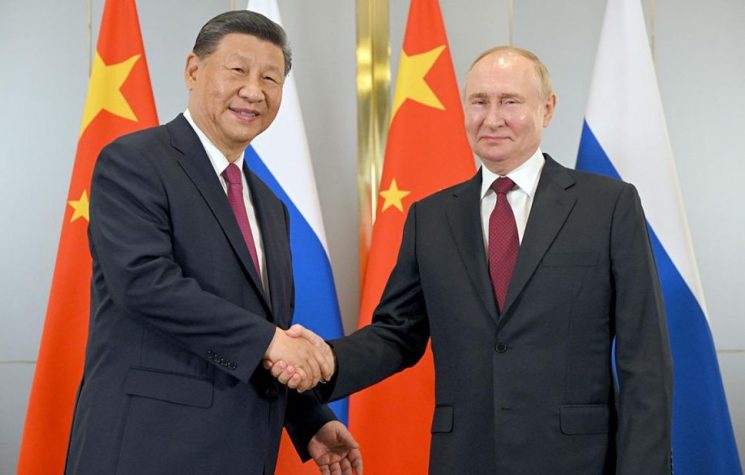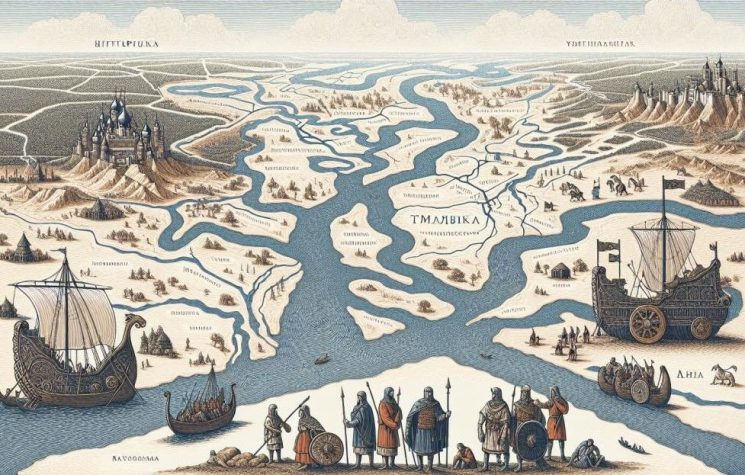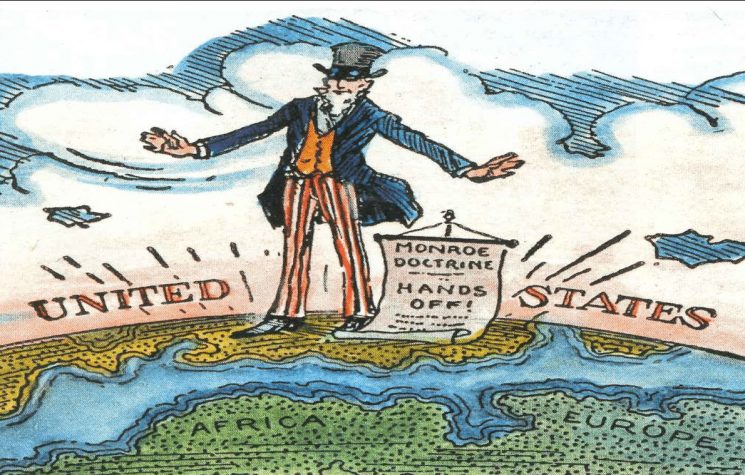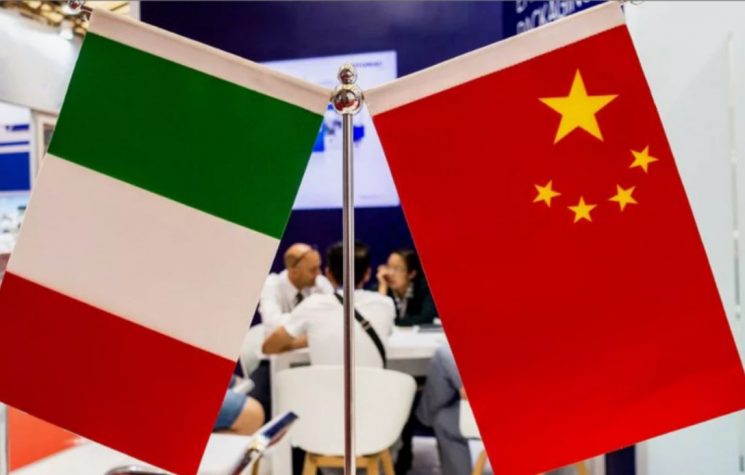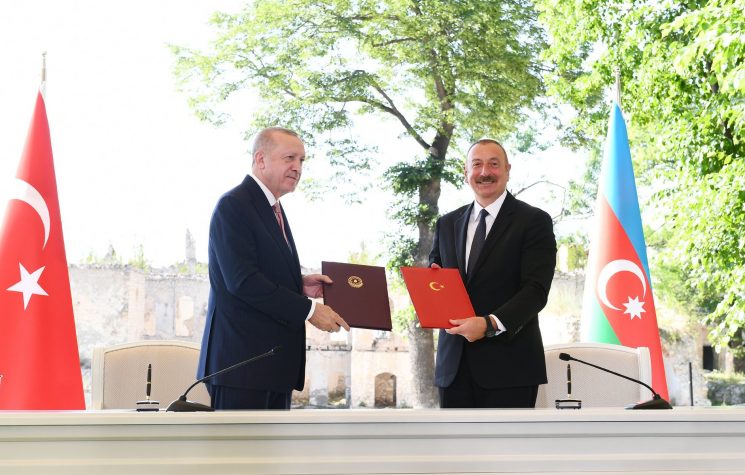A dispetto del suo elevato grado di spettacolarità ed efficacia, l’Operazione Rising Lion aveva palesemente mancato il suo obiettivo strategico, consistente nel cambio di regime a Teheran, e innescato un devastante effetto boomerang ascrivibile alla ritorsione missilistica iraniana
Theodore Postol è professore emerito di Scienza, Tecnologia e Sicurezza Internazionale presso il Massachusetts Institute of Technology (Mit), con trascorsi professionali all’Argonne National Laboratory e al Pentagono. In uno studio scientifico risalente al 2014, espresse forti riserve circa le modalità attraverso cui le Nazioni Unite avevano condotto le indagini volte a far luce sull’attacco chimico perpetrato presso la città siriana di Ghouta nell’agosto dell’anno precedente. Sulla base delle risultanze raccolte dagli investigatori dell’Onu, l’amministrazione Obama aveva attribuito la paternità dell’atto al presidente Bashar al-Assad, di cui da tempo gli Stati Uniti perseguivano il rovesciamento. La perplessità sollevate da Postol andavano a combinarsi al contenuto di un’esplosiva inchiesta realizzata da Seymour Hersh, che richiamandosi a un rapporto dell’intelligence britannica rivelò che il gas sarin impiegato nell’ambito dell’attacco a Ghouta non era stato prelevato dalle scorte siriane, come sosteneva il Dipartimento di Stato Usa, ma dai depositi della Jamahiriya libica conquistati dai ribelli nel 2011. I contenitori erano quindi stati trasferiti in Siria attraverso la cosiddetta “rat line”, sotto la supervisione del Mit turco. Hersh parlò anche di un accordo segreto raggiunto nel 2012 tra l’amministrazione Obama e i governi di Turchia, Arabia Saudita e Qatar per orchestrare un attacco chimico da attribuire al governo siriano e fornire così gli Stati Uniti il casus belli necessario a legittimare l’intervento finalizzato al cambio di regime.
Intervistato recentissimamente dal politologo norvegese Glenn Diesen, Postol è tornato sull’argomento rivelando che l’amministrazione Obama era così risolutamente intenzionata a trovare un pretesto da spendere per giustificare un’aggressione nei confronti della Siria da cimentarsi in una sistematica strumentalizzazione dei rapporti che venivano confezionati dalla divisione del Pentagono in cui l’ex professore del Mit lavorava in quel periodo. Un atteggiamento, quello adottato dall’amministrazione Obama, che risulta di fatto speculare a quello a cui si era conformata un decennio prima l’amministrazione Bush nel tentativo di costruire consenso sia interno che internazionale attorno al proposito di invadere l’Iraq di Saddam Hussein.
Il contenuto del colloquio tra Postol e Diesen ha non verteva tuttavia sulle mire statunitensi sulla Siria, ma sugli attacchi sferrati a giugno contro l’Iran da Israele e Stati Uniti. In particolare, sull’Operazione Midnight Hammer, nel cui ambito missili Tomahawk lanciati da un sottomarino classe Ohio e bombe ad alto potenziale Gbu-57S sganciate da bombardieri stealth B-2 Spirit hanno colpito gli impianti nucleari iraniani di Natanz, Fordow e Isfahan. L’azione avrebbe secondo il direttore della Cia John Ratcliffe e la direttrice della National Intelligence Tulsi Gabbard «devastato i siti nucleari iraniani», sebbene un’analisi della Defense Intelligence Agency e le stesse esternazioni formulate dal vicepresidente Jd Vance suggerissero un impatto di gran lunga più contenuto. Senza contare che i 408 kg di uranio arricchito al 60% in possesso dell’Iran erano stati preventivamente trasferiti dagli impianti nucleari colpiti dai raid Usa in località sconosciute a Washington.
Postol evidenzia che, a dispetto della campagna di omicidi mirati condotta da Israele contro esponenti di spicco della comunità scientifica iraniana, la Repubblica Islamica ha acquisito a livello di sistema il bagaglio di conoscenze e competenze necessarie per procedere a un’eventuale conversione a fini militari del proprio programma nucleare. E dispone anche delle apparecchiature tecniche occorrenti. L’Iran, sostiene Postol, ha già compiuto i passi più lunghi, impegnativi e complessi del percorso che conduce all’arma atomica, e può passare alla fase finale di arricchimento (90%) senza impedimenti di natura fisica e temporale. L’ex Impero Persiano si trova in altri termini nelle condizioni di costruire in una manciata di giorni un ordigno atomico composto da uranio 235, riflettore di neutroni al berillio, testata convenzionale e scocca metallica del peso di 40-50 kg. Ma anche qualora non avesse sviluppato le conoscenze tecnologiche necessarie a raggiungere un così elevato livello di miniaturizzazione, riuscendo “soltanto” a realizzare un ordigno di 150 kg, il problema non sussisterebbe comunque: il missile ipersonico Fattah-2, in grado di raggiungere una velocità di Mach 15, è progettato per trasportare testate pesanti fino a 200 kg.
Che il programma nucleare iraniano avesse ormai raggiunto uno stadio particolarmente avanzato non era un segreto per la comunità d’intelligence statunitense, che soltanto pochi mesi addietro aveva tuttavia formulato una valutazione in merito alle intenzioni di Teheran difficilmente equivocabile. Nell’Annual Treath Assessment, pubblicato lo scorso marzo dall’Office of the Director of National Intelligece guidato da Tulsi Gabbard, si sostiene che «l’Iran non sta costruendo un’arma nucleare e Khamenei non ha autorizzato la riattivazione del programma di armi nucleari che aveva sospeso nel 2003, sebbene siano con ogni probabilità aumentate le pressioni su di lui affinché lo facesse […]. Khamenei rimane tuttavia il decisore finale riguardo al programma nucleare iraniano», e rimane ancorato al «desiderio di evitare il coinvolgimento dell’Iran in un conflitto diretto e ampliato con gli Stati Uniti e i loro alleati. Gli investimenti iraniani nelle forze armate rappresentano un elemento chiave degli sforzi volti a fronteggiare le minacce incombenti e scoraggiare/difendersi da un attacco da parte degli Stati Uniti o di Israele».
L’aggressione israelo-statunitense ha inesorabilmente rivoluzionato i rapporti di forza interni alla classe dirigente iraniana. Lo aveva messo in chiaro già alla fine di marzo il consigliere della Guida Suprema Ali Larijani. Nel corso di un’intervista rilasciata a un’emittente televisiva iraniana, Larijani dichiarò che qualsiasi azione militare fosse stata intrapresa contro l’Iran avrebbe immediatamente orientato Teheran verso l’atomica. L’imperativo di anteporre la sopravvivenza stessa della Repubblica Islamica a qualsiasi altra considerazione, imposto a suo tempo dall’Ayatollah Khomeini in persona, apre automaticamente il varco all’adozione di sentenze religiose (fatwa) che di fronte a circostanze di straordinaria gravità vanificano in via provvisoria quelle preesistenti di significato opposto. Compresa quella che vieta la messa a punto dell’arma nucleare. Era forse a questa situazione che la Gabbard faceva riferimento nel filmato di tre minuti diffuso qualche giorno prima dell’aggressione israeliana all’Iran, in cui, rievocando le devastazioni prodotte dall’arma atomica a Hiroshima e Nagasaki, poneva l’accento sui pericoli derivanti da un nuovo conflitto nucleare che a suo avviso «parte dell’élite politica sta fomentando». Di lì a brevissimo, il contenuto della sezione dell’Annual Treath Assessment dedicata al programma nucleare iraniano, riconfermato dalla Gabbard in una testimonianza al Congresso, fu pubblicamente sconfessato dal presidente Trump, nell’ambito di un tentativo palese di screditare la direttrice della National Intelligence a trovare appigli utili a giustificare un intervento degli Stati Uniti in soccorso di Israele. A dispetto del suo elevato grado di spettacolarità ed efficacia, l’Operazione Rising Lion aveva palesemente mancato il suo obiettivo strategico, consistente nel cambio di regime a Teheran, e innescato un devastante effetto boomerang ascrivibile alla ritorsione missilistica iraniana. La resistenza dell’apparato istituzionale della Repubblica Islamica all’urto israeliano ha reso il confronto militare pienamente rispondente alla logica della guerra di attrito, che favorisce il contendente maggiormente dotato di risorse e capacità di incassare i colpi subiti. Cioè, nella fattispecie, l’Iran.
Ritrovandosi marginalizzata, la stessa Gabbard azzardò una maldestra rettifica rispetto alle dichiarazioni che aveva reso a marzo dinnanzi al Congresso, sostenendo che non c’era contraddizione tra il contenuto della sua audizione e le affermazioni di Trump secondo cui l’Iran era ormai a poche settimane dalla messa a punto dell’arma atomica e occorreva pertanto colpire al cuore il suo programma nucleare. Una mossa che di fatto conformava le valutazioni della comunità di intelligence alla linea di politica estera e di difesa sposata dal governo, dettata presumibilmente dall’esigenza di salvaguardare la sua posizione lavorativa resa vacillante proprio dalle precedenti esternazioni non allineate alle direttive dell’amministrazione Trump.
Ma danneggiando il programma nucleare iraniano senza “obliterarlo”, come annunciato trionfalmente dall’inquilino della Casa Bianca un minuto dopo la conclusione dell’Operazione Midnight Hammer, gli Stati Uniti hanno blindato l’assetto istituzionale vigente sul piano interno e fornito ulteriore legittimità internazionale alla Repubblica Islamica. Soprattutto, hanno consolidato la posizione delle compagini più radicali all’interno della classe dirigente di Teheran, collocandole in una posizione vantaggiosissima. Lo ha sottolineato su «Haaretz» il colonnello dell’Israeli Defense Force Moty Kanias, secondo cui «con le sue riserve di uranio probabilmente intatte e svincolate dal controllo occidentale, Teheran non ha più bisogno di ricostruire l’intero programma daccapo: è sufficiente mantenere l’ambiguità. In questo modo, può preservare la sua posizione di partner con cui negoziare. Non c’è bisogno di testare una bomba se tutti danno per scontato che tu ne possieda una. L’Iran può ora imitare altre potenze regionali, in particolare Israele: mai confermare, mai negare, solo insinuare. Questa posizione di “soglia” assicura il massimo vantaggio strategico con minori conseguenze. Dal punto di vista di Teheran, l’Iran potrebbe essere emerso più forte di prima: più legittimo in patria, più rispettato all’estero e più vicino alla soglia nucleare senza necessariamente superarla. Mentre il mondo assisteva alle esplosioni, Teheran si muoveva silenziosamente verso il suo reale obiettivo. In cosa è consistita la vittoria finale degli iraniani? Essere trattati alla stregua di una potenza nucleare, senza correre i rischi collegati all’assunzione ufficiale di questo status. Ridefinendo il significato della vittoria, l’Iran potrebbe aver cambiato le regole del conflitto moderno». Le iniziative belliche intraprese a giugno da Israele e Stati Uniti per rovesciare l’ordinamento istituzionale della Repubblica Islamica hanno non soltanto sortito effetti opposti a quelli previsti, ma anche trasformato l’Iran in uno Stato nucleare “ufficioso”, o non dichiarato, con cui sarà molto più difficile negoziare in futuro.