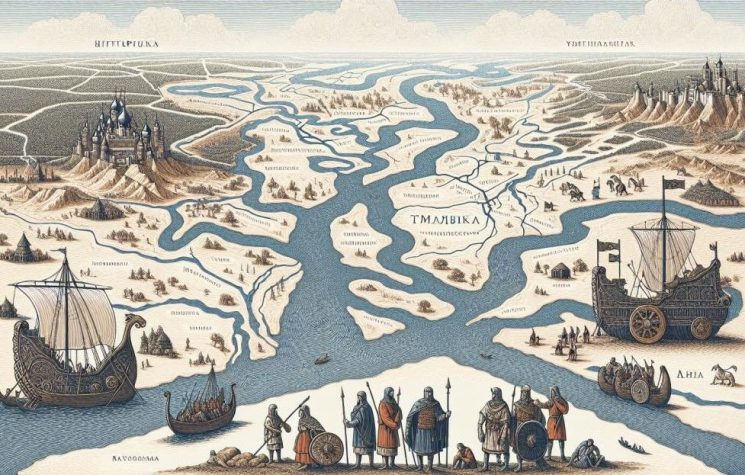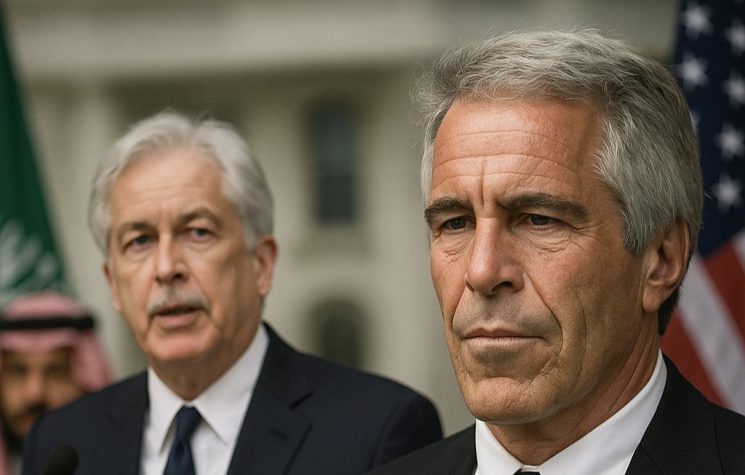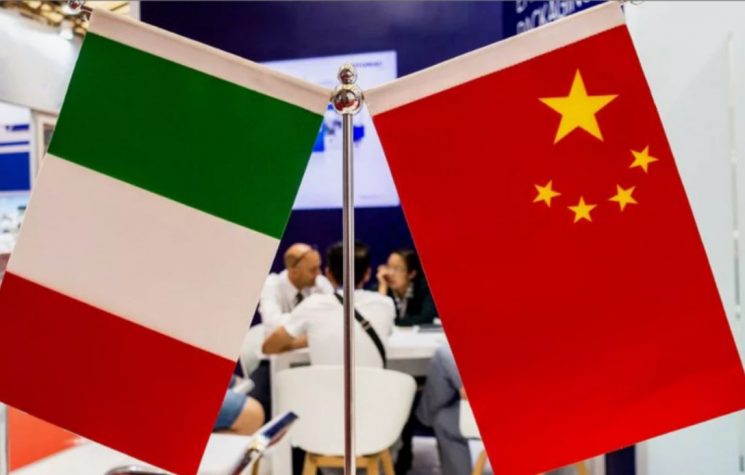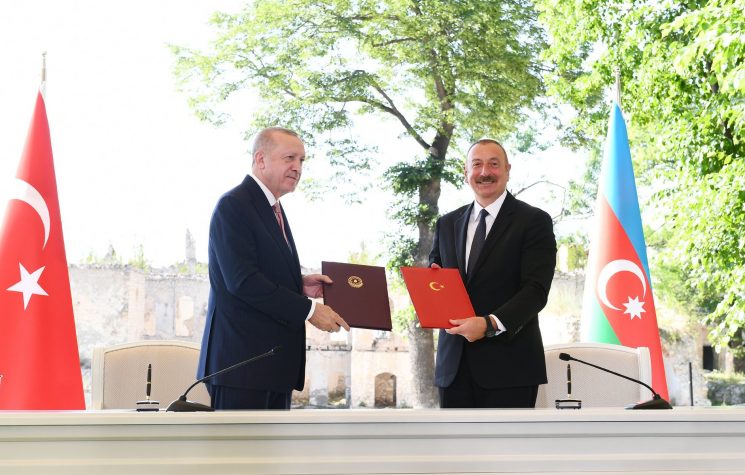Il Pakistan, come osservato nel corso dell’ultima guerra tra Iran e Israele e nel precedente conflitto con l’India rimane un Paese centrale nello scacchiere eurasiatico e fondamentale per l’evoluzione dell’ordine globale verso il multipolarismo. Qui verranno analizzate le sue principali direttrici geopolitiche
Il 22 agosto 2018, in una conferenza tenuta presso il Ron Paul Institute, il colonnello in pensione Lawrence Wilkerson (già capo staff del tristemente noto ex Segretario di Stato nordamericano Colin Powell) dichiarò quanto segue: “Siamo in Afghanistan per lo stesso motivo per cui eravamo in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. Vogliamo essere il più vicini possibile alla BRI (Belt and Road Initiative). Se dobbiamo colpire con la nostra potenza militare possiamo farlo dall’Afghanistan. La seconda ragione è poter stabilizzare la potenza nucleare del Pakistan. La terza ragione è che se la CIA deve montare un’operazione come fatto tramite Erdogan contro Assad, il modo migliore sarebbe fomentare gli Uiguri attraverso l’Afghanistan”.
A distanza di quasi sette anni da questa dichiarazione, è possibile chiedersi, visto il “ritiro” del contingente nordamericano e NATO dall’Afghanistan, se la strategia degli Stati Uniti sia cambiata? La risposta è stata fornita a suo tempo da un articolo apparso sul New York Times nel quale il Generale Austin S. Miller (capo della coalizione guidata dagli Stati Uniti in Afghanistan) ha affermato che ad una presenza “dichiarata” di truppe farà seguito una presenza silenziosa e poco visibile fondata sul coordinamento operativo tra forze speciali e forze mercenarie sotto l’ombrello della CIA.
Questa presenza “mascherata”, nei piani del Pentagono, dovrebbe essere accompagnata da un accrescimento della presenza militare nordamericana nei dintorni dell’Afghanistan, dall’Asia centrale a quella meridionale, col preciso scopo di mantenere sotto controllo l’espansione cinese ed ogni potenziale progetto di cooperazione regionale rivolto a ridurre l’influenza nordamericana nell’area. Tuttavia, l’ex Ministro degli Esteri pakistano Shah Mehmood Qureshi, sulle colonne del quotidiano Pakistan Today, assicurando comunque l’appoggio alle manovre di ritiro, ha annunciato il rifiuto di Islamabad a concedere (nuovamente) le proprie basi all’esercito statunitense, asserendo inoltre (con inusuale schiettezza) che ci sono delle forze che non sono affatto interessate alla stabilizzazione e pacificazione dell’Afghanistan.
La scelta pakistana di allora (che ha dovuto comunque fare i conti con le correnti pro-USA interne; si pensi all’estromissione dal potere di Imran Khan, legata anche alla sua aperta posizione filorussa dopo l’intervento diretto di Mosca nel conflitto civile ucraino), di fatto, si poneva in netto contrasto rispetto ad alcuni decenni in cui (sebbene in modo alternato) Islamabad ha agito come il principale strumento per il perseguimento degli interessi geopolitici nordamericani nella regione.
Quando nel 1977, dopo la defenestrazione di Zulfiqar Ali Bhutto (autore del manifesto geopolitico pakistano “Il mito dell’indipendenza”), salì al potere il Generale Zia ul-Haq, il Pakistan divenne una sorta di Stato “paria”. Questi, nel 1978, riproponendo una formula che nello stile si avvicina non poco a certe affermazioni (ispirate dal puritanesimo) di alcuni presidenti nordamericani, dichiarò: “Ho una missione che mi ha dato Dio, la missione di portare l’ordine islamico in Pakistan”.
Spietato e vendicativo quanto schivo e realmente devoto, le impressioni occidentali nei confronti di Zia cambiarono rapidamente a partire dal 1979 quando, a seguito dell’intervento sovietico in Afghanistan, divenne il principale “alleato” degli Stati Uniti.
Ora, prima di andare ulteriormente avanti, è bene sottolineare che, sul finire degli anni ’70, i principali problemi strutturali che ancora oggi affliggono il Pakistan si erano già palesati in modo evidente.
Esistono storicamente tre relazioni fondamentali (e interconnesse tra loro) che hanno dominato l’evoluzione del Pakistan: quella tra esercito e società civile; quella tra Islam e Stato; quella tra esercito e Islam. La politica pakistana, inoltre, si è sviluppata sin dal principio seguendo due direttrici fondamentali: il paternalismo e la repressione. Questo costituisce in tutto e per tutto un’eredità diretta del Raj Britannico che nei territori dell’odierno Pakistan aveva consolidato il suo sistema di potere da un lato attraverso l’alleanza con la classe dei ricchi possidenti terrieri (a cui, ancora oggi, appartiene larga parte della classe politica e di cui faceva parte lo stesso Bhutto) e, dall’altro, reclutando in maggioranza sudditi di etnia punjabi tra le fila dell’esercito. A ciò si aggiunga la profonda crisi d’identità generata dallo stesso dominio coloniale britannico che portò i musulmani, un tempo sovrani dell’India, a ritrovarsi parte di uno Stato “occidentalizzato” nel quale erano guardati con malcelato sospetto. I Britannici, infatti, anche in virtù delle numerose ribellioni e manifestazioni di resistenza musulmane, non nascosero mai il loro sostanziale favore per la componente indù della popolazione.
Una volta creato il Pakistan, il Punjab (provincia più grande e popolosa) ha fornito il grosso della burocrazia e delle forze armate generando latente malcontento e forme di nazionalismo etnico a più riprese sfruttato anche da forze esterne al Paese (si pensi, oltre alla creazione del Bangladesh, alle insurrezioni in Belucistan – talvolta eterodirette e sostenute dall’esterno – del 1948, 1958-59, 1962-63, 1973-77, 2002, cui si aggiunge quella attuale arrivata addirittura ad una dichiarazione unilaterale di indipendenza).
Paradossalmente, la guerra per procura all’Unione Sovietica in Afghanistan ha consentito al Pakistan di congelare temporaneamente tensioni etniche e sociali interne attraverso il sostanzioso programma d’aiuti provenienti dall’“Occidente” allargato. Ed il periodo di undici anni nel corso dei quali Zia ul-Haq è rimasto al potere ha lasciato un effetto duraturo che si continua a percepire anche nell’attualità. Di fatto, nel corso di questo periodo, oltre al processo di forzata islamizzazione in stile wahhabita, grazie alla CIA, l’Inter-Services Intelligence (ISI) è stato trasformato in una formidabile agenzia di intelligence in grado non solo di gestire il conflitto afghano cercando in incanalarlo secondo i propri desideri (e quelli degli “alleati”) ma anche di determinare in modo decisivo il processo politico interno dello stesso Pakistan.
In linea teorica, l’azione pakistana in Afghanistan aveva delle sue ragioni geopolitiche che andavano oltre la mera funzione di contenimento/indebolimento dell’espansione sovietica che ad essa avevano attribuito gli Stati Uniti.
I rapporti tra Pakistan e Afghanistan sono sempre stati piuttosto complessi. Nel corso degli anni ci sono state diverse rivendicazioni afghane su alcuni territori del Belucistan e della NWFP – North Western Frontier Province. Tra il 1955 ed il 1962 le relazioni tra i due Paesi si guastarono quando Kabul sostenne il progetto del “Grande Pashtunistan”: ovvero, la creazione di un grande Stato Pashtun che inglobasse, oltre all’Afghanistan, i territori abitati da questa etnia in Pakistan.
Negli anni ’80, Zia si autoconvinse che il sostegno pakistano al gihad antisovietico avrebbe posto fine a questo tipo di rivendicazioni installando a Kabul un governo Pashtun, islamista e fedele ad Islamabad. Ciò, inoltre, avrebbe garantito al Pakistan una profondità strategica che la sua conformazione geografica allungata, e priva di quella che in termini geopolitici viene definita come “riva” (un confine difficilmente superabile), non poteva assicurare in caso di una prolungata guerra con l’India.
Questo aspetto è di notevole importanza perché ad esso si lega anche il successivo sostegno pakistano ai Talebani che si cercherà di esaminare in seguito. Al momento, sarà utile ricordare che Zia, oltre a queste considerazioni di natura geopolitica, si fece guidare anche da alcune (neanche troppo velate) aspirazioni personali. Alla pari di un imperatore turco-mongolo, infatti, aveva sognato di ricreare un grande spazio islamico sunnita tra l’infedele Indostan, l’“eretico” Iran e la Russia cristiana. Era convinto che il messaggio dei mujaheddin afghani si sarebbe diffuso in tutta l’Asia centrale creando un blocco geopolitico di Nazioni musulmane guidato dal Pakistan che, così facendo, avrebbe finalmente ottemperato al suo compito storico-ideologico.
Sulla base di queste convinzioni, dopo aver rifiutato un (troppo ridotto) aiuto di 400 milioni di dollari da parte dell’amministrazione Carter nel 1980, accettò un piano quinquennale (1981-1986) di aiuti da 3.2 miliardi (che includeva anche l’invio di 40 caccia F-16) avanzato dall’amministrazione Reagan ed al quale si sarebbe dovuto aggiungere un nuovo piano da 4.02 miliardi per il periodo 1987-1993 (sebbene quest’ultimo non venne mai completato).
A partire dai primi anni ’80, il Pakistan, alla pari della Turchia nel più recente scenario siriano, divenne una vera e propria autostrada per i miliziani islamisti sostenuti dall’“Occidente”. In questo periodo, più di 35.000 miliziani arrivarono in Pakistan da diverse parti del mondo islamico attraverso canali di reclutamento, più o meno direttamente collegati alla CIA, per entrare in Afghanistan. Dal 1982, i mujaheddin afghani iniziarono a ricevere puntualmente 600 milioni di dollari all’anno degli Stati Uniti ed altri 600 dalle monarchie del Golfo Persico (Arabia Saudita in testa) che utilizzarono questo flusso di denaro anche per promuovere il wahhabismo all’infuori della Penisola Arabica. Tra il 1982 ed il 1988, vennero costruite in Pakistan oltre mille nuove scuole coraniche (madrasa) finanziate dai soldi wahhabiti provocando un vero e proprio fenomeno sradicante nei confronti della cultura islamica tradizionale dell’Asia centrale e meridionale. Nello stesso periodo, le università nordamericane sostennero apertamente la “cultura del gihad” finanziando la stampa di testi scolastici nelle lingue locali per indottrinare i giovani pakistani ed i profughi afghani (oltre 3 milioni) che avevano superato la Linea Durand. Nel 1985, Ronald Reagan arrivò addirittura al punto di definire i mujaheddin come l’equivalente morale dei Padri fondatori degli Stati Uniti nel corso di una visita di alcuni di loro alla Casa Bianca. Tra questi c’era pure Gulbuddin Hekmatyar, capo politico del Partito e gruppo paramilitare Hezb-e-Islami, che avrà un ruolo chiave negli sviluppi del conflitto afghano.
Il Pakistan, in questo periodo, conobbe una crescita del PIL che si attestò intorno al 6% annuo. Tuttavia, il costante flusso di denaro venne utilizzato non per investimenti nelle infrastrutture, nella sanità pubblica o nell’educazione dei giovani, ma per alimentare un vasto sistema clientelare e di corruzione. Alla pari di quanto avverrà con la “guerra al terrore” dei primi anni 2000, il denaro terminò nelle mani dei soliti noti (politici corrotti, burocrazia inefficiente, servizi segreti, gruppi estremisti di varia natura, organizzazioni criminali legate al contrabbando) che da quel momento in poi continuarono a fare affidamento sugli aiuti internazionali per mantenere inalterato il loro status privilegiato. Tuttavia, questo “idillio” tra USA e Pakistan non durò molto. Gli obiettivi iniziarono presto a divergere. A Washington, infatti, non piaceva l’idea pakistana di insediare a Kabul Hekmatyar ed il progetto geopolitico di Zia, la cui morte, avvenuta in un incidente aereo, rimane ancora oggi avvolta nel mistero. In fondo, non sarebbe la prima volta che gli Stati Uniti, dopo averlo ampiamente utilizzato, si liberano di un alleato divenuto troppo scomodo (la vicenda di Osama Bin Laden e dell’alleanza a corrente alternata con al-Qaeda, creata proprio nel contesto del conflitto afghano, è lì a dimostrarlo – sebbene oggi, in Siria, si stia assistendo ad un nuovo idillio tra i due). A ciò si aggiunga che proprio sul finire degli anni ’80, con l’evidente malcontento di Washington (sempre pronta a soprassedere alla tutela della “democrazia” quando si tratta del proprio tornaconto e mai quando altri attori agiscono nel rispetto dei loro interessi), iniziarono a circolare voci sullo sviluppo clandestino (tramite aiuto cinese, saudita e libico) di armi nucleari da parte del Pakistan. Una notizia priva di conferme ufficiali ma che troverebbe riscontro nella natura dualistica dello stesso servizio segreto pakistano, storicamente animato da due correnti: una filo-americana ed una filo-cinese. A questo proposito è bene ricordare che Israele, dopo l’operazione Babilonia con la quale bombardò i siti nucleari iracheni, pensò anche ad eventuale attaccò contro il Pakistan, saltato a causa delle enormi difficoltà logistiche. Ad ogni modo, considerato il notevole flusso di armi verso l’Afghanistan proveniente dagli arsenali israeliani (in larga parte armi sovietiche sequestrate agli eserciti siriano ed egiziano nel corso dei conflitti del 1967 e 1973), il Pakistan riuscì a trovare un accordo con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare: Washington diede il proprio benestare in cambio della promessa che la bomba non venisse mai utilizzata contro Israele ma solo come forma di deterrenza verso l’India.
Ora, tornando al discorso prettamente geopolitico, bisogna sottolineare che lo spazio geografico dell’Asia centrale ha avuto un ruolo di primo piano in tutte le principali teorie (e strategie) geopolitiche del Novecento. Tra queste, indubbiamente, spiccano le teorie “continentaliste” (sebbene su versanti opposti) dell’inglese Sir Halford J. Mackinder (1861-1947) e del tedesco Karl Haushofer (1869-1946), così come la dottrina russa eurasista.
Secondo il loro approccio, per lo più lungo l’asse Est-Ovest, confliggono due centri di potere mondiale: uno continentale ed uno marittimo (talassocratico). Per Mackinder, che enuncia la sua tesi nel 1904, esiste una gigantesca fortezza naturale, inaccessibile al potere marittimo, che si estende dall’Asia centrale all’Artico e dalla quale, nel corso dei secoli, hanno avuto origine diverse invasioni (Unni, Mongoli, Turchi) che hanno interessato l’intero spazio eurasiatico (dall’Europa all’Estremo Oriente). Il dominio di questa regione, che Mackinder chiama inizialmente “area perno” (pivot area) e successivamente “heartland” (con il senso di “cuore del mondo”), garantirebbe il dominio dell’intera massa continentale eurasiatica e, di conseguenza, del mondo. Afferma Mackinder: “Chi controlla l’Europa orientale controlla l’heartland; chi controlla l’heartland controlla l’isola mondo (l’Eurasia); e chi controlla l’isola mondo controlla il mondo”. Per controllare l’Eurasia, bisogna dunque impedirne l’unità continentale in ogni sua forma. E, non a caso, per l’intero XIX secolo, l’Asia centrale fu sottoposta al gioco di spie tra Gran Bretagna e Russia zarista, con la prima fermamente decisa ad impedire a Mosca l’accesso ai mari caldi dell’Oceano Indiano.
Karl Haushofer, a sua volta, riprende le vedute di Mackinder circa l’importanza fondamentale dell’Europa centro-orientale, ma ne rovescia le conclusioni politiche, poiché difende l’idea di un’alleanza russo-tedesca, un Kontinentalblock eurasiatico.
Alle teorie di Mackinder e Haushofer si contrappongono quelle sul dominio marittimo dell’ammiraglio nordamericano Alfred T. Mahan (1840-1914) e di Nicholas J. Spykman. Entrambe, tuttavia, attribuiscono ancora una volta un ruolo centrale allo spazio dell’Asia centrale visto che sia Mahan che Spykman, in modo quasi profetico, identificavano nella Cina una potenziale minaccia all’egemonia globale nordamericana anche maggiore rispetto al Giappone (Mahan) ed all’URSS (Spykman). Proprio Spykman risulta essere il principale esponente di quella scuola “marginalista” che tanta fortuna ha conosciuto tra gli strateghi nordamericani.
Il suo pensiero è puramente determinista. Secondo Spykman la geografia è l’elemento più importante nella politica estera degli Stati (dalla geografia scaturiscono lotte egemoniche che si perpetuano nella storia). “I ministri vanno e vengono – affermava Spykman – i mari, i fiumi e le catene montuose restano lì dove sono”. Le preoccupazioni dello zar Alessandro I e di Stalin per un accesso ai mari caldi, ad esempio, erano le medesime. Secondo Spykman, inoltre, il miglioramento della propria posizione di potenza è (o dovrebbe essere) l’obiettivo della politica interna ed estera di ogni Stato.
Nella prospettiva del teorico nordamericano, tuttavia, non è il controllo dell’heartland a determinare l’egemonia globale ma il controllo sul “territorio marginale” (il rimland): ovvero, la fascia peninsulare e insulare che circonda la fascia costiera eurasiatica. La difesa degli interessi statunitensi comporta necessariamente il controllo di quest’area e la sua frammentazione, perché la sua unificazione sarebbe disastrosa per gli Stati Uniti. Perciò, alla formula continentalista di Mackinder, Spykman contrappone la formula del potere peninsulare: “Chi controlla il rimland domina l’Eurasia; chi domina l’Eurasia controlla i destini del mondo”.
Sulla base delle teorie di Spykman appare evidente sia la ragione per cui gli Stati Uniti, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, si siano concentrati, oltre che sul Vicino e Medio Oriente, sulla ricerca di una forma di controllo della fascia costiera dell’Asia meridionale (dove il porti pakistani di Karachi e Gwadar hanno un valore strategico non di poco conto) e sudorientale; sia la ragione per cui il Pakistan non ha mai rinunciato (geopoliticamente e ideologicamente) alla ricerca della propria profondità strategica su entrambi i lati dei suoi confini: in Afghanistan e nel Kashmir occupato dall’India.
Alla pari dell’“ossessione” russa per la ricerca di uno sbocco sui mari caldi, la geopolitica pakistana, a prescindere da chi sia al potere, non potrà mai rinunciare al tentativo di esercitare la propria influenza sull’Afghanistan, di liberare il Kashmir (al centro di innumerevoli fasi di conflitto con l’India) – da sottolineare anche il fatto che spesso la causa del Kashmir viene associata dai vertici politici e militari pakistani a quella palestinese (ragione alla base del rifiuto di normalizzare i rapporti con Israele) – e, da “potenza tellurica” in nuce, di incrementare la propria interconnessione con l’Asia centrale. Oggi, inoltre, considerata la centralità di entrambi i Paesi all’interno del progetto infrastrutturale di interconnessione eurasiatica della Nuova Via della Seta, il Pakistan non può permettersi una destabilizzazione del vicino Iran o la caduta vera e propria della Repubblica Islamica, visti i notevoli interessi economici e di sicurezza condivisi (soprattutto per ciò che concerne il contenimento dei movimenti terroristi, sostenuti da India e Occidente, nel Belucistan). Questi, non a caso, prendono costantemente di mira il CPEC: il Corridoio Economico Sino-Pakistano, centrale per lo sviluppo dell’intero sistema Paese e fondamentale per le catene di approvvigionamento energetico cinesi e per bypassare il rischioso Stretto di Malacca.
Di fatto, una delle principali motivazioni che portarono Pervez Musharraf alla totale capitolazione nei confronti degli USA dopo l’11 settembre 2001 fu proprio il rischio di vedere vanificati sia gli sforzi compiuti nel Kashmir, sia l’ulteriore sviluppo del programma e delle installazioni nucleari pakistane. Il timore di Musharraf, in un contesto storico in cui le lobby indiane non persero tempo a presentare il Pakistan come uno “Stato sostenitore del terrorismo”, era quello di dover affrontare una sconfitta geopolitica della medesima portata (o forse addirittura peggiore) rispetto a quella subita nel 1971: un trauma nazionale che determinò la separazione della parte orientale del Paese. Per comprendere meglio la “mentalità” che ha portato alla resa di Musharraf ai voleri USA si rende necessario un piccolo passo indietro.
Il 28 maggio 1998 il Pakistan era divenuto a tutti gli effetti una potenza nucleare dopo aver effettuato sei test a seguito di quelli realizzati da Nuova Delhi. L’Occidente rispose imponendo pesanti sanzioni che misero ulteriormente in crisi un’economia già profondamente depressa almeno dal 1996.
Il 28 giugno 1998, nonostante la crisi, il Ministero delle Finanze annunciò comunque il pagamento di 300 milioni di rupie (6 milioni di dollari) a favore dell’amministrazione talebana di Kabul. Tra il 1997 ed il 1998 il Pakistan fornì ai Talebani aiuti per 30 milioni di dollari.
Il sostegno del Pakistan al Movimento degli studenti coranici risale al secondo mandato di Benazir Bhutto come Primo Ministro (1993-1996). Questa aveva già avuto modo di governare dal 1988 al 1990 quando, dopo la morte di Zia e grazie alla mediazione degli Stati Uniti, era riuscita a trovare un compromesso con i militari attraverso l’assicurazione che non avrebbe intaccato il bilancio della difesa e avrebbe lasciato a loro la gestione della politica estera. Dopo pesanti accuse di corruzione (rivolte soprattutto al marito Asif Ali Zardari che sfruttò non poco la posizione della moglie) fu costretta a lasciare il governo nel 1990. Tuttavia, per l’intero decennio successivo, la politica interna pakistana venne trasformata in una sorta di faida tra la famiglia Bhutto e quella di Nawaz Sharif (altro personaggio non estraneo all’utilizzo della “cosa pubblica” per la salvaguardia dei propri interessi privati: l’attuale Primo Ministro è il fratello Shahbaz Sharif).
Questo periodo di tempo coincide anche con alcuni eventi geopolitici di notevole rilievo: in primo luogo, la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Se la strategia USA negli anni ’80 si era concentrata sulla creazione di una sorta di “cintura verde” (governi a trazione islamista-fondamentalista) ai confini meridionali dell’URSS, dalla metà degli anni ’90 in poi, questa (anche in virtù delle teorie dell’ex Consigliere Nazionale alla Difesa dell’amministrazione Carter Zbigniew Brzezinski) si concentrò principalmente verso il controllo (più o meno diretto) dell’Asia centrale. Non a caso, tra il 1998-99, alcune Repubbliche ex-sovietiche della regione conobbero un incremento delle attività terroristiche (ad esempio, la formazione del Movimento Islamico dell’Uzbekistan che si stazionò nella strategica Valle del Fergana) che le porterà, volenti o nolenti, a dover accettare la presenza di basi USA sul proprio territorio.
Più o meno nel medesimo spazio temporale, l’Afghanistan, dopo aver esaurito il compito di mettere in crisi il potere sovietico, sprofondò in una sorta di buco nero in cui signori della guerra e della droga si spartirono il potere (spesso anche scontrandosi gli uni con gli altri) gestendolo anche a discapito e sulla pelle della popolazione civile.
L’iniziale successo e consenso riscosso dai Talebani fu legato proprio al desiderio popolare di ordine, giustizia e stabilità contro i soprusi dei signori della guerra. Il Pakistan iniziò a promuovere la causa talebana a partire dal 1993 ed in questo ebbe un ruolo di primo piano il Generale Naserullah Babar. Islamabad, a partire da questa data, iniziò progressivamente a ridurre il sostegno fin lì accordato a Hekmatyar (incapace di compiere la missione che l’ISI gli aveva affidato) ed a foraggiare il Movimento guidato dal Mullah Omar. L’obiettivo, ancora una volta, era quello di stabilizzare l’Afghanistan dandogli un governo filo-pakistano anche nella prospettiva di costruire una rotta commerciale diretta verso l’Asia centrale. Gli sforzi pakistani in questo senso si intensificarono dal 1995: l’anno in cui i Talebani conquistarono Herat.
Tuttavia, i Talebani si dimostrarono ben presto molto più “autonomi” di quanto lo stesso ISI potesse credere ed estremamente connessi con il tessuto economico e socio-politico del Pakistan. Questi, infatti, in molti casi possedevano documenti pakistani; avevano studiato ed erano stati addestrati in Pakistan; avevano già collegamenti profondi con Partiti politici islamisti pakistani e con gruppi criminali legati al contrabbando.
Che il contrabbando abbia storicamente rappresentato un grave problema per il Pakistan non è di certo una novità. Lo zelo con il quale il Paese dell’Asia meridionale sta cercando di portare avanti, insieme a Pechino, i progetti della Nuova Via della Seta, nonostante le tensioni ed i tentativi di sabotaggio, è anche legato alla volontà di regolare i traffici da e verso i già citati porti di Gwadar e Karachi.
Il contrabbando che si estende dall’Asia centrale al Golfo Persico, all’Iran ed al Pakistan, rappresenta una grave perdita in termini di entrate per ogni Paese coinvolto. Il Pakistan, vista la particolare posizione geografica e non essendo particolarmente ricco di materie prime, è quello che subisce maggiormente i danni derivati da questi mancati introiti. La sua industria locale, inoltre, è stata a più riprese messa in difficoltà dall’introduzione clandestina di beni di consumo provenienti dall’estero.
La principale fonte di sostegno per il Movimento talebano, prima ancora che l’ISI optasse per l’aperto sostegno, di fatto, era il “pedaggio” pagato dagli autotrasportatori in cambio dell’apertura delle strade afghane al contrabbando. Volendo fare un paragone con eventi più vicini nel tempo, si potrebbe fare nuovamente riferimento a quanto accaduto nello scenario siro-iracheno con il sedicente “Stato Islamico” abile nello sfruttare le rotte verso la Turchia e la porosità dei confini per il contrabbando di greggio e manufatti preziosi. Il giornalista pakistano Ahmed Rashid ha riportato che tra il 1992 ed il 1993 la perdita in entrate doganali per il Pakistan era stata di 3 miliardi di rupie; nel 94-95 è stata di 11 miliardi; nel 97-98 di 30 miliardi. Così ha scritto nel suo studio sulla nascita e sviluppo del fenomeno talebano: “L’economia sommersa in Pakistan sale dai 15 miliardi di rupie del 1973 ai 1115 del 1996 […] Nel corso dello stesso periodo, l’evasione fiscale – compresa l’evasione dei diritti doganali – da 1.5 miliardi di rupie raggiunge il picco di 152 miliardi”.
Questa forma di “evasione” incontrollata e mai del tutto ostacolata, per anni ha contribuito anche ad arricchire svariati gruppi di potere (corrotti) all’interno del Pakistan. Negli anni ’90, inoltre, iniziarono a farsi sentire le ripercussioni della guerra per procura all’Unione Sovietica in Afghanistan. Questa, infatti, aveva creato la cultura dell’eroina, del Kalashnikov e della madrasa wahhabita. In dieci anni di guerra il profilo sociale del Paese era stato profondamente stravolto.
L’ISI, nel suo appoggio ai Talebani, ha cercato di sostituirsi ai gruppi criminali di Quetta legati al contrabbando. Quando i Talebani entrarono a Mazar-i Sharif nel 1998, i capi militari pakistani considerarono questa vittoria come una vittoria pakistana. Essi, inoltre, ritenevano che il governo talebano, a differenza di ogni precedente regime afghano, avrebbe riconosciuto la Linea Durand e tenuto a bada il nazionalismo Pashtun nel NWFP, dando, al contempo, uno sbocco agli islamisti radicali pakistani (dal 1994 al 2001 oltre 80.000 miliziani pakistani combatterono tra le fila dei Talebani) ed impedendo la creazione di un fronte interno antigovernativo.
Tuttavia, si è verificato l’esatto contrario. La vittoria talebana ha virtualmente eliminato un confine (in linea teorica mai esistito) che già da decenni veniva comunque attraversato in entrambe le direzioni. Ma il fallimento totale della strategia pakistana si registra definitivamente a partire dal settembre 2001.
Nel 1999 un colpo di Stato militare rovesciò Nawaz Sharif che dal 1997 aveva reso sempre più esplicito il sostegno ai Talebani. Il colpo di Stato fu l’esito della disastrosa avventura militare nelle alture del Kargil (nel Kashmir occupato dall’India) a seguito della quale venne addirittura paventata l’opzione nucleare. Principale responsabile dell’operazione fu Pervez Musharraf, allora capo delle forze armate. Questo, venuto a sapere dell’intenzione di Sharif di sollevarlo dall’incarico, lo anticipò assumendo la guida del Paese.
Come avvenuto venti anni prima con Zia, Musharraf si trovava in una condizione in cui il Pakistan godeva di una pessima reputazione sul piano internazionale. Una delle principali preoccupazioni per le amministrazioni nordamericane a cavallo del nuovo millennio era proprio quella di stabilire quale tipo di relazioni mantenere con Islamabad. Già Bill Clinton rafforzò notevolmente le relazioni con l’India ed impose sanzioni al regime militare pakistano.
Nel gennaio del 2001, l’ONU aveva imposto pesanti sanzioni all’Emirato dell’Afghanistan (allora riconosciuto solo da Pakistan, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) al preciso scopo di bloccare i rifornimenti in armi che arrivavano proprio dal Pakistan.
L’11 settembre 2001, il generale Mehmood Ahmad, allora a capo dell’ISI, si trovava paradossalmente proprio a New York, a colloquio con i vertici della CIA che lo invitarono a convincere i Talebani a consegnare Osama Bin Laden. Il giorno dopo gli attentati, Mehmood venne ricevuto, insieme a Maleeha Lodhi (allora ambasciatrice pakistana a Washington), dal Vice Segretario di Stato Richard L. Armitage che chiese espressamente ai due quale parte il Pakistan avesse intenzione di sostenere. Mehmood affermò che il Pakistan era sempre stato dalla parte degli Stati Uniti e che, al contrario, era stata Washington a piantare in asso spesso e volentieri il Pakistan.
Di fatto, la politica estera del Pakistan per i successivi dieci anni era già stata decisa. Musharraf venne informato dell’attentato durante una conferenza militare a Karachi. Sapeva che gli “Stati Uniti avrebbero reagito come un orso ferito” e che avrebbero attaccato l’Afghanistan. La sua scelta, la via più semplice, fu stabilire che il Pakistan non avrebbe dovuto opporsi alle richieste USA (pur non partecipando direttamente all’aggressione all’Afghanistan) e avrebbe dovuto interrompere immediatamente il sostegno ai Talebani in modo da non correre il rischio dell’esposizione ad un possibile attacco nordamericano. Tuttavia, gli Stati Uniti, dal canto loro, avrebbero dovuto rimuovere le sanzioni e garantire un aiuto economico immediato ad Islamabad.
Il generale Mohammed Aziz, principale artefice della vittoria talebana sull’Alleanza del Nord, fu uno dei pochi ad opporsi. Insieme a Muzaffar Usmani e lo stesso Mehmood Ahmad, fece notare che la totale capitolazione ai desideri USA avrebbe significato l’azzeramento di qualsivoglia potere contrattuale e di autonomia geopolitica per il Pakistan nel breve e lungo termine. Di fatto, sebbene con alcune palesi contraddizioni, è ciò che avvenne. Basti pensare che, in spregio di ciò che è sempre stato il peggiore incubo geopolitico pakistano, venne instaurato a Kabul un governo filo-indiano come quello di Ahmid Karzai.
La “guerra al terrore” dell’amministrazione Bush ed i suoi strascichi nelle amministrazioni successive, alla pari del decennio del gihad antisovietico, hanno avuto effetti deleteri e drammatici sulla società pakistana e sulla credibilità di figure istituzionali che, presentandosi come “modernizzatrici” (Musharraf si dichiarò estimatore di Seyyed Ahmad Khan e del padre della Turchia moderna Mustafa Kemal), hanno consentito ad una potenza straniera di bombardare il loro stesso popolo.
Nonostante ciò, dopo vent’anni e la continua manifestazione di autonomia strategica talebana, il ritiro USA dall’Afghanistan può ancora una volta essere considerato come una vittoria dell’ISI che, per vie traverse, non ha mai smesso di sostenere i ribelli afghani, scatenando anche non poche tensioni con gli Stati Uniti. La stabilizzazione dell’Asia Centrale e dei suoi flussi commerciali rimane il principale obiettivo per un Pakistan che entro il 2050 conoscerà un notevole incremento della popolazione. Per questo motivo i suoi rapporti (anche culturali) con il gigante economico cinese rimangono fondamentali. Allo stesso tempo, è fondamentale il sistema fluviale dell’Indo dal quale il Pakistan riceve l’80% del proprio fabbisogno di acqua dolce. Uno stallo del Trattato siglato con l’India nel 1960, paventato da Nuova Delhi nell’istante della recente fase conflittuale, metterebbe in grave crisi il sistema agricolo ed industriale pakistano. Fattore che spingerà Islamabad a trovare una soluzione nel prossimo futuro.