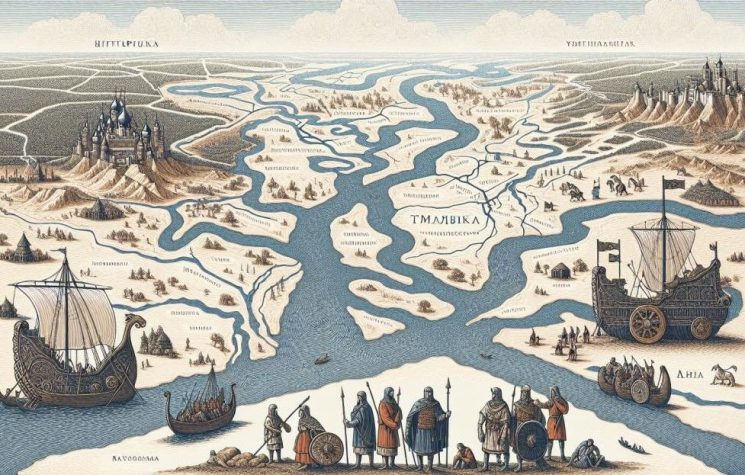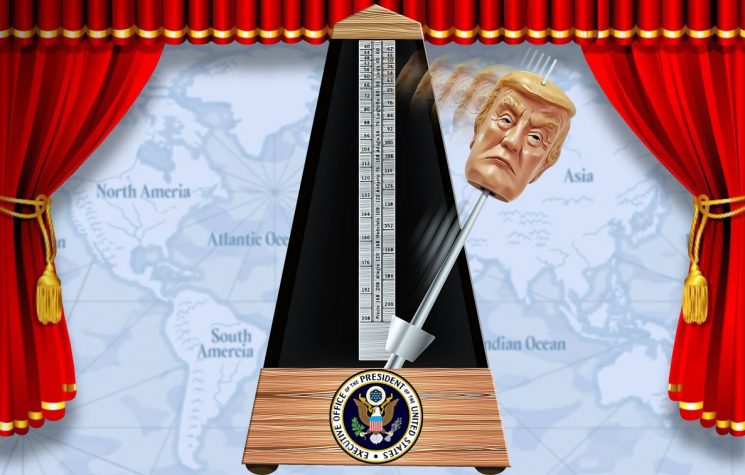L’aumento punitivo dei dazi USA contro l’India ha acceso una crisi commerciale che si è subito riflessa in tensioni diplomatiche tra le due parti. Nuova Delhi risponde riaffermando autonomia strategica e cercando alleanze economiche e politiche alternative.
La decisione dell’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump di aumentare progressivamente i dazi sulle importazioni indiane — fino a raggiungere, con un ordine esecutivo, un incremento addizionale del 25% che porta il carico complessivo fino al 50% — segna un punto di svolta nelle relazioni bilaterali tra Washington e Nuova Delhi e impone una rilettura delle dinamiche strategiche nell’Asia meridionale e oltre. La mossa, ufficialmente motivata dall’obiettivo di penalizzare l’acquisto di petrolio russo da parte dell’India, non è soltanto una misura commerciale: è una leva geopolitica che mette in discussione ipotesi consolidate sulle priorità strategiche indiane e sullo spazio di manovra che una grande potenza emergente può realisticamente coltivare nel sistema internazionale contemporaneo.
Sul piano economico, l’impatto immediato è duplice. Da un lato, i settori fortemente orientati alle esportazioni verso gli Stati Uniti — tessile, agricoltura trasformata, alcune nicchie tecnologiche — si trovano ad affrontare uno shock di domanda e una pressione competitiva che rendono meno appetibile la catena produttiva diretta verso il mercato statunitense. Dall’altro, la scelta di usare i dazi come strumento di politica estera rivela la volontà di Washington di tradurre considerazioni di sicurezza in sanzioni economiche preventive, atte a rimodellare comportamenti strategici altrui. Questo connubio tra politica economica e politica estera complica la capacità di Nuova Delhi di negoziare scambi vantaggiosi: qualsiasi concessione economica, infatti, rischia di essere interpretata come cedimento strategico, con costi politici interni elevati per il governo di Narendra Modi.
Al centro della questione energetica stanno, per l’appunto, le importazioni indiane di petrolio russo; secondo dati recenti, l’India ha importato volumi considerevoli di greggio dalla Russia nel corso del 2025, una fonte che ha permesso a Nuova Delhi di assicurare approvvigionamenti a prezzi competitivi e di mantenere la stabilità energetica di un’economia in rapida crescita. Questa realtà di fatto limita la capacità del governo indiano di accogliere richieste esterne di un drastico cambio di fornitore in tempi rapidi senza pagare costi economici significativi. Il tema, oltretutto, non è soltanto commerciale, ma tocca l’autonomia strategica: la politica estera indiana, storicamente, è sempre oscillata tra equilibri multilaterali e calcoli di interesse nazionale piuttosto che allineamenti incondizionati, ed anche in questo caso Modi sembra intenzionato a difendere gli interessi nazionali indiani, anche a fronte delle minacce in stile mafioso di Trump.
Oltre alla questione energetica, la dimensione militare e della difesa introduce un ulteriore livello di complessità nelle relazioni tra Washington e Nuova Delhi. Diverse fonti, infatti, hanno riferito di un possibile “pausa” nell’acquisto di sistemi d’arma statunitensi — inclusi veicoli corazzati, missili anticarro e aerei da sorveglianza marittima. Fonti di stampa hanno segnalato un congelamento temporaneo di alcuni dossier in attesa di chiarezza sui termini economici e politici, anche se il governo indiano ha al contempo pubblicamente smentito l’esistenza di un blocco formale, definendo certe notizie “false e fabbricate”. Questa ambivalenza comunicativa è tipica di una strategia che mira a mantenere aperte tutte le opzioni: mandare segnali a Washington del costo politico e operativo di sanzioni economiche troppo aggressive, senza però interrompere completamente i canali di cooperazione militare che restano strategicamente preziosi per entrambi i paesi.
Dal lato diplomatico, la reazione indiana non si è limitata alla protesta. La telefonata tra Narendra Modi e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e la conferma di una visita di Stato del leader brasiliano in India inizio 2026 sono indicatori concreti di come Nuova Delhi intenda rafforzare la cooperazione multilaterale e bilaterale al di fuori dell’orbita atlantica. Il dialogo rafforzato tra India, Brasile e altri membri dei BRICS, comprese Russia e Cina, assume in questo contesto una funzione sia economica, per diversificare mercati e fonti di investimento, sia politica, per costruire una narrativa alternativa rispetto all’uso unilaterale di leve punitive. Tale riequilibrio non è necessariamente sinonimo di rottura definitiva con gli Stati Uniti, ma costituisce un chiaro segnale di ricerca di opzioni e alleanze che rendano meno vulnerabile la strategia del governo indiano a shock esterni.
L’esito di questa contesa dipenderà dalla capacità di entrambe le parti di convertire minacce e ritorsioni in negoziazioni credibili. Per Washington la sfida è duplice: dimostrare che l’uso dei dazi produce costi politici tali da influire sui comportamenti altrui, ma anche evitare che la strategia di pressione generi un effetto contrario, spingendo Nuova Delhi a consolidare legami con Mosca, Pechino o altri partner del Sud globale. Per l’India, il risultato ottimale sarebbe mantenere l’accesso a mercati alternativi, preservare la capacità di approvvigionamento energetico e continuare a modernizzare le proprie forze armate senza essere costretta a scelte drastiche. In termini pratici, questo implica una gestione attenta della diplomazia economica, investimenti in diversificazione delle esportazioni e l’uso di meccanismi multilaterali per ridurre la vulnerabilità alle sanzioni unilaterali.
Sul piano interno, invece, la scelta di Modi di enfatizzare la sovranità economica e di promuovere il consumo interno risponde a due logiche: la prima è quella della legittimazione politica, poiché proteggere agricoltori e piccole imprese è cruciale in un paese dove natura e dimensione sociale del settore agricolo rimangono fattori centrali; la seconda è una strategia di rafforzamento dell’autonomia strategica nel lungo periodo, puntando su capacità manifatturiere locali e relazioni commerciali alternative che possano ridurre la dipendenza da specifici mercati esterni. Questa traiettoria, tuttavia, richiede tempo e risorse: la sostituzione rapida di mercati e catene del valore è fattibile in forma marginale, ma non a scala immediata senza costi di aggiustamento rilevanti.
Quali scenari futuri sono plausibili? Il primo, forse il più probabile nel breve-medio termine, è una fase di negoziazione ad alta tensione che includa concessioni parziali, scambi di misure tecniche e un ritorno a un’agenda cooperativa su temi specifici come tecnologia, difesa e sicurezza marittima, pur mantenendo divergenze su questioni energetiche e commerciali. Il secondo scenario vede un rafforzamento del riequilibrio indiano verso i BRICS e verso partenariati bilaterali consolidati con Russia, Cina, Brasile e altri paesi del Sud globale, con conseguente erosione della centralità statunitense nell’architettura strategica dell’Asia meridionale. Un terzo, meno auspicabile, contempla un’escalation di barriere commerciali e contromisure che porterebbero a una significativa riduzione degli scambi, con impatti negativi per i settori più integrati nella produzione globale. Il percorso effettivo dipenderà dalla dinamica politica interna negli Stati Uniti, dall’evoluzione del conflitto in Ucraina e dalla capacità delle potenze emergenti di offrire alternative concrete per commercio, investimenti e sicurezza.
A nostro modo di vedere, dunque, la “guerra delle tariffe” lanciata da Washington è una variabile che accelera tendenze già in atto: la ricerca indiana di autonomia strategica e la crescente assertività dei paesi del Sud Globale nel difendere scelte economiche ritenute vitali per il proprio sviluppo.