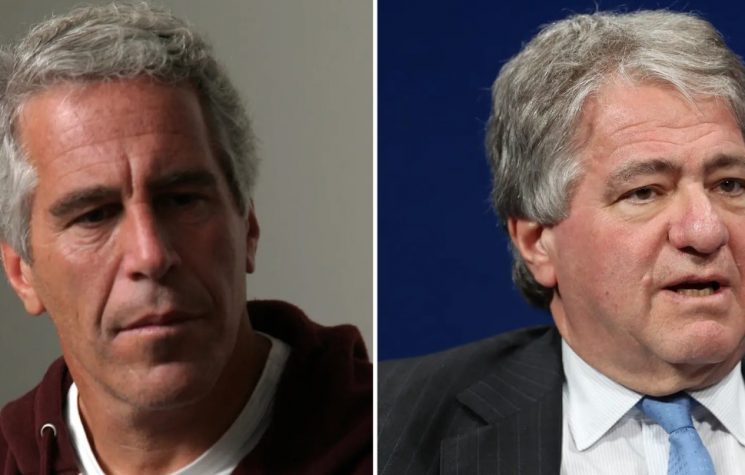L’imperialismo viceversa? Le importazioni di capitali (non solo) europei hanno impresso una forte spinta propulsiva all’economia degli Stati Uniti, i quali continuano a conseguire considerevoli ritmi di crescita a fronte di concomitanti incrementi del debito netto con l’estero.
Tra le non poche intuizioni geniali avute da Lenin, una rilevanza particolare va riconosciuta a quella che attribuiva all’esportazione dei capitali un ruolo di gran lunga più decisivo rispetto all’esportazione delle merci nell’ambito della dinamica imperialistica.
All’epoca, l’osservazione risultava indubbiamente corretta. Tutte le principali potenze, sia di consolidata (Gran Bretagna, Francia, Olanda, Belgio) che di nuova (Stati Uniti, Germania, Giappone) vocazione imperialista, mantenevano rigidi controlli sui movimenti di capitale per limitare l’accesso interno ai concorrenti. Convogliavano quindi i propri capitali in eccesso verso colonie, semi-colonie e Paesi formalmente indipendenti ma sprovvisti della forza per ergersi a potenziali competitori, che remuneravano gli investimenti stranieri sotto forma di rendimenti e dividenti elevati.
La Russia zarista rientrava indubbiamente nella categoria, al pari degli Stati Uniti dei decenni precedenti, quando percepivano enormi flussi di capitale britannici occupando una posizione rigorosamente debitoria fino alla Prima Guerra Mondiale. La deflagrazione della “Grande Guerra” comportò un rapido rovesciamento dei rapporti transatlantici, consacrando gli Usa come i maggiori esportatori di capitali al mondo. Una condizione che il Paese ha preservato per circa settant’anni. Ancora nel 1980, gli Stati Uniti esibivano una posizione finanziaria netta – che registra i flussi di capitale transfrontalieri (sotto forma di investimenti diretti, di portafoglio e di altro genere) di ciascun Paese – positiva per 297 miliardi di dollari: un ammontare superiore a quella ricavabile dalla sommatoria delle posizioni finanziarie nette di tutti gli altri Paesi del mondo.
Ad appena nove anni di distanza, tuttavia, la posizione finanziaria netta degli Stati Uniti passò in negativo per la prima volta dal 1914 (per un ammontare di 33,7 miliardi di dollari), inaugurando un processo di appesantimento progressivo delle passività che è tutt’ora in corso. Nel 1991, con una posizione negativa per 243 miliardi di dollari, gli Stati si affermarono come principali debitori netti su scala globale, e da allora hanno accumulato crescente distacco rispetto a ogni altro Paese. Alla fine del terzo trimestre del 2024, rivelano i dati pubblicati dal Bureau of Economic Analysis lo scorso 27 dicembre, gli Stati Uniti registravano una posizione finanziaria netta negativa per 23,60 trilioni di dollari, con un peggioramento su base annua quantificabile in 5,44 trilioni. Un ammontare assai cospicuo, pari all’82% del Pil ed equivalente alla somma delle posizioni finanziarie nette di tutti i Paesi debitori del mondo. In Europa, realizzano performance peggiori soltanto Grecia (-139,8% del Pil), Irlanda (-93,1% del Pil) e Cipro (-86,0% del Pil). Si tratta tuttavia di economie di dimensioni ridotte, mentre quella statunitense risulta a tutt’oggi la più grande su scala globale se misurata attraverso il parametro del Pil nominale.
Sotto molti aspetti, la posizione finanziaria netta negativa degli Stati Uniti si riflette negli attivi strutturali accumulati dal gruppo dei creditori, che riunisce Paesi come Cina, Giappone, Germania, Corea del Sud, Svizzera, Arabia Saudita e Russia. Parte assai rilevanti delle nazioni creditrici annovera gli Stati Uniti come destinazione dominante delle proprie esportazioni. Il discorso si applica soprattutto a Cina, Giappone e Germania, dotati di un saldo commerciale e finanziario pesantemente positivo con gli Stati Uniti, nonostante i rendimenti garantiti da questi ultimi agli stranieri risultino di gran lunga inferiori rispetto a quelli che gli investitori statunitensi ricavano dalle loro attività all’estero.
Lo certificano il saldo dei redditi internazionali da capitale, che per gli Stati Uniti è negativo per una quota compresa tra il 2 e il 2,5% del Pil, e la stessa posizione finanziaria netta degli Usa, che trimestre dopo trimestre vede le voci passive sovrastare in maniera sempre più netta quelle attive. Nel terzo trimestre 2024, le attività estere degli Stati Uniti sono cresciute su base annua da 32,90 a 37,86 trilioni di dollari (+4,96 trilioni); le passività, da 51,06 a 61,46 (+10,40 trilioni). Eppure, gli Stati Uniti, maggiori debitori al mondo, ricavano flussi di reddito netto enormemente positivi, a fronte di posizioni significativamente passive accumulate da grandi creditori come la Cina.
Per anni, l’ex Celeste Impero ha riciclato parte considerevole dei proventi derivanti dall’export nell’acquisto di titoli di debito degli Stati Uniti che garantivano molto spesso rendimenti negativi in termini reali. Un atteggiamento inteso per un verso ad irrigare la “benevolenza” della classe dirigente statunitense onde garantirsi l’accesso al mercato statunitense («come puoi essere duro con il tuo banchiere?», domandava nel 2009 l’allora segretario di Stato Hillary Clinton al primo ministro australiano Kevin Rudd), e per l’altro a mantenere ampia la divaricazione di cambio tra dollaro e yuan-renminbi in un’ottica di preservazione della competitività delle merci cinesi. Nel momento in cui Pechino ha alzato il tiro, mettendo nel mirino quote azionarie e imprese statunitensi di rilevanza strategica, Washington ha tuttavia attuato una brusca virata protezionistica. Le prime misure restrittive adottate dall’amministrazione Obama hanno aperto il varco a una serie di giri di vite, nella convinzione che quello stesso regime di (relativamente) libero mercato imposto dagli Stati Uniti a partire dagli anni ’80 stesse agevolando un processo di centralizzazione internazionale di capitali di stampo cinese, e assicurando più genericamente al “club dei creditori” vantaggi insostenibili.
Allo stesso tempo, però, gli investitori statunitensi continuano a incassare rendimenti stratosferici grazie al possesso di partecipazioni azionarie di imprese cinesi ad alto tasso di redditività.
Sul piano delle pubbliche relazioni, i provvedimenti statunitensi che hanno portato al sovvertimento deliberato delle logiche della globalizzazione sono stati ricondotti sotto l’espressione “politicamente corretta” di friendshoring, consistente nella riconfigurazione delle relazioni con l’estero intesa a incentivare una «stretta cooperazione per catene di approvvigionamento resilienti con alleati e partner che condividano i nostri valori, in modo da promuovere la sicurezza economica e nazionale collettiva», recita l’ordine esecutivo America’s Supply Chain firmato da Biden il 24 febbraio 2021. A poco più di un anno di distanza, a conflitto russo-ucraino ormai deflagrato e sanzioni statunitensi contro la Russia irrogate, il segretario al Tesoro Janet Yellen tornò sul punto, precisando che: «io tendo a vedere il friendshoring come un gruppo di partner con i quali sentiamo sintonia con la nostra geopolitica […]. Favorire il friendshoring contando su un gran numero di Paesi fidati, in modo da poter continuare a garantire in modo sicuro l’accesso al mercato, ridurrà i rischi per la nostra economia […]. Otterremmo così di proseguire nei vantaggi dell’efficienza nella produzione, avendo un gruppo di partner che lavorano per proteggere le catene di approvvigionamento e renderle più resilienti […]. Dobbiamo approfondire i nostri legami con quei partner e lavorare insieme per assicurarci di poter soddisfare le nostre esigenze di materie prime essenziali».
Le limitazioni introdotte agli investimenti esteri introdotte nel corso degli anni dalle autorità di Washington hanno condotto a una segmentazione dello scenario internazionale in blocchi geoeconomici molto meno comunicanti rispetto al recentissimo passato, e a una riorganizzazione dei flussi di capitale verso gli Stati Uniti gestita da grandi fondi del calibro di BlackRock, Vanguard e State Streets e sorretta dagli alleati internazionali di Washington, vale a dire Giappone, Corea del Sud, Australia e Paesi membri dell’Unione Europea. Una menzione speciale spetta alla Germania, il cui clima degli investimenti è stato letteralmente devastato dalle implicazioni del conflitto russo-ucraino. Se prima del febbraio 2022 avevano manifestato un certo livello di bidirezionalità, con l’adozione delle sanzioni, la recisione del legame energetico con la Federazione Russa e la destrutturazione dell’architettura di sicurezza europea i flussi transatlantici di capitale hanno assunto un senso univocamente favorevole agli Stati Uniti. Lo ha ammesso la stessa presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, che nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio Europeo tenutasi lo scorso aprile ha confermato quanto già denunciato da Enrico Letta, secondo cui oltre il 30% circa dei 1.000 miliardi di euro che ogni anno defluiscono dall’Europa prendono la via degli Usa.
Le importazioni di capitali (non solo) europei hanno impresso una forte spinta propulsiva all’economia degli Stati Uniti, i quali continuano a conseguire considerevoli ritmi di crescita a fronte di concomitanti incrementi del debito netto con l’estero.
Segno che, a circa un secolo di distanza dalla sua formulazione (1916), l’osservazione di Lenin secondo cui «l’esportazione del capitale è parassitismo elevato al quadrato» può essere capovolta nel suo esatto contrario. Senonché, rileva l’economista Valentin Katasonov, «i parassiti hanno tendenzialmente una vita limitata. Muoiono o perché le loro fonti di sostentamento si esauriscono, o perché gli organismi da cui succhiano linfa vitale li distruggono».