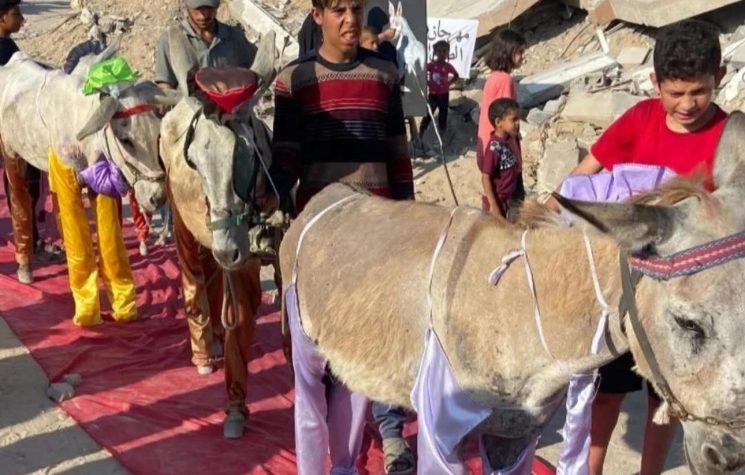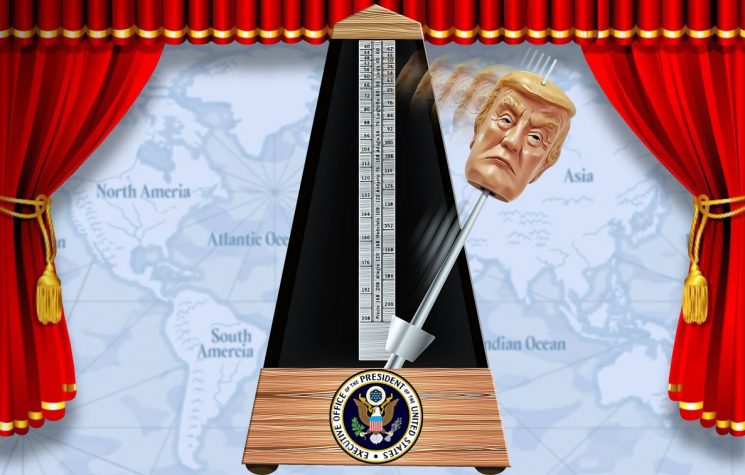L’attacco israeliano a Doha, in Qatar (dove si stava tenendo una riunione dell’ala politica di Hamas), ha aperto un nuovo capitolo nella lotta per l’egemonia nel Vicino Oriente. Qui si analizzerà il particolare (e sotto certi aspetti ambiguo) ruolo del Qatar in questo preciso contesto geopolitico.
Il Dawlat Qatar (Stato del Qatar), sin dalla sua indipendenza nel 1971, ha dovuto vivere (e sopravvivere) sottoposto alla doppia pressione degli ingombranti vicini: l’Arabia Saudita e l’Iran (prima e dopo la Rivoluzione Islamica).
È uno Stato di dimensioni piuttosto ridotte, con una demografia debole (3,1 milioni di abitanti in larga maggioranza lavoratori stranieri), ma dotato di vaste risorse naturali – il 13% delle riserve globali di gas che lo posizionano al terzo posto dopo Russia e Iran nel settore, e con la prospettiva di estrarre 126 tonnellate l’anno della risorsa entro il 2027 – che hanno reso il Paese indipendente sul piano economico e finanziario. Una indipendenza che, negli ultimi decenni (almeno dal 1995), ha permesso agli ambiziosi vertici politici qatarini di sviluppare una propria strategia geopolitica regionale.
Di fatto, con la salita al potere di Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani (proprio nel 1995) la politica estera del piccolo Stato del Golfo Persico cambia progressivamente. Fino a quel momento, il Qatar aveva mantenuto una posizione geopolitica dormiente, appiattita su quella dell’Arabia Saudita ed in linea con gli schieramenti della “Guerra Fredda”. Il nuovo sovrano, invece, rimasto al potere fino al 2013 (quando ha abdicato in favore del quarto figlio Tamim bin Hamd al-Thani), utilizzò da subito una serie di tattiche sia offensive che difensive per dare centralità al suo regno. In particolare, puntò con forza sul cosiddetto “potere morbido” e sulla diffusione/commercializzazione del “marchio” Qatar. Così, nel 1996, è stato lanciato il primo canale satellitare arabo, al-Jazeera: vero e proprio strumento di proiezione di influenza sul mondo arabo, assolutamente in linea con il progetto qatarino di acquisire il ruolo di centro regionale della cultura araba (in chiara competizione con Ryadh). Un canale, quest’ultimo, che ha spesso coperto in modo non poco ambiguo le notizie provenienti dallo stesso mondo arabo (si pensi, ad esempio, al caso siriano in diretta correlazione con quello del Bahrein, nel corso delle prime manifestazioni delle cosiddette “primavere arabe”). Ma tale “ambiguità” si è manifestata anche nella copertura di altri eventi: dall’invasione dell’Afghanistan fino all’attacco della “coalizione dei volenterosi” all’Iraq, o agli eventi legati alla Seconda Intifada in Palestina. In questi casi, infatti, pur essendo il Qatar totalmente dipendente in termini di sicurezza dagli Stati Uniti, al-Jazeera proponeva un racconto dei fatti che metteva spesso in luce i crimini e le malefatte delle diverse occupazioni. Questo rientra comunque nell’ambito di una certa ambiguità che ha sempre contraddistinto il gioco delle alleanze nella regione.
Sempre per ciò che concerne il “potere morbido” è difficile non tenere in considerazione gli importanti investimenti del Qatar per ciò che concerne lo sport; dall’organizzazione del mondiale di calcio del 2022 (estremamente criticato per l’ipersfruttamento dei lavoratori addetti alla costruzione degli stadi) fino all’acquisizione di importanti club europei (il Paris Saint-German di Nasser al-Khelaifi, già in ottimi rapporti con la casa regnante e fresco vincitore della UEFA Champions League).
Si è detto della dipendenza qatarina dagli Stati Uniti. Questa è connessa al particolare percorso storico compiuto da Doha dopo l’indipendenza. Il Qatar, come noto, alla pari di Emirati Arabi Uniti e Bahrein, ottenne la propria indipendenza dal Regno Unito nel 1971, ma rimase legata a Londra da un trattato di cooperazione ed amicizia fino al 1981. La presenza inglese nella Penisola Arabica, nel Golfo Persico e, dunque, in quello che è stato chiamato come Heartland mediorientale, era centrale per la fornitura di greggio alla Royal Navy e per garantire la proiezione egemonica marittima britannica.
Nonostante l’indipendenza, rimaneva comunque difficile definire queste entità politiche come “Stati-nazione”. Un discorso che vale in misura minore per l’Arabia Saudita, costruita sempre con il patrocinio britannico ma attorno alla particolare interpretazione wahhabita dell’Islam sviluppatasi nel XVIII secolo. Tra l’altro sarebbe opportuno ricordare che, con il sostegno alla causa saudita-wahhabita, Londra portò a compimento un doppio tradimento nei confronti degli hashemiti meccani (diretti discendenti del Profeta Muhammad) che si videro negare non solo la creazione di uno Stato arabo nel Vicino Oriente promesso a seguito della loro ribellioni all’Impero ottomano (si pensi agli accordi Sykes-Picot); non solo videro Londra promettere la Palestina al sionismo con la Dichiarazione Balfour; ma si videro pure privati dei luoghi santi dell’Islam (Mecca e Medina) di cui erano storicamente protettori.
Ad ogni modo, con il declino dell’“impero” britannico, a seguito dei due conflitti mondiali, il ruolo di questo nel Vicino Oriente venne fatto proprio dagli Stati Uniti. Questi, già nel 1945, avevano garantito piena protezione alla stessa Arabia Saudita in cambio di lucrosi contratti sulla produzione/fornitura di petrolio con il quale Washington avrebbe dovuto garantirsi il ruolo marittimo che fu della Gran Bretagna. Tuttavia, la loro influenza regionale aumenta in modo esponenziale a seguito delle prime due guerre del golfo: il conflitto Iran-Iraq (con la quale gli USA, agendo da ago della bilancia, ottengono l’auto-annullamento delle due più importanti potenze militari regionali) e la prima aggressione a Baghdad a seguito dell’invasione del Kuwait nei primi anni ’90.
Al 1992, non a caso, corrisponde la firma di un accordo di difesa tra Qatar e Stati Uniti, seguito da un altro con la Francia nel 1994. E, più o meno nello stesso periodo, il Qatar cerca di avvicinarsi anche ad Israele, sebbene l’assassinio di Yitzhak Rabin e la salita al potere di un governo di destra, guidato per la prima volta da Benjamin Netanyahu, modificano rapidamente questa prospettiva.
Come già anticipato, con il 1995 le cose cambiano sul piano dei rapporti interni al mondo arabo, ma non per ciò che concerne l’“alleanza” tra Qatar e Stati Uniti che, anzi, si evolve a partire dal 2003 con il trasferimento delle forze USA dall’Arabia Saudita alla base qatarina di al-Ubeid che diviene la più grande della regione. Per Washington, infatti, il Qatar è fondamentale per la sua vicinanza a diversi teatri di guerra (reali e potenziali) – Iraq, Yemen, Palestina, Iran e Afghanistan – e per il controllo diretto del Golfo Persico e del traffico petrolifero. Ancora, gli Stati Uniti puntano sulle ambizioni geopolitiche del Qatar, utilizzandolo come mediatore in diversi conflitti regionali (un ruolo svolto egregiamente anche dall’Oman, ad onor del vero). Ed in questo senso, Doha lavora per dirimere le controversie all’interno dei vertici politici palestinesi; lavora per organizzare incontri tra rappresentanti USA e dei talebani afghani; opera per porre fine ai conflitti ripetuti tra i ribelli Houthi dello Yemen ed il potere centrale di Sana’a nel primo decennio del XXI secolo.
Ma Doha utilizza questo ruolo anche per proiettare la propria influenza sul mondo arabo. Cosa non affatto gradita dall’Arabia Saudita che già in due occasioni (1996 e 2002) aveva cercato di orchestrare dei colpi di Stato per rovesciare Hamad bin Khalifa. A ciò, inoltre, si aggiunga l’ostruzionismo saudita per la realizzazione di alcuni progetti infrastrutturali (gasdotti) che avrebbero dovuto collegare il Qatar con il Bahrein ed il Kuwait e la cosiddetta “guerra fredda araba” del 2017 con la rottura dei rapporti diplomatici (poi ricostruiti) tra Doha, da una parte, ed Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti dall’altra. Una rottura arrivata per evidenti fratture sulla gestione del conflitto in Siria – conflitto in parte dovuto al rifiuto di Damasco di assecondare il progetto di un gasdotto che, passando dal territorio siriano, avrebbe dovuto collegare Qatar e Turchia – ma anche per questioni più prettamente “ideologiche” come il sostegno qatarino alla Fratellanza Musulmana e proprio la sua vicinanza con la Turchia (di fatto, la ricerca della sponda turca ed all’occorrenza anche iraniana – nel 2010 Qatar e Iran siglano un accordo di sicurezza reciproca e sulla divisione dei confini marittimi – ha sempre avuto il ruolo di limitare/contrastare l’influenza saudita sullo stesso Qatar e, più in generale, sull’intera regione).
Il sostegno alla Fratellanza Musulmana (molti telepredicatori di questo movimento operano proprio dalle emittenti qatarine) merita l’apertura di una breve parentesi, visto che il gruppo è stato dichiarato organizzazione terroristica dall’Egitto (nonostante avesse vinto le uniche elezioni libere tenute nel Paese), e vista la diretta discendenza di Hamas dallo stesso (si è a lungo disquisito sui fondi qatarini giunti nella Striscia di Gaza prima del 7 ottobre 2023). In realtà, se è vero che l’ala politica del Movimento di Resistenza Islamico palestinese ha sempre guardato verso il Qatar (fattore che lo spinse a schierarsi contro Bashar al-Assad nei primi anni del conflitto siriano): è altrettanto vero che l’ala militare del Movimento ha sempre mantenuto strette relazioni con la Repubblica Islamica dell’Iran, a prescindere dalle differenze teologiche tra sunniti e sciiti. In questo senso non è errato affermare che Iran e Qatar si siano contesi l’esercizio di influenza su Hamas, sebbene il Movimento palestinese abbia sempre agito con una sostanziale autonomia.
Ora, al discorso su Hamas si collegano anche i fatti più recenti: ovvero l’attacco israeliano a Doha e le reazioni internazionali ad esso. Il Presidente USA Donald J. Trump ha criticato l’azione di Israele contro un “grande e prezioso alleato” di Washington. Tuttavia, non si capisce perché i sistemi di difesa antiaerea nordamericani siano rimasti spenti. Ed a questo si aggiunga che aerei britannici e statunitensi hanno di fatto accompagnato/protetto i caccia israeliani nella loro azione.
Detto ciò, l’attacco israeliano sembra aver raggiunto solo in parte gli obiettivi sperati, forse a causa di un avvertimento preventivo arrivato a Doha attraverso la Turchia. Ma l’azione israeliana rimane carica di ulteriori ripercussioni nel lungo periodo. In primo luogo Tel Aviv è conscia del fatto che Egitto ed Arabia Saudita non vedano affatto male un indebolimento della posizione geopolitica qatarina. In secondo luogo, il vertice arabo-islamico, convocato d’urgenza proprio a Doha, sembra aver spinto per la creazione di una “NATO araba” (cosa di cui si parla sin dalla seconda amministrazione Obama e dalla prima amministrazione Trump) che, già dal nome, sembra voler presagire un aumento della spesa militare dei Paesi arabi in favore degli Stati Uniti (e questo spiegherebbe anche il “nulla osta” USA all’attacco). Allo stesso tempo, però, un incremento della tensione tra Israele e le monarchie del Golfo metterebbe a rischio il progetto IMEC – India-Middle East Economic Corridor (la cosiddetta “Via del Cotone”) che avrebbe dovuto garantire ad Israele quella proiezione geopolitica verso Oriente di cui ancora necessita fortemente. Non solo, l’attacco a Doha, mette in chiaro che nessuno è realmente al sicuro e destabilizza ulteriormente la regione, preparando forse un nuovo potenziale attacco non alla Turchia (cosa che farebbe scattare l’articolo V dello statuto della NATO) ma agli interessi turchi a Cipro.