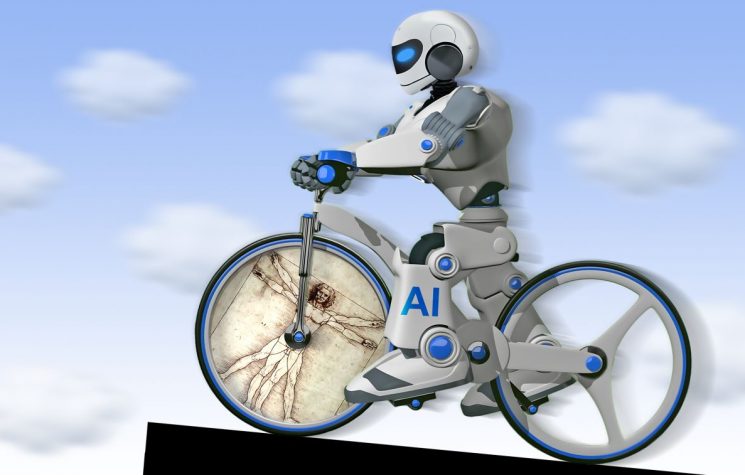Come il mondo è diventato dipendente dall’America
Con l’entrata in vigore dell’accordo, la recessione statunitense terminò ufficialmente, partirono le prime consegne di sistemi d’arma all’Arabia Saudita e andò intensificandosi l’impegno statunitense a garantire la stabilità del dollaro. A tale scopo, il presidente Ford accolse il consiglio di Tucker di istituire una riserva strategica nazionale, preposta a tutelare gli Stati Uniti da penurie negli approvvigionamenti e a sostenere i prezzi del petrolio nelle fasi di flessione così da mantenere inalterati i flussi di cassa sauditi. In base all’intesa segreta tra Washington e Riad, di cui si trova traccia in un memorandum del febbraio 1975 redatto dal funzionario del Dipartimento del Tesoro Jack Bennett (che in seguito assunse la guida della Exxon), gli Usa ottennero anche l’autorizzazione a inviare a Riad, in qualità di consulente finanziario della Saudi Arabia Monetary Authority (Sama), il finanziere David Mulford con l’incarico di gestire il processo di trasferimento dei fondi sauditi presso le banche di Wall Street e della City.
La Chase Manhattan Bank stimò che, tra il 1974 e il 1978, i Paesi dell’Opec avrebbero accumulato surplus per 185 miliardi di dollari, l’80% circa dei quali sarebbe confluito verso le piazze finanziarie di New York e Londra per essere trasformato in prestiti ai Paesi in via di sviluppo sotto la supervisione degli amministratori delegati di Chase Manhattan Bank (David Rockefeller) e Citibank (Walter Wriston). Puntualmente, i petrodollari in uscita dai Paesi produttori migrarono regolarmente verso il mercato degli eurodollari, così come i narcodollari generati dallo smercio dell’eroina afghana (gestito dalle famiglie mafiose Usa dei Gambino, Bonanno, ecc.) e della cocaina colombiana (gestito dai cartelli di Medellín e Cali).
Nei 5 mesi successivi all’intesa tra Stati Uniti e Arabia Saudita, il dollaro registrò una rivalutazione del 4,6%, salvo calare leggermente fino alla fine del 1976 e crollare letteralmente nel 1977. Nell’ottobre del 1978, l’indice del dollaro scese di quasi il 13% rispetto al picco massimo del 1975. La depressione costante e apparentemente inarrestabile del corso del dollaro fu interpretata dai sauditi come una violazione dell’accordo Simon-Faysal, e posta a fondamento della liquidazione di decine di miliardi di dollari di Treasury Bond e del raddoppio del prezzo del petrolio disposto a cavallo tra il 1979 e il 1980, in piena Rivoluzione Islamica iraniana. Dal canto suo, il nuovo governo di Teheran tagliò drasticamente l’output petrolifero in perfetta concomitanza con il ridimensionamento delle scorte da parte di Big Oil, innescando un crollo verticale dell’offerta foriero di radicali stravolgimenti nel mercato internazionale degli idrocarburi. Il prezzo del petrolio schizzò da 14 a oltre 40 dollari per barile nell’arco di poche settimane. La recessione e le interminabili code di automobili che vennero a formarsi presso gran parte delle stazioni di rifornimento statunitensi concorsero a diffondere panico e insicurezza in tutto il Paese.
Ad appena un anno e mezzo di distanza, sulla scia della crisi degli ostaggi in Iran e dell’invasione sovietica dell’Afghanistan, la quotazione dell’oro era arrivata a sfondare la soglia critica degli 875 dollari per oncia, e per ben due volte nell’arco di pochi mesi le grandi imprese, le Banche Centrali e altri investitori avevano rifiutato l’utilizzo del dollaro come valuta universale. Si stagliava così all’orizzonte la prospettiva, temutissima da Washington, di un incremento potenzialmente insostenibile delle pressioni generalizzate per il ripristino di una qualche forma di ancoraggio all’oro.
La crisi del dollaro fu superata attraverso la revoca delle politiche espansive portate avanti nel corso degli anni precedenti, in favore di una generale rivalutazione dei principi della stabilità della moneta culminata con la poderosa stretta creditizia varata della Federal Reserve. Sotto la direzione del nuovo presidente Paul Volcker, la Fed innalzò tasso di interesse – portandolo dal 6 al 20% nell’arco di poche settimane – ben al di sopra del saggio di inflazione corrente, che crollò dal 15% del 1980 al 4% entro la fine del 1982. L’indice del dollaro risalì da 84,13 dell’ottobre 1978 a 92,48 nel novembre 1980, raggiungendo i livelli toccati nel 1975. Combinata alla deregulation e alla detassazione implementate sotto l’amministrazione Reagan, la linea restrittiva imposta da Volcker impresse una spinta decisiva alla valuta statunitense. Nel marzo 1985, l’indice del dollaro raggiunse il massimo storico di 128,44, con uno spettacolare aumento del 53% rispetto al minimo dell’ottobre 1978. Il prezzo fu la deindustrializzazione, con lo strangolamento di gran parte delle attività legate alla produzione reale di beni. Migliaia di stabilimenti furono trasferiti dagli Stati Uniti ai Paesi in via di sviluppo come la Cina, dotati di inesauribili serbatoi di manodopera a basso altamente produttiva, con conseguente perdita di posti di lavoro di alta qualità e delle relative competenze.
I tentativi di temperare l’insostenibile squilibrio vigente si concretizzarono con l’Accordo del Plaza, implicante la rivalutazione dello yen e del marco attraverso un colossale programma di vendita di valuta statunitense da parte delle Banche Centrali di Francia, Repubblica Federale Tedesca, Gran Bretagna e Giappone. Lo “scaricamento” di ben 10 miliardi di dollari innescò una depressione del corso del dollaro rispetto allo yen del 51%. L’atto di forza sanciva il rovesciamento della politica restrittiva portata avanti fino a quel momento e il trasferimento della recessione dagli Usa ai loro concorrenti economici, funzionale al rilancio della competitività dell’apparato produttivo statunitense. Nell’immediato, la Germania e soprattutto il Giappone accusarono pesanti contraccolpi, ma il tentativo di rilancio dell’export Usa si risolse comunque in un sostanziale fallimento a causa dell’incommensurabile divario qualitativo che separava le merci asiatiche ed europee da quelle statunitensi e della renitenza giapponese a rimuovere i vincoli sulle importazioni. Nel febbraio 1987, a nemmeno due anni di distanza, l’Accordo del Louvre pose fine alla strategia di affossamento pilotato del valore del dollaro in un’ottica di stabilizzazione della valuta statunitense, conformemente agli impegni assunti da Washington nei confronti dei sauditi. La politica del “dollaro forte” fu seguita senza indugi per il ventennio successivo, sotto Bush sr., Clinton e Bush jr., consolidando l’accordo Simon-Faysal su cui si fondava lo status internazionale del dollaro, principale valuta sia di riserva che di pagamento.
La situazione cambiò radicalmente con la bancarotta di Lehman Brothers (15 settembre 2008) e la “grande crisi” che ne scaturì. Crollo del commercio internazionale, recessione generalizzata e incertezza diffusa proiettarono sull’economia mondiale l’ombra sinistra della Grande Depressione. Nella visione delineata dal presidente Obama nel discorso sullo Stato dell’Unione del gennaio 2010, il superamento della crisi passava necessariamente per una forte attenuazione degli squilibri economici e commerciali globali. A suo avviso, occorreva che Cina e Giappone trasferissero l’asse della crescita dagli investimenti al consumo interno; che l’Unione Europea spostasse il focus dall’export agli investimenti e che gli Stati Uniti abbandonassero il ruolo di “importatori di ultima istanza” del surplus produttivo globale attraverso un rilancio delle esportazioni. «Più prodotti produciamo e vendiamo ad altri Paesi, più posti di lavoro sosteniamo qui in America. Ci siamo prefissati un nuovo obiettivo: raddoppieremo le nostre esportazioni nei prossimi cinque anni, un incremento che sosterrà due milioni di posti di lavoro in America», proclamò Obama. La via maestra per raggiungere l’obiettivo consisteva in una svalutazione del dollaro, realizzata attraverso colossali iniezioni di liquidità nell’ambito dei programmi di quantitative easing adottati dalla Federal Reserve in accordo con il Dipartimento del Tesoro. Per il sistema bancario statunitense, l’intervento dell’autorità pubblica venne a configurarsi come una fondamentale rete di sicurezza, ma le implicazioni sul versante monetario si rivelarono clamorose: nel luglio 2011, ad appena 18 mesi di distanza dal pronunciamento di Obama, l’indice del dollaro piombò al minimo storico di 80,48.
Una svalutazione pesantissima, tale da mettere in seria discussione l’accordo del petrodollaro. Anche perché accompagnata dall’intesa sul nucleare iraniano patrocinata dall’amministrazione Obama, interpretata come un inaccettabile voltafaccia da Riad, oltre che dalla desecretazione parziale di un rapporto statunitense che “esplorava” potenziali connessioni tra Riad e i personaggi coinvolti negli attentati dell’11 settembre 2001. Nonché dall’esplicito sostegno politico accordato da Washington alle cosiddette “primavere arabe”, una vera e propria ondata di destabilizzazione della macroarea nordafricana e mediorientale in cui si concentra parte assai rilevante delle riserve mondiali di petrolio. Significativamente, le “primavere arabe” presero avvio mentre gli Stati Uniti si ponevano nelle condizioni di conquistare, grazie all’applicazione delle tecniche di fratturazione idraulica (fracking), l’agognata autosufficienza energetica. E persino di affermarsi come grandi esportatori, al di fuori della cornice Opec.
Così come nel 1971 ripudiarono unilateralmente gli Accordi di Bretton Woods perché incompatibili con i loro interessi nazionali, allo stesso modo e per ragioni sostanzialmente affini gli Stati Uniti si sono svincolati dall’intesa sul petrodollaro – anche se in forma più sotterranea e meno plateale. Il rifiuto di rinnovare il patto Simon-Faysal ufficializzato dall’Arabia Saudita nel giugno del 2024 ha conferito formalità a una situazione reale affermatasi ormai da tempo.