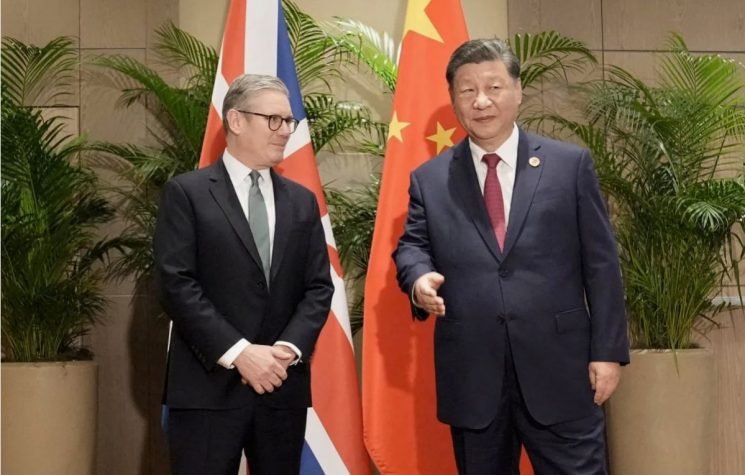L’accordo di difesa tra Arabia Saudita e Pakistan è un tassello del grande cambiamento in atto
Lo scorso 17 settembre, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif si è recato in visita a Riad per firmare assieme al principe ereditario saudita Mohammed bin-Salman un accordo di mutua difesa strategica che consacra una significativa alterazione del quadro geostrategico mediorientale. Nello specifico, recita il comunica congiunto pubblicato a margine dell’incontro, l’intesa, «che riflette l’impegno condiviso di entrambe le nazioni a rafforzare la propria sicurezza e a raggiungere la stabilità e la pace nella regione e nel mondo, mira a sviluppare aspetti della cooperazione in materia di difesa tra i due Paesi e a rafforzare la deterrenza congiunta contro qualsiasi aggressione. L’accordo stabilisce che qualsiasi aggressione contro uno dei due Paesi sarà considerata un’aggressione contro entrambi».
Al premier pakistano, i sauditi hanno riservato un’accoglienza generalmente concessa ai grandi leader globali, con tanto di caccia F-15 che sorvolavano il tappeto rosso srotolato dinnanzi alla scaletta dell’areo da cui Sharif si apprestava a scendere. A riprova della rilevanza attribuita all’accordo dalla leadership di Riad.
L’Arabia Saudita, custode di due dei principali luoghi sacri dell’Islam e attore cruciale nel mercato energetico globale si è così assicurato la protezione militare del Pakistan, affermatosi ormai da decenni come unica potenza nucleare del mondo musulmano grazie, si vocifera ormai da anni, proprio ai capitali messi a disposizione da Riad.
La tempistica dell’intesa è assolutamente emblematica, perché giunge al culmine di un’escalation mediorientale scatenata da Israele, che ha aperto un ottavo fronte, rappresentato dal Qatar, supplementare a quelli costituiti da Striscia di Gaza, Cisgiordania, Libano, Siria, Yemen, Iraq e Iran. In questo contesto, gli Stati Uniti hanno manifestato sia un sostanziale appiattimento sulle posizioni israeliane confermato anche dinnanzi alla recente aggressione nei confronti del Qatar, sia l’incapacità di garantire la sicurezza regionale, come certificato dal fallimento in cui si è risolta la campagna militare contro gli Houthi yemeniti.
Allo stesso tempo, le potenzialità belliche dimostrate dall’Iran nel corso della “guerra dei 12 giorni” contro Israele hanno indotto profonde riflessioni in tutto il Medio Oriente, a partire proprio dall’Arabia Saudita. In un’intervista rilasciata a «The Cradle» lo scorso luglio, un anonimo ma “ben informato” diplomatico arabo ha dichiarato che: «questa guerra ha segnato una svolta nel pensiero saudita. Riad ora comprende che l’Iran è una potenza militare matura, immune alla coercizione. La pressione tradizionale non funziona più. La sicurezza saudita ora dipende da un accomodamento diretto con l’Iran, non da Israele, e certamente non dal declinante ombrello di sicurezza statunitense». Combinandosi con le valutazioni nettamente negative formulate dalla classe dirigente saudita in merito alla linea d’azione israeliana, l’effetto dirompente generato dalla ritorsione iraniana «spinge l’Arabia Saudita a riconsiderare le sue scommesse regionali e a considerare l’Iran come un fattore di potenza regionale che non può essere ignorato».
Un altro diplomatico raggiunto sempre da «The Cradle» ha espresso considerazioni dello stesso tenore: «Riad sta abbandonando le illusioni. Il dialogo con i vicini, non l’alleanza con Washington e Tel Aviv, è ora considerata la via per salvaguardare gli interessi sauditi. Si tratta di fatti, non di adesione a vecchi vincoli di lealtà. L’Iran costituisce ormai una componente fissa dell’equazione della sicurezza del Golfo».
Non si tratta di un mero “effetto collaterale” della riapertura dei canali diplomatici tra Riad e Teheran mediata dalla Cina nel 2023, ma di una sostanziale alterazione della postura strategica saudita, allontanatasi gradualmente dalla sfera d’influenza statunitense a beneficio di una sempre più accentuata propensione a «ricercare soluzioni regionali lontane da Washington». Una tendenza che, sostiene «The Cradle», risulta condivisa anche dagli altri Paesi del Golfo Persico. Risultato: «il binomio “Golfo contro Iran” sta svanendo. L’ultima guerra ha accelerato una tendenza in atto da tempo: il crollo della Pax Americana e l’emergere del regionalismo multipolare. Il Golfo sta tracciando una nuova rotta, meno soggetta ai diktat di Stati Uniti e Israele. Oggi, l’Arabia Saudita vede Teheran non come una minaccia da neutralizzare, ma come una potenza da coinvolgere. I quadri di sicurezza regionale vengono costruiti dall’interno. Israele, nel frattempo […], sta lottando per rimanere rilevante. Se queste dinamiche si preserveranno, ci orienteremo verso una transizione storica, che potrebbe finalmente consentire al Golfo Persico di definire la propria sicurezza e sovranità, alle proprie condizioni. No si tratta di un futuro ideale, ma di un passo avanti strategico dopo decenni di sottomissione».
Coerentemente con le anticipazioni, il principe bin-Salman ha incontrato il Consigliere per la Sicurezza Nazionale iraniano Ali Larjani ancor prima di ricevere il premier pakistano Sharif, per concordare l’espansione dei legami economici e della cooperazione in materia di difesa, oltre che per definire misure volte a rafforzare la stabilità nel teatro dell’Asia occidentale. Le agenzie di stampa saudite e iraniane hanno riferito che bin-Salman e Larijani hanno esaminato con particolare attenzione gli «ultimi sviluppi regionali», e intavolato discussioni relative alle modalità da adottare per espandere la cooperazione a beneficio del «futuro della regione». Larijani ha successivamente incontrato il ministro della Difesa saudita Khalid bin-Salman al-Saud per discutere iniziative di difesa bilaterali e sicurezza regionale, e affermato di aver analizzato «le relazioni saudite-iraniane e diverse questioni di reciproco interesse, nonché gli sviluppi regionali e gli sforzi per raggiungere sicurezza e stabilità». Questi incontri si sono verificati il giorno successivo all’incontro tra bin-Salman e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian tenutosi a Doha a margine del vertice arabo-islamico di emergenza convocato in risposta all’attacco israeliano al Qatar. Stando a quanto riportato da «al-Arabiya», quel summit avrebbe registrato un consenso unanime attorno alla necessità di «accelerare i lavori della Gulf Joint Task Force per la creazione di un sistema di allerta precoce contro i missili balistici». Nonché di procedere alla condivisione della «situazione aerea tra tutti i centri operativi; all’aggiornamento dei piani di difesa congiunti mediante la coordinazione tra il Comando Militare Unificato e il Comitato per le Operazioni e l’Addestramento dei Paesi membri del Consiglio per la Cooperazione del Golfo; all’intensificazione dello scambio di informazioni in materia di intelligence in seno al Comando Militare Unificato». Durante l’incontro di Doha si sarebbe inoltre stabilito di organizzare «esercitazioni congiunte tra i centri operativi e per la difesa aerea degli stati del Golfo entro i prossimi tre mesi, a cui fare seguito un’esercitazione aerea congiunta vera e propria».
L’accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita e Pakistan si inserisce perfettamente in questo quadro strategico in evoluzione. Lo ha riconosciuto anche Zalmay Khalilzad, diplomatico statunitense di lunghissimo corso secondo cui «se l’Arabia Saudita non nutre più fiducia nelle garanzie di sicurezza americane, perché dovrebbe farlo chiunque altro?». A suo avviso, l’accordo sancisce inoltre un allineamento indiretto dell’Arabia Saudita al complesso militar-industriale cinese, che copre qualcosa come l’81% degli approvvigionamenti militari il Pakistan.
La sfiducia negli Stati Uniti sgancia quindi la penisola araba dal paradigma di difesa anti-iraniano imperniato sugli Accordi di Abramo, orientandola verso un modello più aderente al principio della “sicurezza indivisibile” di cui Iran e Pakistan costituiscono parte integrante.