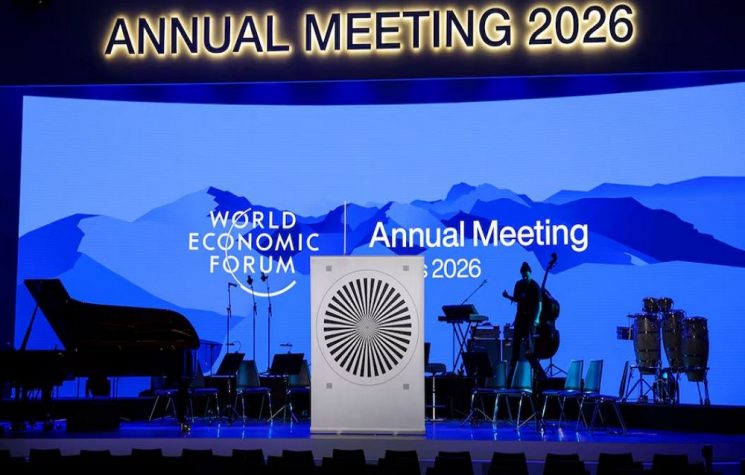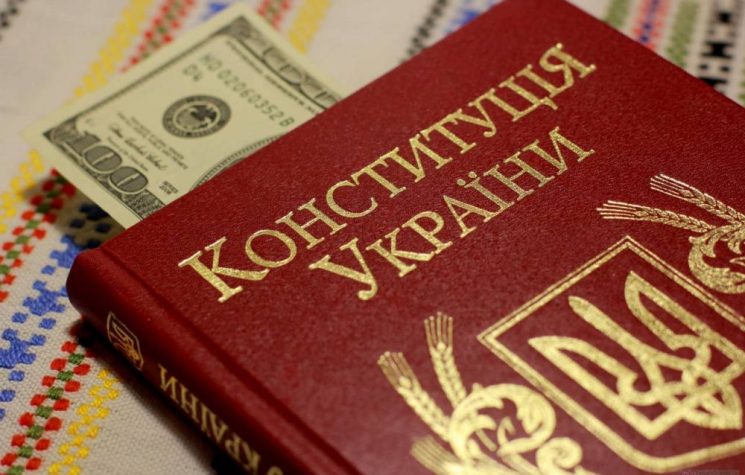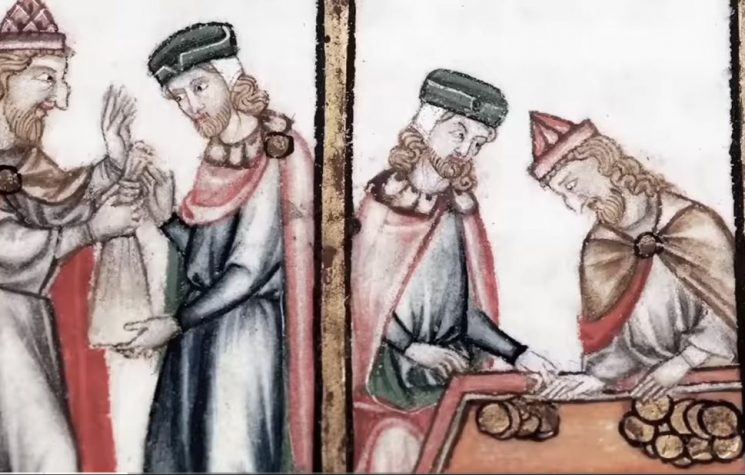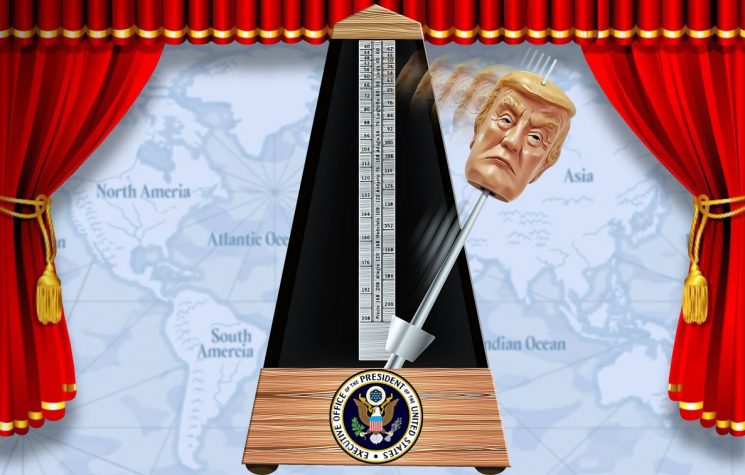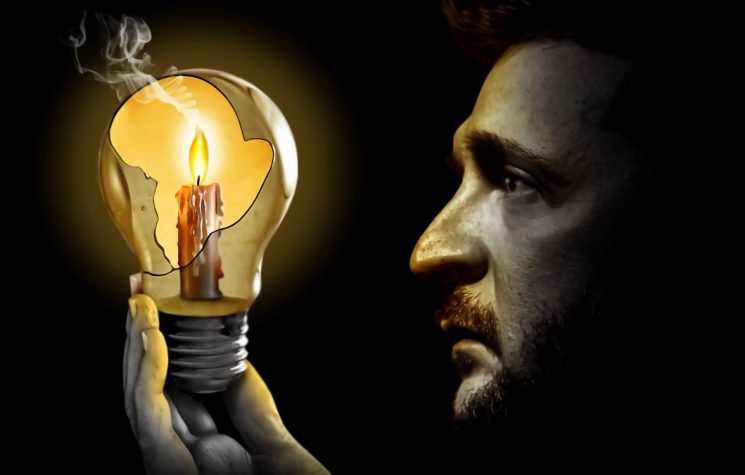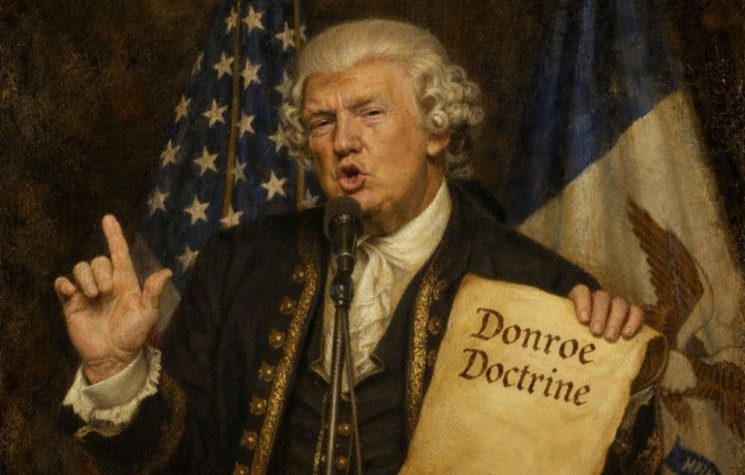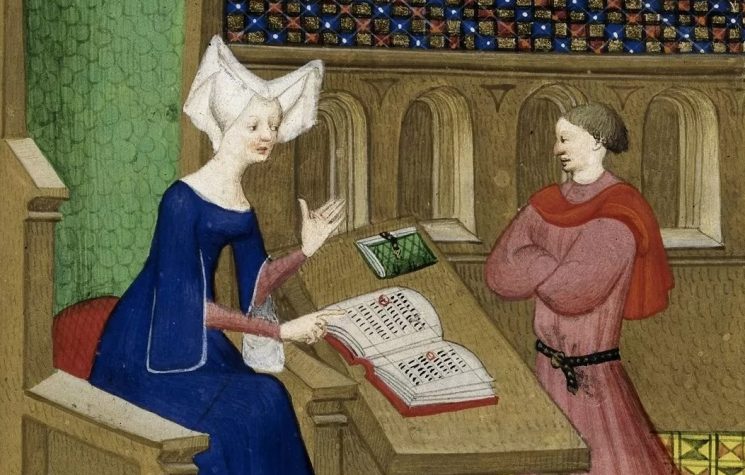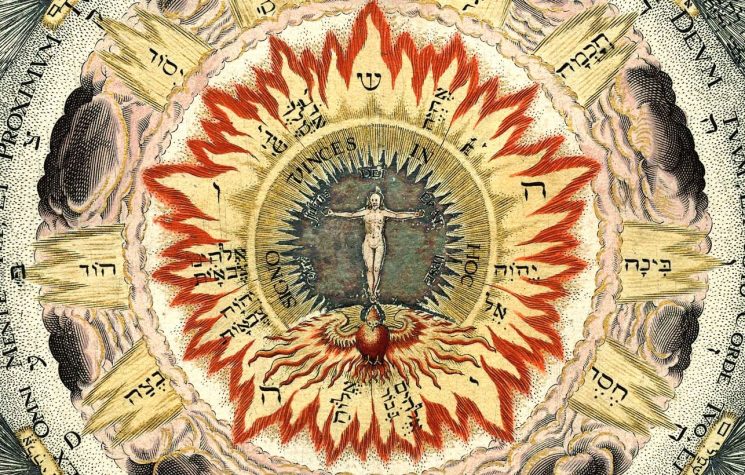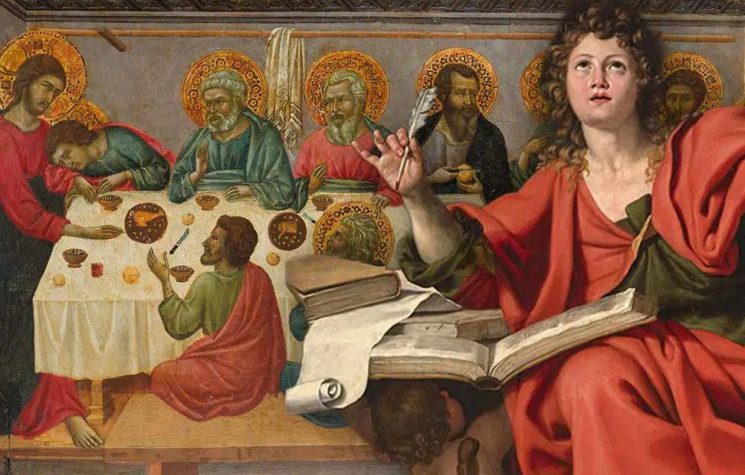Con il Quindicesimo Piano Quinquennale 2026-2030, Pechino punta su innovazione tecnologica autonoma, industria avanzata e prosperità condivisa. La Cina rivendica i risultati del periodo 2021-2025 e rilancia con obiettivi più ambiziosi: sicurezza nazionale, transizione verde, apertura di alto livello e miglioramento concreto della vita quotidiana.
Il Quindicesimo Piano Quinquennale della Repubblica Popolare Cinese, che coprirà il periodo 2026-2030, è stato impostato dal XX Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) nel corso della quarta sessione plenaria. Si tratta del documento di indirizzo più importante della politica economica e sociale cinese, che definisce la traiettoria di sviluppo dei prossimi cinque anni e, allo stesso tempo, delinea il percorso che dovrebbe portare entro il 2035 a una modernizzazione “fondamentalmente compiuta”, secondo la formulazione della leadership. Il linguaggio politico e tecnico che accompagna questa pianificazione si sposa con contenuti che sono estremamente concreti: industria, salari, ricerca scientifica, sicurezza nazionale, qualità della vita urbana e rurale, transizione ecologica e rapporto con il resto del mondo. È, in altre parole, un progetto di società.
Per capire che cosa c’è in gioco nel piano 2026-2030 bisogna partire da ciò che è accaduto nel ciclo precedente, cioè dal XIV Piano Quinquennale, che copre il periodo 2021-2025. Quel piano è nato in condizioni globali difficilissime, quelle dell’uscita dalla pandemia, caratterizzate da un rallentamento della crescita mondiale, dalla rottura di catene di approvvigionamento globali, dall’aumento del protezionismo e dalla recrudescenza della competizione geopolitica. A questo si sono aggiunte le tensioni tecnologiche e commerciali con gli Stati Uniti e i loro alleati, oltre a guerre commerciali e restrizioni unilaterali sull’export e sull’accesso a tecnologie avanzate. In questo quadro, il Comitato Centrale del PCC ha rivendicato ufficialmente “importanti risultati di sviluppo” ottenuti durante il piano 2021-2025, come dimostrano i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica per i primi tre trimestri del 2025, i quali segnalano una crescita del PIL del 5,2% su base annua, in accelerazione rispetto al ritmo dell’anno precedente. Questa dinamica è maturata mentre le principali economie avanzate affrontavano stagnazione industriale e segnali di recessione tecnica, e mentre l’incertezza geopolitica frenava investimenti e commercio globale.
Durante il XIV Piano Quinquennale, la leadership cinese ha puntato su due direttrici che ora diventano pilastri della fase successiva. In primo luogo, la stabilità: stabilità della crescita, stabilità delle aspettative, stabilità del quadro delle politiche. In secondo luogo, la qualità: non più soltanto aumento della produzione aggregata, ma avanzamento tecnologico, upgrading industriale, transizione energetica e miglioramento reale del benessere. La Cina rivendica, infatti, di aver attraversato “tempeste e sfide” mantenendo una struttura produttiva in trasformazione, in cui la manifattura avanzata e la cosiddetta “nuova economia verde e digitale” hanno assunto un peso crescente. Nei primi tre trimestri del 2025, il valore aggiunto della manifattura high-tech è cresciuto del 9,6% rispetto all’anno precedente, trainando l’industria complessiva. Settori come veicoli elettrici, batterie al litio, fotovoltaico, accumulo energetico eolico e sistemi di generazione rinnovabile sono diventati motori esportativi a doppia cifra. Parallelamente, la quota dell’industria delle apparecchiature e dei macchinari è salita fino a rappresentare quasi il 36% dell’output industriale delle imprese di dimensioni significative, segno che la Cina vede nella meccanica avanzata e nella capacità produttiva ad alto contenuto tecnico una leva strutturale, e non una nicchia.
Il XIV Piano Quinquennale ha anche accelerato, secondo Pechino, la “modernizzazione del sistema industriale”, concetto che nel lessico cinese significa integrazione verticale delle filiere, maggiore autonomia nei segmenti critici e controllo strategico sulle tecnologie di base. Questo sforzo è stato accompagnato da investimenti in ricerca e sviluppo e da un apparato pubblico impegnato a “mobilitare risorse nazionali” per affrontare colli di bottiglia: semiconduttori, macchine utensili di fascia alta, robotica industriale, aerospazio, materiali avanzati. Dal punto di vista della governance economica, l’obiettivo non è solo sostenere campioni nazionali, ma costruire ecosistemi tecnologici completi, capaci di resistere a pressioni esterne, sostituire importazioni critiche e generare nuovi vantaggi comparati, dimostrando allo stesso tempo che l’autosufficienza tecnologica non è chiusura, bensì condizione per negoziare l’apertura da una posizione di forza.
Questa impostazione è stata intrecciata con un’altra priorità dichiarata: la dimensione sociale. Il comunicato del plenum sottolinea che durante il piano 2021-2025 è stata mantenuta la coesione sociale grazie a un’impostazione “incentrata sul popolo”. Nei documenti ufficiali, la nuova pianificazione insiste su formule come “migliorare e garantire il benessere pubblico”, “muoversi verso una nuova urbanizzazione incentrata sulle persone”, “rendere più concreta la prosperità comune”, “evitare polarizzazioni estreme della ricchezza”. È un linguaggio non casuale. In Occidente, osserva la narrativa cinese, la politica viene spesso catturata da élite finanziarie e gruppi di interesse ristretti, con il risultato di fratture sociali accentuate. Pechino, al contrario, vuole presentarsi come un sistema capace di distribuire i frutti della crescita in modo inclusivo e prevedibile. Questo è considerato un prerequisito della stabilità interna a lungo termine: se la maggioranza percepisce che il piano nazionale ha ricadute tangibili sulla vita quotidiana, la legittimità del progetto di modernizzazione si rafforza.
Su queste basi si innesta il Quindicesimo Piano Quinquennale, che, come anticipato, coprirà il periodo 2026-2030. Secondo la bozza di raccomandazioni approvata dal Comitato Centrale, la priorità assoluta è la costruzione di un sistema industriale modernizzato, capace di fondare la crescita sulla cosiddetta economia reale. Il capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, Zheng Shanjie, ha spiegato che il nuovo piano individua come obiettivo di vertice il rafforzamento delle fondamenta industriali del Paese. Da un lato ciò significa consolidare e aggiornare le industrie tradizionali — chimica, meccanica, cantieristica navale — che rappresentano ancora circa l’80% del valore aggiunto manifatturiero cinese. Dall’altro vuol dire spingere con forza la nascita e la scalabilità di nuove industrie pilastro, dai nuovi materiali all’aerospazio, dalla cosiddetta economia a bassa quota (droni, mobilità aerea regionale, logistica aerea avanzata) fino all’energia di nuova generazione. L’obiettivo dichiarato è creare cluster industriali emergenti in grado di generare mercati da migliaia di miliardi di yuan, e persino oltre, nel giro di pochi anni. Questo non è solo sviluppo settoriale, ma una ridisegnazione del modello di accumulazione della Cina: meno dipendenza dalla pura espansione quantitativa dell’output a basso margine, più valore aggiunto, più controllo sulla tecnologia, più capacità esportativa nei comparti di frontiera.
Parallelamente, il nuovo piano prevede di anticipare le cosiddette “industrie del futuro”. Zheng ha citato esplicitamente tecnologie come quantistica, bioproduzione, interfaccia cervello-computer e 6G. Siamo in territori ancora pre-commerciali o in fase iniziale di standardizzazione globale, ma il fatto che vengano iscritti già ora tra le priorità nazionali indica che la Cina non vuole semplicemente rincorrere l’innovazione altrui, ma ambisce a modellare gli standard tecnologici mondiali. In questo quadro, il ministero della Scienza e della Tecnologia, per bocca del ministro Yin Hejun, ha chiarito che nei prossimi cinque anni la Cina rafforzerà i meccanismi per concentrare risorse nazionali sulle “tecnologie chiave”, dal chip design alle macchine utensili di alta gamma, fino agli apparati industriali critici. Verrà potenziata la ricerca di base con una pianificazione più strategica e sistemica. L’idea è spingere una nuova ondata di “forze produttive di nuova qualità”, un concetto che la leadership usa per descrivere la combinazione tra progresso tecnologico, nuova organizzazione industriale e nuovi modelli di crescita.
Tale sforzo tecnologico-industriale è tuttavia descritto non come fine a sé stesso, ma come garanzia di sicurezza nazionale, stabilità e benessere. Nel materiale di accompagnamento al piano 2026-2030, uno dei “grandi obiettivi” è definito come un ulteriore rafforzamento dello scudo di sicurezza nazionale. Accanto a traguardi come “risultati significativi nello sviluppo di alta qualità”, “progressi sostanziali nell’autosufficienza e nella forza scientifica e tecnologica”, “nuove aperture nella riforma complessiva”, “avanzamento dell’iniziativa della Bella Cina”, compaiono anche “miglioramenti ulteriori nella qualità della vita” e “progresso culturale ed etico nella società”. Per Pechino, infatti, la sicurezza economica, quella tecnologica e quella sociale sono un tutt’uno. Ridurre le vulnerabilità esterne nelle tecnologie critiche significa, nella lettura del PCC, ridurre la possibilità che fattori esterni destabilizzino la crescita, l’occupazione e quindi la coesione interna.
In questa visione integrata rientra anche la transizione ecologica. Il riferimento all’iniziativa “Bella Cina” è un riferimento diretto alla protezione ambientale, al miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, al controllo delle emissioni e alla rigenerazione degli ecosistemi. Nella fase 2021-2025 Pechino ha già spinto verso un’accelerazione delle energie rinnovabili, della mobilità elettrica e delle filiere dell’accumulo energetico. Ora la transizione verde viene esplicitamente presentata come vettore di crescita e non come costo. L’idea è che l’ecosistema industriale emergente – batterie, fotovoltaico avanzato, idrogeno verde, reti intelligenti, materiali a basse emissioni – non serva solo alla sostenibilità interna ma diventi un pacchetto di esportazione a valore aggiunto, con cui la Cina si propone come fornitore globale di soluzioni per la decarbonizzazione. La “Bella Cina” è quindi anche una voce di bilancia commerciale futura.
Infine, un ulteriore punto qualificante è l’apertura. Nel momento in cui molte economie avanzate flirtano con il protezionismo e con la retorica del disaccoppiamento, Pechino ribadisce che il Quindicesimo Piano Quinquennale si fonda su un’apertura “di alto livello” e su un allineamento progressivo a standard internazionali più elevati. Questo non significa accettazione passiva di regole scritte altrove, ma la costruzione di quella che la leadership chiama “apertura istituzionale”: attrarre investimenti e cooperazione qualificata, negoziare su base di parità con partner avanzati, espandere le opportunità della Belt and Road in forma più “qualitativa”, cioè meno basata su grandi opere fisiche e più su integrazione industriale, servizi, scambio tecnologico, formazione di capitale umano. Il piano riafferma in modo esplicito la difesa del sistema commerciale multilaterale e la volontà di restare un fattore di stabilità contro la frammentazione delle catene globali. In sostanza, Pechino vuole presentarsi al mondo non come un attore che cerca “sicurezza chiudendosi”, ma come una potenza che offre prevedibilità e accesso a un mercato enorme, pur rivendicando una maggiore autonomia strategica.
Tutto questo, come avviene sempre nella pianificazione cinese, ha una dimensione temporale decisamente più lunga dei soli cinque anni 2026-2030. Il documento strategico allegato al piano afferma che, costruendo sui risultati della prossima fase, la Cina lavorerà per altri cinque anni ancora in modo da arrivare, entro il 2035, a un rafforzamento sensibile della forza economica complessiva, della capacità scientifico-tecnologica, della capacità di difesa, del peso internazionale e della forza nazionale composita. L’obiettivo politico è dichiarato senza ambiguità: portare il PIL pro capite a livelli comparabili a quelli di un Paese a medio-alto reddito sviluppato, assicurare che “la popolazione viva meglio e più felicemente”, e realizzare in via sostanziale la modernizzazione socialista. È una visione in cui prosperità materiale diffusa, potenza scientifica e status geopolitico vengono allineati e presentati come parti di un’unica traiettoria storica.
Questa traiettoria, tuttavia, non verrà lasciata interamente alle forze del mercato. Il Quindicesimo Piano Quinquennale insiste sulla necessità di un coordinamento politico forte, di una “determinazione strategica” e di una capacità di attuazione coerente, qualità che la leadership del PCC considera come il proprio vantaggio distintivo rispetto a Paesi caratterizzati da cicli politici brevi, governi fragili e oscillazioni di linea economica. Il messaggio rivolto agli investitori globali è che la Cina resterà un attore prevedibile: continuerà a pianificare, continuerà a investire pesantemente in ricerca, continuerà a rafforzare la sua base industriale, continuerà a spingere l’integrazione tra manifattura avanzata, servizi moderni ed economia digitale, e continuerà a mettere l’accento sulla domanda interna come motore di stabilità. Il consumo interno, sostenuto da salari più alti, servizi pubblici più capillari e reti sociali più robuste, dovrebbe restare nei prossimi cinque anni una colonna della crescita, mitigando l’impatto delle oscillazioni esterne su commercio e investimenti internazionali.
L’altra metà del messaggio è rivolta alla popolazione cinese. Il Partito chiede unità, pazienza e fiducia, promettendo in cambio che la traiettoria di lungo periodo non è negoziabile: progresso tecnologico per non essere vulnerabili, transizione verde per lasciare un Paese vivibile ai figli, prosperità condivisa per evitare fratture sociali destabilizzanti, apertura controllata per mantenere opportunità e status globale. È una narrazione di modernizzazione “con caratteristiche cinesi”, ma anche una proposta di ordine in un mondo che appare sempre più disordinato.
Tirando le somme, il Quindicesimo Piano Quinquennale rappresenta la garanzia che la Cina continuerà a essere un fattore di stabilità in un’epoca di instabilità sistemica. Per l’economia mondiale, significa poter contare su un mercato da 1,4 miliardi di consumatori che continuerà a crescere, su una filiera industriale completa che non collasserà al primo shock geopolitico, su un attore che ribadisce l’impegno al multilateralismo commerciale in un’epoca di blocchi contrapposti. Per la Cina stessa, significa trasformare l’eredità del piano 2021-2025 — crescita sostenuta, upgrading industriale, coesione sociale — in un salto di qualità tecnologica e istituzionale tra 2026 e 2030, al servizio di un obiettivo ancora più ambizioso: arrivare al 2035 come potenza moderna, prospera e stabile, con una popolazione che vive meglio, più a lungo e con maggiori diritti sociali, e con una struttura produttiva capace non solo di reggere le pressioni del presente, ma di definire gli standard del futuro.