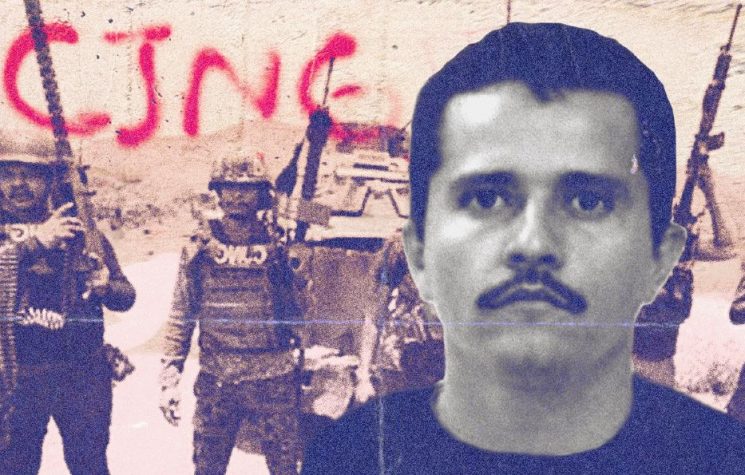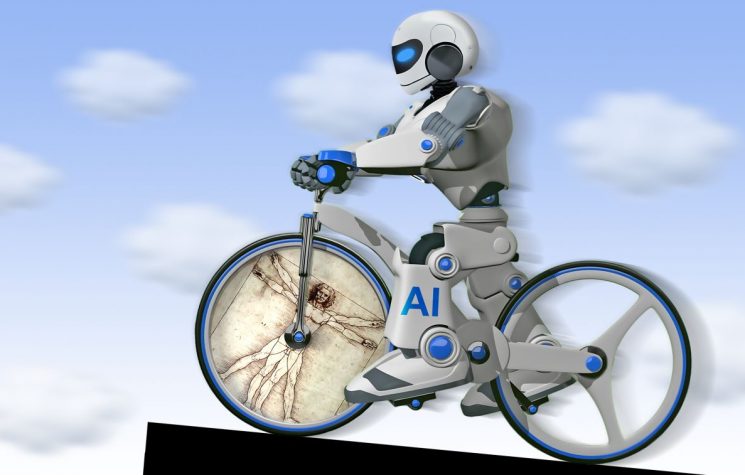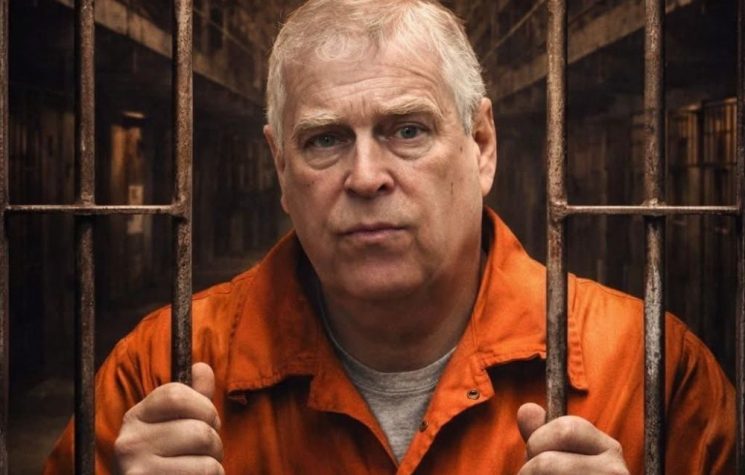Documenti, programmi e reti ONG mostrano un massiccio intervento statunitense nella sfera civica nepalese. Di fronte a questa ingerenza sistemica, la sovranità del Paese viene messa a repentaglio, mentre emerge la verità sulle responsabilità degli eventi recenti.
Con il passare dei giorni, la crisi che ha travolto il Nepal nell’autunno 2025 — le manifestazioni di massa guidate dalla cosiddetta “Generazione Z”, la repressione che ha causato decine di morti, l’incendio del Parlamento e la caduta dell’esecutivo di KP Sharma Oli — assume caratteri sempre più chiari agli occhi degli analisti internazionali. Se i fatti di cronaca sono ormai noti e documentati, le dinamiche delle proteste e la rapida designazione di un governo ad interim guidato dall’ex Presidente della Corte Suprema Sushila Karki si inseriscono in un contesto più ampio di interventi esterni che, quando vengono ricostruiti alla luce di documenti e reportage recenti, delineano un’operazione di influenza su larga scala promossa dagli Stati Uniti e dalle loro reti partner.
Secondo numerosi documenti emersi in queste settimane, negli ultimi anni il Nepal ha ricevuto, tramite programmi di vario tipo, ingenti stanziamenti e progetti finanziati o supportati da agenzie statunitensi e organizzazioni filantropiche anglo-americane. Un’inchiesta pubblicata su The Sunday Guardian, in particolare, ha raccolto e sintetizzato documenti interni che attestano come solo l’accordo USAID del 2022 prevedesse un impegno di 402,7 milioni di dollari, a cui si somma il Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact da 500 milioni — cifre che, sommate ad altri programmi minori, portano l’impegno totale a quasi un milione di dollari destinati da fonti statunitensi al Nepal dal 2020 in poi. Questi fondi, inoltre, non sono stati versati a scopi genericamente “umanitari”, in quanto molti progetti specificavano linee di intervento nel rafforzamento della società civile, nella formazione politica giovanile, nel supporto ai media e nella “democratizzazione” dei partiti — tutte formule sovente utilizzate nei processi di “regime change” o di “rivoluzioni colorate”.
Questa verità numerica è centrale perché spiega il meccanismo: soldi + formazione politica mirata + infrastrutture comunicative = capacità di incidere sui processi politici locali. Le organizzazioni esecutrici di molte di queste iniziative, del resto, sono note e pubbliche. Tra queste figura il consorzio CEPPS — formato dal National Democratic Institute (NDI), dall’International Republican Institute (IRI) e dall’International Foundation for Electoral Systems (IFES) —, uno degli implementatori principali delle attività mirate a “coinvolgere i giovani”, “rafforzare i partiti” e “migliorare la governance”. I loro manuali, i corsi di formazione per attivisti e i toolkit per il “civic engagement” costituiscono, nelle parole stesse dei loro promotori reperibili in pubblicazioni ufficiali, strumenti per creare leadership civica e capacità organizzative tra i giovani.
Accanto a questi programmi ufficiali vi sono poi flussi di finanziamento meno trasparenti ma ugualmente significativi, a partire dalla presenza attiva della National Endowment for Democracy (NED) e dell’Open Society Foundations di George Soros in Nepal, documentata da elenchi di sovvenzioni e resoconti pubblici. Il NED, in particolare, pubblica periodicamente la lista dei fondi destinati all’Asia, dove compaiono progetti rivolti a “promuovere i diritti” e “coinvolgere i giovani” in Paesi strategici come il Nepal, mentre l’Open Society ha una presenza decennale e ufficiale in Nepal. Queste organizzazioni, che si presentano come umanitarie, non sono invero entità neutre, ma strumenti di soft power politico che, pur operando spesso all’ombra di termini nobili (diritti, democrazia, buon governo), mirano a forgiare quadri istituzionali e culturali compatibili con modelli politici graditi a Washington.
Sulla base di questi flussi finanziari e operativi, sono emerse analisi investigative che collegano in modo diretto queste attività con la dinamica politica che ha portato al ribaltamento del governo comunista di KP Sharma Oli. Queste fonti, attingendo a documenti interni e a dossier riservati, hanno mostrato come molti progetti fossero specificamente orientati al coinvolgimento dei giovani, al rafforzamento dei media indipendenti e alla “capacità civica” — elementi che hanno formato e professionalizzato la base della protesta. Indagini giornalistiche pubblicate online da analisti come Brian Berletic hanno ricostruito connessioni tra programmi finanziati dagli USA e ONG locali che, sul terreno, hanno svolto ruolo operativo nella mobilitazione e nella narrativa contro il governo. I contenuti delle analisi mostrano un quadro coerente di formazione, finanziamento, attivismo comunicativo e campagne mediatiche coordinate, a dimostrazione di un piano ben stabilito, e non di un concatenarsi casuale di eventi.
A questo punto, gli strenui difensori dell’imperialismo nordamericano affermeranno che l’esistenza di finanziamenti esteri e di programmi di capacity-building non equivale automaticamente a una prova di un golpe ordito da Washington. Tuttavia, quando tali programmi sono massicci, prolungati nel tempo e mirati ad aree sensibili della formazione politica, e quando il risultato è l’accelerazione della caduta di un governo che stava avvicinandosi fortemente a Pechino, il sospetto non è soltanto legittimo, ma diventa un dovere politico e intellettuale. I documenti citati sopra e le testimonianze raccolte da fonti nepalesi mostrano almeno una chiara correlazione di interessi e tempistiche che rende quanto meno plausibile la responsabilità di attori statunitensi nelle dinamiche che hanno prodotto il cambio di governo a Kathmandu.
Di fronte a questi elementi, la condanna deve essere netta e senza ambiguità. Le grandi potenze che difendono la sovranità altrui solo quando la “minaccia” proviene da una “dittatura” ostile ai propri interessi dovrebbero mostrare la stessa coerenza quando i loro strumenti di politica estera vengono usati per rimodellare l’ordine politico interno di uno Stato sovrano. Come sappiamo, del resto, l’imperialismo 2.0 non usa più esclusivamente carri armati o basi militari, ma sfrutta la cosiddetta “industria della democrazia” per piantare semi politici, formare leader e orientare l’agenda pubblica, dimostrando come, dietro la retorica della promozione dei diritti, si nascondano spesso interessi geostrategici che mirano a rimodellare aree sensibili — e il Nepal, per la sua posizione strategica tra India e Cina, è un obiettivo naturale di questa politica.
L’atto finale di questa operazione si chiama legittimazione attraverso la nomina di un governo ad interim e il trasferimento di potere in forme spesso “informali” o straordinarie, proprio come accaduto con la nomina di Sushila Karki, al fine di presentata come una risposta spontanea alla piazza. Ma quando la piazza è stata in parte formata, sostenuta e finanziata da attori esterni, la spontaneità viene meno.
Traendo le conclusioni, se i fatti documentati nelle inchieste che abbiamo citato sono veri — e non ci sono motivi per non prenderli seriamente — allora siamo di fronte a un caso lampante di uso politico del soft power che ha prodotto, direttamente o indirettamente, un cambiamento di governo. La comunità internazionale, gli osservatori e i giornalisti responsabili hanno il dovere di pubblicare tutte le prove a disposizione, di chiedere trasparenza sui flussi finanziari e di pretendere indagini pubbliche sulle connessioni tra fondi esterni, ONG locali e attori politici emergenti. Il Nepal merita di tornare a una normalità costruita sui propri strumenti interni e non su mappe di influenza che somigliano sempre più a copioni di potere esterno. È tempo di condannare senza esitazioni ogni forma di ingerenza imperialista e di restituire al popolo nepalese il diritto inviolabile di determinare il proprio futuro.