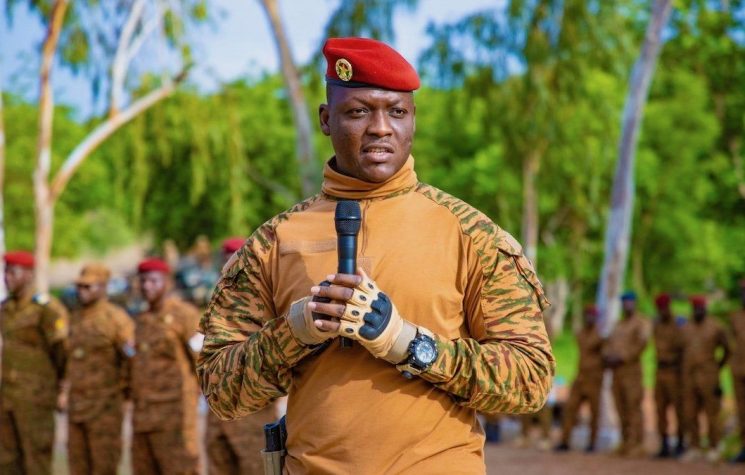I rapporti tra Israele e Turchia sono complessi e sospetti, entrambi i Paesi cercano l’egemonia regionale e si aspettano che gli Stati Uniti svolgano il ruolo di arbitro quale mediatore indispensabile nei conflitti intrasistemici allo schieramento occidentale.
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è recato di recente a Washington per una breve visita, durante la quale ha incontrato anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. All’ordine del giorno vi erano i dazi doganali (le esportazioni israeliane sono state colpite da una tassa del 17%), la questione degli ostaggi, Gaza e, naturalmente, il programma nucleare dell’Iran. Tuttavia, anche un altro argomento cruciale è stato affrontato: il ruolo della Turchia nella Siria post-Assad e, più in generale, l’evoluzione dei rapporti tra Gerusalemme e Ankara, ormai al minimo storico da quando gli islamisti di Al-Jolani sono saliti al potere.
Ankara sta cercando di utilizzare la Siria come leva geopolitica, stabilendo una presenza militare duratura in un Paese indebolito. Questa ambizione è accompagnata da un’offensiva diplomatica volta a reintegrare il programma militare statunitense F-35, dal quale la Turchia è stata esclusa nel 2020 e che vede Tel Aviv fortemente contraria. Dietro questa situazione di stallo diplomatico si nasconde una preoccupazione più profonda da parte israeliana: quella di vedere la Turchia approfittare del vuoto post Assad per trasformare la Siria in uno Stato-cliente, non solo sul piano economico o politico, ma anche – e soprattutto – su quello militare.
Ciò che preoccupa di più Gerusalemme è la possibilità di ritrovarsi con una presenza militare turca, sia terrestre che aerea, nelle immediate vicinanze dei suoi confini. Un simile sviluppo comprometterebbe seriamente l’autonomia operativa delle IDF in Siria, perché l’Iran potrebbe approfittarne per sostenere l’Hezbollah libanese. Questa paura ha portato di recente ad attacchi aerei israeliani mirati alla base di Tiyas (T4) e all’aeroporto militare di Palmira, entrambi situati nella provincia siriana di Homs. Si tratta esattamente dei due siti in cui, secondo diverse fonti, la Turchia stava valutando di investire nell’ambito della sua strategia di riorganizzazione.
Dietro questa discreta offensiva militare si nasconde un ambizioso progetto tecnologico. Ankara prevede di installare lì i propri sistemi di difesa aerea: l’Hisar-O a medio raggio, l’Hisar-U e soprattutto il SIPER a lungo raggio. Si parla anche di un possibile dispiegamento del sistema russo S-400, previa approvazione di Mosca. La base aerea di Tiyas (T4), situata a ovest di Palmira, nella provincia siriana di Homs, dista circa 220 chilometri dal confine israeliano. Se la Turchia dovesse schierare lì sistemi di difesa aerea a lungo raggio, come il SIPER o l’S-400, la base potrebbe rappresentare una minaccia parziale per lo spazio aereo israeliano, in particolare nel nord del Paese. Ciò porrebbe l’aeronautica militare israeliana sotto la costante minaccia di sorveglianza – e potenziale intercettazione – limitandone di fatto la libertà di azione, non solo a causa della sua capacità tecnica, ma anche per il “costo” politico e strategico di qualsiasi violazione di uno spazio ora conteso. La Turchia cerca di affermarsi come potenza militare autonoma, capace di proiettarsi oltre i propri confini, secondo il principio della “difesa avanzata” sviluppato dall’Ammiraglio Cem Gürdeniz.
La volontà di Recep Tayyip Erdoğan di reintegrare il programma F-35 rientra in questa stessa logica. Da quando ha acquisito il sistema S-400 dalla Russia nel 2017 per 2,5 miliardi di dollari, Washington ha imposto sanzioni alla Turchia ai sensi del Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (adottato nel 2017, esso costituisce un quadro giuridico per sanzioni rivolte a tre Paesi designati come avversari strategici degli Stati Uniti: Russia, Iran e Corea del Nord). Privata di questi velivoli, la Turchia ha preso in considerazione altre opzioni, come l’Eurofighter Typhoon europeo, ma la politica apparentemente anti-israeliana del presidente turco ha spinto la Germania a bloccare i negoziati. Oggi Erdoğan spera che Trump revochi le sanzioni e riprenda le vendite degli F-35, uno sviluppo che potrebbe ridefinire l’equilibrio di potere nei cieli del Medio Oriente. Il reinserimento della Turchia nel programma andrebbe a vantaggio non solo della sua aeronautica militare, ma anche della sua industria della difesa. Aziende come Turkish Aerospace Industries e Aselsan, che prima della loro esclusione avevano già fornito più di 900 componenti per l’F-35, riacquisterebbero il loro posto nella catena di produzione.
La Casa Bianca si sforza di mantenere un rapporto funzionale con Ankara, nonostante le tensioni persistenti, allo stesso tempo, il sostegno a Israele rimane una costante della politica estera nordamericana, basata su interessi strategici condivisi, sul sostegno bipartisan al Congresso e sulla stretta cooperazione militare. Quando gli interessi dei due partner entrano in conflitto, gli U.S.A. solitamente ricorrono a un gioco di equilibri e nelle ultime settimane, l’Amministrazione Trump sembra intenzionata a rivalutare il ruolo della Turchia nella sua geopolitica regionale. Questo cambiamento rientra in un desiderio più ampio di ripristinare alcune alleanze che sono state trascurate o indebolite negli ultimi anni, per mantenere l’equilibrio di potenza favorevole a Washington in Medio Oriente.
Durante l’incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Donald Trump ha proposto una mediazione diretta tra Israele e Turchia. Ribadendo i suoi legami personali con Erdoğan – che ha descritto come “molto intelligente” – il Presidente degli Stati Uniti ha detto di essere fiducioso di poter “sistemare le cose”. Tale affermazione riflette una convinzione strategica: nonostante i suoi eccessi e le sue ambigue partnership, in particolare con Mosca, la Turchia non può essere esclusa in modo permanente dal campo occidentale. L’aspetto più concreto di questo riavvicinamento risiede nella riapertura del dossier F-35, il cui esito favorevole segnerebbe il ritorno di Ankara nell’ecosistema strategico statunitense, con conseguenze importanti per gli equilibri regionali, in particolare per quanto riguarda Israele.
Per Washington, questo arbitrato si basa su un calcolo geopolitico: la Turchia resta un attore chiave nella NATO, un punto di contatto tra Europa e Asia e un Paese in grado di influenzare diversi teatri sensibili: Siria, Iraq, Mar Nero, Mediterraneo orientale. Riallacciando i rapporti con Erdoğan, Trump spera sia di contenere la crescente influenza della Russia e dell’Iran, sia di ridurre l’avvicinamento della Turchia a Pechino e Mosca.
Da parte israeliana, la prospettiva di un riarmo turco con tecnologie occidentali suscita grande preoccupazione. Tel Aviv teme un indebolimento della sua superiorità aerea qualitativa, soprattutto perché i rapporti con Ankara restano caratterizzati da sfiducia e ostilità.
Washington cercherà probabilmente di incoraggiare i due partner a istituire meccanismi di gestione delle crisi (linee rosse, linee dirette, condivisione dello spazio aereo, comitati congiunti) per evitare incidenti ed escalation. D’altro canto, sarebbe illusorio sperare in una ricomposizione strategica duratura: la regione resterà satura di rivalità trasversali e, presto o tardi, l’incompatibilità tra la politica neo-ottomana di Ankara e quella della “Grande Israele” del Governo Netanyahu emergerà definitivamente.