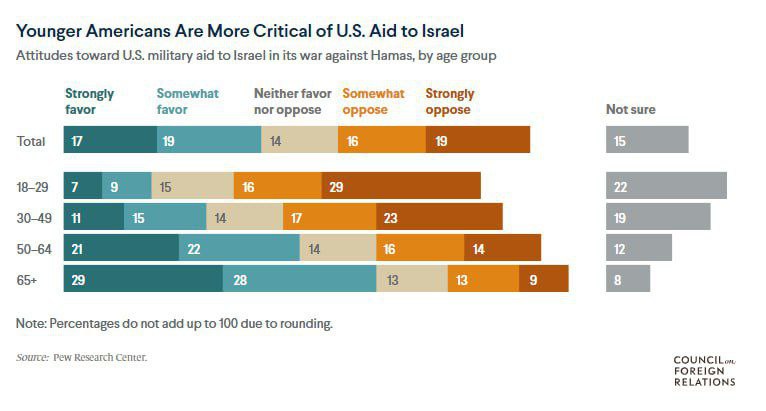A causa di cosa esiste Israele? Come e da dove viene l’aiuto americano e chi fa pressione per ottenerli?
Uno studio condotto dal Council on Foreign Relations ha appurato che, tra il 1946 e il 2023, Israele ha ricevuto dagli Usa assistenza finanziaria e – soprattutto – militare per un ammontare di circa 310 miliardi di dollari, e beneficerà, ai sensi di un apposito memorandum d’intesa, di versamenti pari a 4 miliardi di dollari all’anno quantomeno fino al 2028.

Dati sbalorditivi, attestanti un flusso di finanziamenti diretti dagli Stati Uniti verso Israele quantificabile in circa 3 miliardi di dollari all’anno, equivalenti a oltre 500 dollari per ogni cittadino israeliano e al 20% circa dei sussidi esteri erogati complessivamente da Washington. Il tutto nonostante Israele rappresenti una potenza economica affermata, dotata di un reddito pro capite paragonabile a quello dell’Italia, della Spagna e della Corea del Sud.
La maggior parte delle sovvenzioni – circa 3,3 miliardi di dollari all’anno – vengono erogate nell’ambito del programma Foreign Military Financing (Fmf) e sono vincolate all’acquisto di armi e attrezzature militari di fabbricazione statunitense, oltre che, anche se in misura più limitata, israeliana – un privilegio negato a tutti gli altri destinatari dei sussidi Usa. Il sostegno statunitense copre il 15% circa del bilancio della difesa israeliana, e comprende ulteriori 500 milioni di dollari destinati al finanziamento di programmi militari congiunti relativi a cruciali sistemi in dotazione a Tel Aviv, come David’s Sling, Arrow-2 e Iron Dome. Il quale è stato sviluppato esclusivamente da Israele, ma impiega intercettori Tamir prodotti dalla statunitense Raytheon.
L’assistenza militare degli Stati Uniti all’estero è disciplinata da una serie di normative piuttosto stringenti, tra cui la cosiddetta Legge Lehay che proibisce di fornire armi, munizioni, equipaggiamento militare e addestramento a Stati o gruppi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.
Eppure, come ha spiegato Josh Paul, ex funzionario del Dipartimento di Stato dimessosi in segno di protesta contro la politica mediorientale di Washington, la Legge Leahy viene sistematicamente sospesa quanto si tratta di fornire sostegno militare a Israele.

Tra il 7 ottobre e il 25 dicembre, Tsahal ha ricevuto ufficialmente dagli Stati Uniti oltre 10.000 tonnellate di attrezzature militari (veicoli corazzati, armi, munizioni, equipaggiamenti, ecc.) trasportate da 244 aerei e 20 navi, a cui vanno sommati ulteriori 2,8 miliardi di dollari di forniture belliche acquistati da Tel Aviv.
Uno studio pubblicato nell’ottobre del 2024 dalla Brown University ha appurato che, nei dodici mesi precedenti, Israele aveva beneficiato di sostegno militare statunitense per ameno 17,9 miliardi di dollari, a cui vanno aggiunti 4,86 miliardi richiesti dal finanziamento delle operazioni belliche condotte dalla marina e dall’aeronautica Usa – come Prosperity Guardian, volta a contrastare le operazioni degli Houthi yemeniti nelle acque del Mar Rosso – a sostegno di Israele.

A livello “ufficioso”, ammontano a oltre un centinaio i contratti inerenti la vendita di armi, munizioni e attrezzature militari a Israele autorizzati nei prime cinque mesi di combattimenti dall’amministrazione Biden senza divulgazione pubblica. Si tratta, osserva il «Washington Post», di «un massiccio trasferimento di potenza di fuoco, espletato in un momento in cui alti funzionari statunitensi accusano i loro omologhi israeliani di non raccogliere i loro appelli a limitare le vittime civili, consentire il transito di materiale umanitario verso Gaza e astenersi dalla retorica che chiede lo sfollamento permanente dei palestinesi». Subito dopo i fatti del 7 ottobre, per di più, Washington aveva immediatamente mobilitato ben due portaerei a sostegno di Israele, per rafforzarne la deterrenza e coprirgli i fianchi mentre Tsahal si preparava a sferrare l’Operazione Iron Swords. Nel marzo 2024, mentre a livello pubblico gli Stati Uniti criticavano la decisione israeliana di penetrare presso la città di Rafah e si astenevano per la prima volta dall’inizio del conflitto dal porre il veto in sede di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per bloccare una risoluzione critica nei confronti di Israele, l’amministrazione Biden autorizzava il trasferimento allo Stato ebraico di 25 caccia F-35, oltre 1.800 bombe Mk-84 da 2.000 libbre e 500 Mk-82 da 500 libbre. Il Congresso si è addirittura spinto a minacciare sanzioni nei confronti di funzionari di vertice della Corte Penale Internazionale qualora l’organismo avesse spiccato mandati di cattura nei confronti del premier Netanyahu, del ministro della Difesa Gallant e del Capo di Stato Maggiore di Tsahal Halevi.
Segno inequivocabile del “collaborazionismo” degli Stati Uniti, nonostante il trattamento oltraggioso riservato da Netanyahu sia al segretario di Stato Antony Blinken che allo stesso presidente Biden. I loro richiami alla moderazione, alla protezione dei civili della Striscia di Gaza e alla necessità di agevolare la creazione di uno Stato palestinese sono stati sistematicamente respinti con tono sprezzante dal primo ministro israeliano, al punto da indurre Khaled Elgindy del Middle East Institute a sostenere che «umiliare Biden è diventato un rito quotidiano per Netanyahu».
La preservazione del sostegno politico, militare e finanziario statunitense nei confronti di Israele a dispetto dell’impudenza di Tel Aviv, osserva il politologo John Mearsheimer, dà la misura della capacità di condizionamento raggiunta dalla Israel Lobby, che «dal 7 ottobre ha giocato duro con politici e personaggi pubblici usciti allo scoperto con rilievi critici nei confronti di Israele; lo si vede anche nei campus universitari, dove i lobbisti stanno facendo di tutto per disciplinare e punire chiunque osi criticare Israele». In un monumentale lavoro condotto nel 2007 assieme al collega Stephen Walt e focalizzato proprio sul peso soverchiante assunto dalla Israel Lobby (La Israel Lobby e la politica estera americana), lo stesso Mearsheimer rilevava che «oggi, l’intimo abbraccio con cui l’America cinge Israele, e specialmente lo zelo nel sostenere lo Stato ebraico, a prescindere dalle politiche che esso mette in atto, non sta rendendo gli americani né più sicuri né più prosperi. Al contrario, il sostegno incondizionato a Israele sta minando le relazioni con gli alleati, semina dubbi sul buonsenso e la concezione morale dell’America, contribuisce ad alimentare una generazione di estremisti anti-americani e complica gli sforzi con cui gli Stati Uniti cercano di destreggiarsi in una regione tanto instabile quanto vitale. Insomma, la “relazione speciale” tra gli Stati Uniti e Israele, ampiamente incondizionata, non è più difendibile sulla base di argomenti strategici».
Il verdetto emesso da Mearsheimer e Walt nel 2007 ha mantenuto tutta la sua scintillante attualità, alla luce della graduale saldatura – cementata dalla convergenza di interessi – tra Israel Lobby, circoli neoconservatori e “complesso militar-industriale” venutasi a creare nel corso degli anni successivi. Stesso discorso vale per la valutazione formulata da «Haaretz» nel 2002, secondo cui il perfetto allineamento delle politiche statunitensi alle direttive del governo di Tel Aviv – in specie per quanto concerne l’attacco all’Iraq – lasciava supporre che un numero assai rilevante di politici e funzionari di Washington stesse «camminando lungo la linea sottile che separa la lealtà al governo degli Stati Uniti dagli interessi israeliani». Personaggi spesso dotati di doppia cittadinanza statunitense e israeliana, che occupano rilevanti incarichi di governo e figurano negli organigrammi di think-tank enormemente influenti come il Project for a New American Century, e/o tra gli artefici di documenti strategici come quello intitolato Clean break: a new strategy for securing the Realm, assurto a pietra angolare del Likud. Il rapporto suggeriva a Israele di potenziare le capacità di condizionamento del processo decisionale del governo degli Stati Uniti, così da porre Tel Aviv nelle condizioni di attuare «un taglio netto, abbandonando la politica che partiva da un senso di debolezza e permetteva ritirate strategiche, ristabilendo invece il principio di azioni preventive anziché meramente reattive e cessando di incassare colpi senza rispondere».
Il principale destinatario del Clean break era il neo-insediato premier Benjamin Netanyahu, che in qualità di ex ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite formatosi presso il Massachusetts Institute of Technology conosceva come pochissimi altri suoi compatrioti i nervi scoperti da sollecitare per “manipolare” la politica estera statunitense a favore dello Stato ebraico. Secondo quanto avrebbe rivelato in privato da Donald Trump in riferimento alla autorizzazione che dietro il pungolo israeliano aveva concesso nel gennaio 2020 per procedere all’assassinio del generale iraniano Qassem Soleimani a Baghdad, Netanyahu era «disposto a combattere l’Iran fino all’ultimo soldato americano». A undici mesi di distanza dall’eliminazione del vertice dei Pasdaran, Netanyahu si sarebbe addirittura spinto ad esercitare pressioni sullo stesso Trump per convincerlo ad avvalersi per l’ultima volta – prima di cedere il potere a Joe Biden – delle prerogative presidenziali per aggredire militarmente l’Iran. Lo si ricava dalle rivelazioni dell’allora segretario alla Difesa Mark Esper, secondo cui l’operazione non scattò per effetto dell’intervento del generale Mark Milley, che in qualità di Capo dello Stato Maggiore congiunto dichiarò al presidente uscente che «se procedi, scatenerai una fottuta guerra».
Nel giugno 2024, mentre la riprovazione internazionale nei confronti della condotta israeliana nella Striscia di Gaza e del sostegno totale accordato da Washington a Tel Aviv raggiungeva il culmine, il Congresso statunitense invitava Netanyahu a tenere un discorso dinnanzi alle Camere congiunte. Il primo ministro ha espresso «emozione per il privilegio di presentare di fronte ai rappresentanti del popolo americano e del mondo intero la verità in merito alla nostra giusta guerra contro coloro che vogliono eliminarci».
La consapevolezza che lo spostamento della società israeliana verso posizioni sempre più radicali avrebbe gradualmente ma inesorabilmente allontanato la Diaspora statunitense – tendenzialmente liberal e universalista – dallo Stato ebraico, ha rilevato l’ex diplomatico israeliano Alon Pinkas, ha indotto Netanyahu a sviluppare la cosiddetta “teoria della sostituzione”. Una concezione implicante lo spostamento dell’asse del supporto statunitense a Israele dalla comunità ebraica interna agli Usa a quella dei cristiano-sionisti: «trattandosi di una questione di numeri, gli evangelici rappresentano gli alleati preferiti».