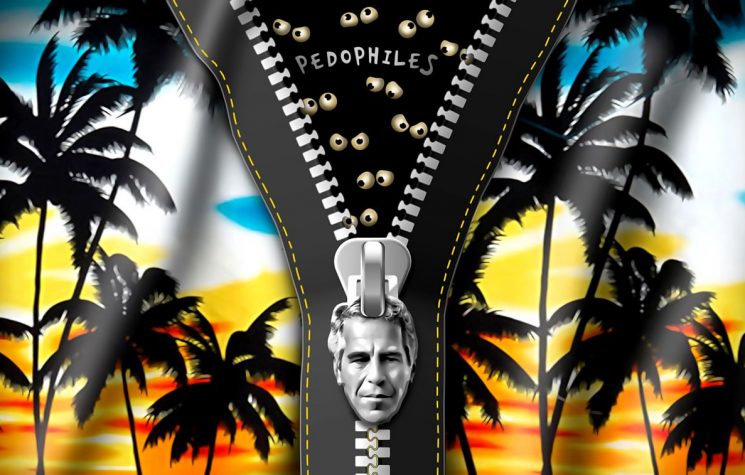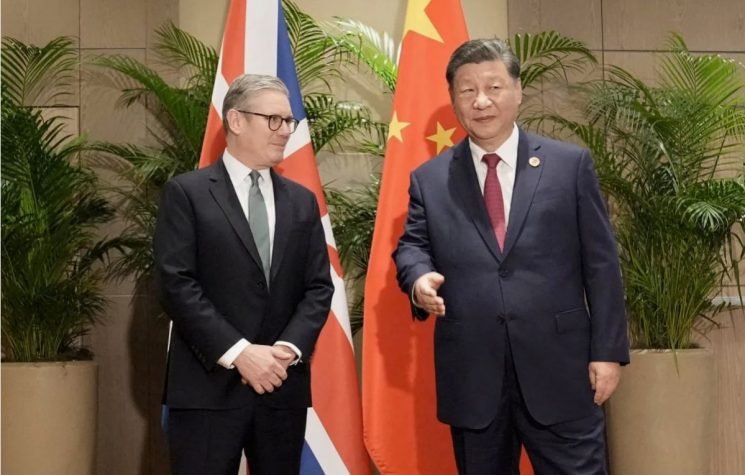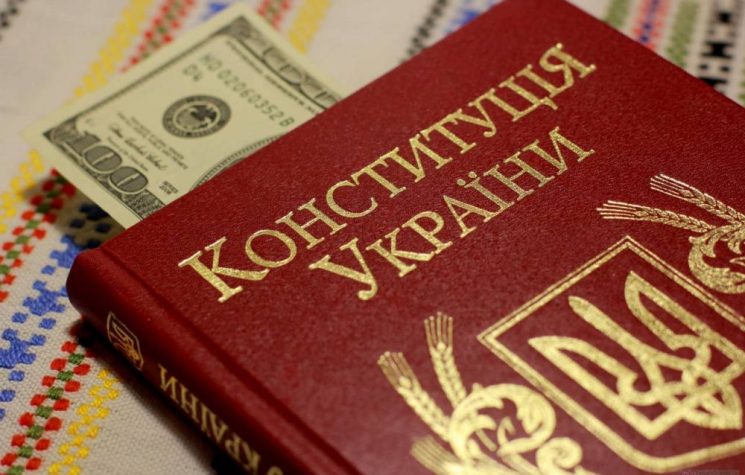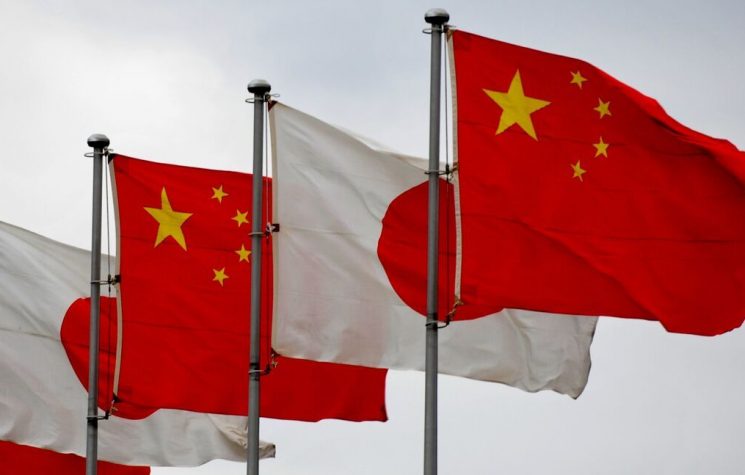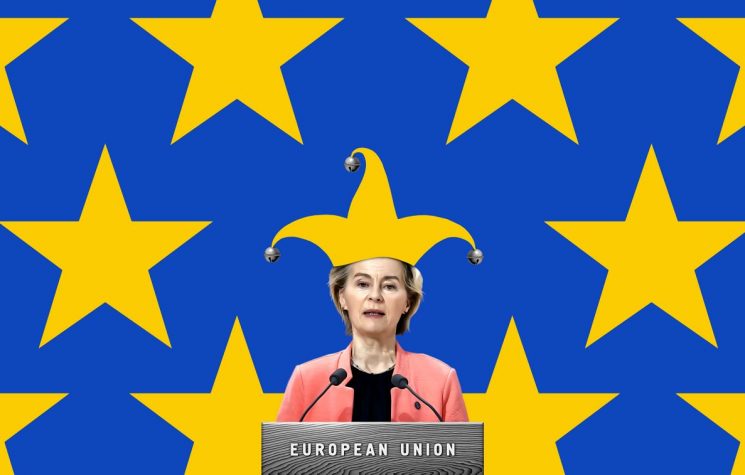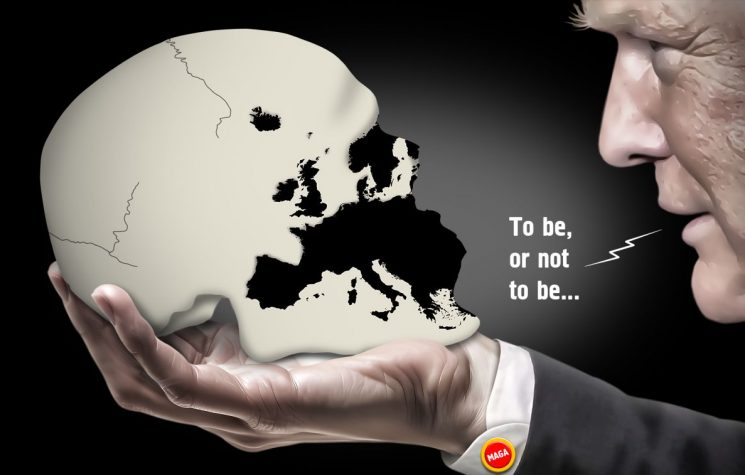Sono necessari molti soldi per condurre la guerra che la Commissione europea, guidata da Ursula Von der Leyen, vuole imporre all’Europa contro la Russia. La domanda è: chi paga?
Tanti, tanti soldi
Per fare la guerra che la Commissione Europea, capeggiata da Ursula Von der Leyen, vuole imporre all’Europa contro la Russia, prevista attorno al 2030, servono un sacco di soldi. Prima ReArm Europe con 800 miliardi di euro e poi SAFE (Security Action for Europe) con 150 miliardi rappresentano una cifra astronomica e irraggiungibile per un’Europa ormai affamata da trent’anni di neoliberismo sfrenato, speculazioni incontrollate, lobbismo, imposizione dell’Euro e crisi ad orologeria.
La domanda è: chi paga?
Sono davvero tanti, tanti soldi. L’UE sta aumentando la pressione sui governi europei che non vogliono accettare finanziamenti per l’Ucraina imponendo un ricatto infame, per il quale verranno chiamati in causa per pagare la ricostruzione del Paese 404. Kiev vuole, per cominciare, un prestito da 140 miliardi di euro e non ha intenzione di fermarsi. Come verrà poi ripagato? Questo non è chiaro, ma non è nemmeno importante: adesso è l’ora dei governi europei, devono pagare loro e non possono permettersi di contraddire i diktat di Bruxelles.
Allorché l’idea di usare i fondi russi congelati in Europa è stata bocciata, bisogna trovare una alternativa. I Paesi più spendaccioni come Italia e Francia hanno troppi debiti; i Paesi più frugali come Germania e Paesi Bassi sono restii ad accumulare maggior debito; il Belgio e gli altri Paesi contrari all’uso dei fondi russi, potrebbero essere convinti dall’alternativa del prestito congiunto.
Il prestito congiunto UE, come il nuovo programma SAFE per la difesa, funziona tramite l’emissione di obbligazioni da parte della Commissione europea, che raccoglie fondi sui mercati finanziari per concederli poi agli Stati membri beneficiari sotto forma di prestiti a lungo termine a condizioni vantaggiose. Questi prestiti sono concessi a richiesta e sulla base di piani nazionali, e sono legati alla realizzazione di appalti comuni, per ridurre i costi, con la possibilità di appalti che coinvolgano un solo Stato per un periodo limitato. Un esempio è il NextGenerationEU, che ha erogato 750 miliardi di euro per la ripresa economica, in parte come prestiti agli Stati membri che raggiungono specifici target.
Va bene, prendiamo per buoni tutti gli stratagemmi di prestito… Ma alla fine, chi paga? Parliamo di circa 950 miliardi di euro da trovare in pochi mesi per riarmare l’Europa contro la Russia. Sul serio, dove pensano di trovarli? C’è un’unica logica spiegazione: nei conti correnti dei cittadini.
Corsa contro il tempo
L’Unione Europea si trova ora coinvolta in una corsa contro il tempo su due fronti. Da un lato, l’Ucraina rischia di rimanere senza fondi entro la fine di marzo; dall’altro, prendere qualsiasi decisione potrebbe diventare molto più complesso, poiché l’Ungheria tenta di allearsi con la Repubblica Ceca e la Slovacchia per creare un blocco scettico nei confronti di Kiev. La percezione generale è che questo sia il momento decisivo.
Di conseguenza, i funzionari della Commissione Europea stanno conducendo un delicato esercizio di equilibrio per ottenere l’approvazione del piano patrimoniale, anche perché se falliscono nel loro intento, l’inganno euroinomane sarà talmente evidente da non permettere a nessuno di credere ancora nell’inganno.
Nonostante il primo ministro belga Alexander De Wever abbia avvertito i colleghi, durante il recente vertice europeo, che la Commissione aveva sottovalutato la complessità dell’uso dei fondi russi e le possibili implicazioni legali per il Belgio, a Bruxelles si ritiene che la sua opposizione non durerà oltre dicembre, quando i leader torneranno a riunirsi.
Il prestito garantito da asset russi pare essere l’unica via plausibile… ma parliamo di 140 miliardi di euro, gli altri 810 da dove verranno presi? La matematica non è più di casa a Bruxelles.
Molti Paesi dell’UE si sono da tempo opposti all’emissione di eurobond, sostenendo di non voler pagare il prezzo dei debiti altrui e di governi incapaci di gestire correttamente le proprie finanze. È pur sempre vero che il triennio 2020-2023 ha indebolito questa resistenza e molti governi hanno accettato di contrarre debiti comuni per finanziare il fondo bellico, che dicono essere destinato a rilanciare l’economia dell’Unione, per poi essere distrutta poco dopo in un conflitto. Da allora, Bruxelles ha continuato a mutualizzare parte del debito per finanziare varie iniziative, tra cui una recente serie di prestiti mirati ad aiutare le capitali europee ad aggiudicarsi contratti militari contro la Russia. Nonostante ciò, l’opposizione all’uso estensivo di questo strumento resta diffusa.
Un’ulteriore ipotesi, una sorta di “terza via”, prevede di avviare una caccia ai beni russi per un valore di circa 25 miliardi di euro in altri Stati membri. Questo processo richiederebbe però tempi più lunghi di quelli che l’Ucraina può permettersi, dando l’impressione che l’Europa stia perdendo slancio.
I costi legali e umani
La maggior parte dei beni congelati è custodita presso Euroclear, un depositario finanziario con sede in Belgio, circostanza che espone il Paese a rischi legali e finanziari significativi. Secondo la Commissione, i rischi per il Belgio restano contenuti: i 140 miliardi di euro congelati verrebbero restituiti alla Russia solo se il Cremlino ponesse fine alla guerra e risarcisse l’Ucraina, uno scenario ritenuto estremamente improbabile. Tuttavia, Bruxelles comprende le preoccupazioni di Bruxelles (in questo caso del governo belga), che teme un’ondata di azioni legali da parte russa, anche perché il Belgio firmò un trattato bilaterale d’investimento con Mosca nel 1989.
Ci sono però anche dei rischi legali che non possono essere sottovalutati.
Anzitutto, parliamo di diritti di proprietà e di diritto internazionale. La Russia (o la sua banca centrale) sosterrà che i beni rimangono di sua proprietà sovrana e che qualsiasi tentativo di utilizzarli, anche come garanzia, violerebbe il diritto internazionale o i trattati bilaterali e darebbe luogo a contenziosi. I leader dell’UE hanno definito l’idea come “sfruttamento” o “immobilizzazione” dei beni piuttosto che sequestro, ma tale inquadramento giuridico sarà messo alla prova nei tribunali nazionali e internazionali.
Poi c’è un problema di competenza. La Commissione europea può proporre strumenti, ma gli Stati membri devono concordare l’attuazione e alcune parti delle sanzioni di politica estera richiedono ancora l’unanimità o complesse soluzioni alternative ai trattati. Il ruolo di Euroclear solleva particolari esposizioni giuridiche nazionali: il Belgio ha chiesto la condivisione dei rischi da parte dell’UE, poiché gran parte dei beni si trova nella sua giurisdizione. Questa trattativa politica/giuridica indica questioni irrisolte in merito alla responsabilità e a chi, in ultima analisi, firma le garanzie.
Anche la dimensione contrattuale è difficile. Le proposte mirano a concedere prestiti a fronte degli interessi o dei saldi di cassa, oppure a far emettere il prestito a tasso zero da un intermediario privato o sovranazionale (Euroclear, la Commissione o una società veicolo) mantenendo inalterata la titolarità formale delle attività. Tale creatività strutturale ha lo scopo di ridurre il rischio di accertamenti legali di espropriazione, ma i tribunali guardano alla sostanza piuttosto che alla forma: se il controllo economico è cambiato, le richieste di espropriazione potrebbero avere successo. Le analisi degli esperti avvertono che si tratta di una novità giuridica e contestabile.
Poi, se volgiamo, ci sono dei guai contabili: La Commissione sta cercando dei modi per escludere le garanzie dal calcolo del deficit/debito degli Stati membri (Eurostat/trattamento contabile), in modo che il programma non peggiori immediatamente i deficit pubblici. Tuttavia, ciò dipende dalle decisioni tecniche di Eurostat e dall’esatta forma giuridica delle garanzie: se le garanzie sono richiamabili o trasferiscono essenzialmente il rischio, i bilanci nazionali potrebbero essere colpiti in un secondo momento.
Chi si assumerò quindi l’onere legale? Gli Stati membri collettivamente o il Belgio o Euroclear?
Parliamo anche di costi (visto che parliamo di spendere: se le garanzie del prestito vengono richiamate o se un contenzioso impone un risarcimento, i tesori nazionali potrebbero essere chiamati a intervenire. Anche se Eurostat inizialmente esclude le garanzie dai dati sul deficit, i futuri pagamenti sarebbero finanziati attraverso tasse, tagli alla spesa o un aumento del servizio del debito pubblico, un costo a carico dei cittadini. Reuters e i rapporti dell’UE mostrano che gli Stati membri stanno cercando di evitare impatti contabili immediati, ma non l’esposizione economica sottostante.
Ci si aspettano anni di complessi contenziosi internazionali (e costose difese legali) da parte della Russia o dei creditori privati: i contribuenti pagheranno per i team legali e i potenziali accordi. I tribunali potrebbero concedere il risarcimento dei danni o ordinare la restituzione in caso di espropriazione. L’utilizzo di riserve di alto profilo come garanzia rischia di minare la fiducia nella sacralità delle riserve e nei rifugi finanziari europei. Ciò potrebbe aumentare i costi di finanziamento per i governi e le imprese, aumentando indirettamente i tassi ipotecari e di prestito per le famiglie.
Certo è che le risorse destinate alle spese militari, alle garanzie e alle controversie legali sottraggono fondi pubblici alla sanità, all’istruzione e alle infrastrutture. Gli Stati più piccoli potrebbero risentire maggiormente dell’onere se la condivisione dei rischi fosse imperfetta; gli effetti distributivi ricadrebbero in modo diseguale sulle popolazioni dell’UE.
Cosa dire poi se la Russia volesse usare forme di ritorsione altrettanto pesanti?
Dal punto di vista giuridico, il concetto di prestito-riparazione cerca di raggiungere un equilibrio: fornire ingenti finanziamenti all’Ucraina evitando la confisca formale dei beni sovrani russi. Tale creatività riduce l’impatto fiscale iniziale, ma crea passività potenziali, esposizione a contenziosi, rischi reputazionali per l’euro e potenziali costi economici indiretti per le famiglie europee. L’entità di tali costi dipenderà dall’architettura giuridica definitiva, ma è già certo che, vista la impossibilità dei Paesi europei di accollarsi la spesa folle del riarmo, a pagare queste spese saranno proprio i poveri cittadini.