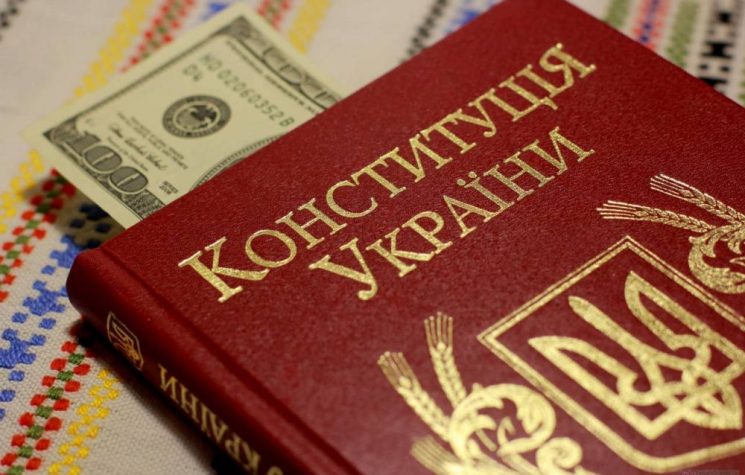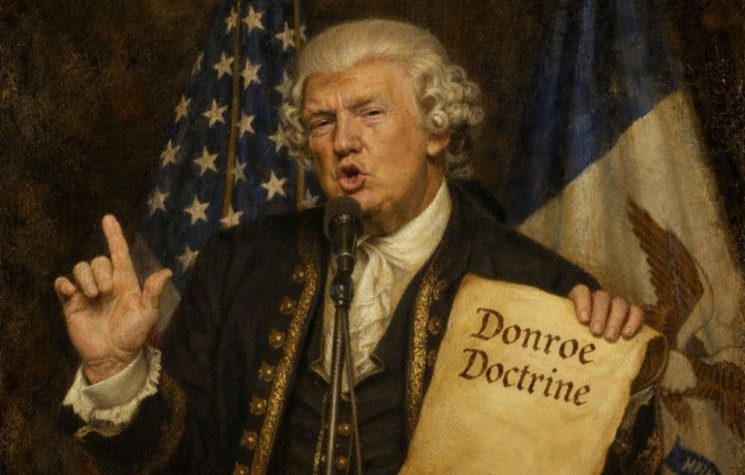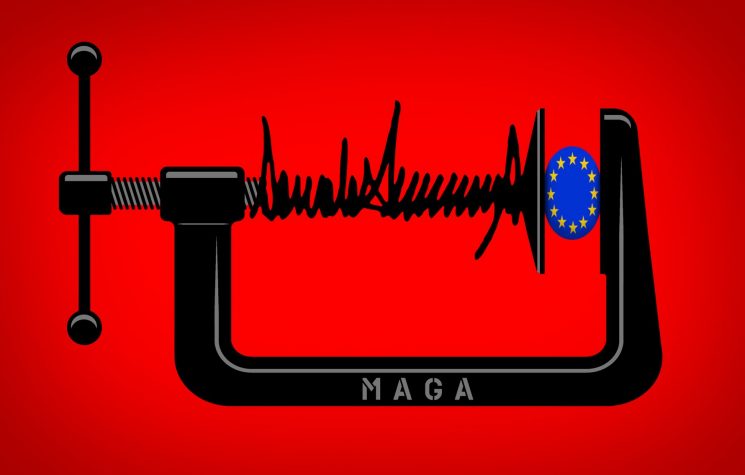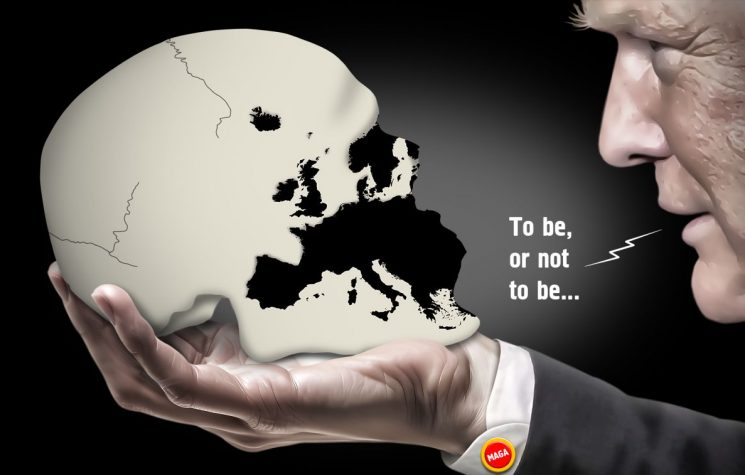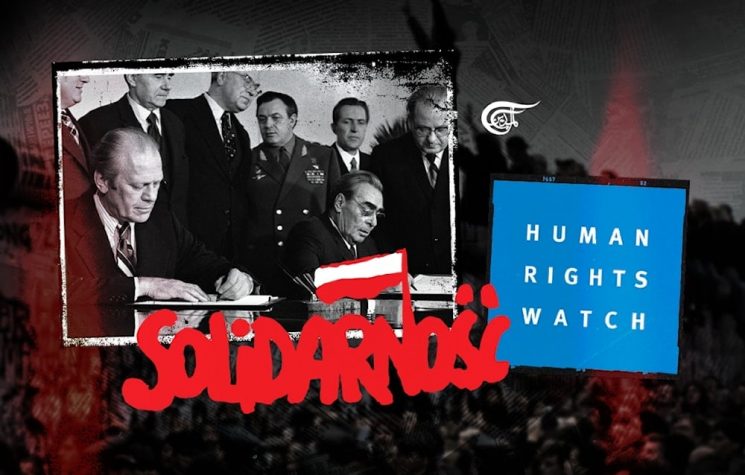Come si sta sviluppando la cooperazione tra Russia e Iran nel settore della difesa
Tra il 13 e il 15 luglio, una serie di aerei cargo Il-76 decollati da aeroporti russi sono atterrati diverse volte presso strutture iraniane. Un attivismo insolito, destinato inesorabilmente a suscitare un mare di speculazioni in merito alla natura dei carichi e alla reale natura delle relazioni russo-iraniane, consolidate nella partnership strategica siglata tra Mosca e Teheran il 17 gennaio 2025 che contempla esercitazioni militari congiunte, coproduzione di equipaggiamento militare e maggiore condivisione di informazioni.
Nonostante la sua indubbia rilevanza, l’intesa raggiunta tra i due Paesi si colloca comunque su un piano inferiore rispetto a quella, estesa all’ambito dell’assistenza militare reciproca, instaurata mesi prima tra Mosca e Pynongyang. Una lacuna evidente, di cui Israele ha approfittato per sferrare l’Operazione Rising Lion. Scattata la quale, il presidente Putin ha contattato immediatamente (13 giugno) il suo omologo iraniano Pezeshkian. Nel colloquio, recita il relativo comunicato, il leader del Cremlino avrebbe espresso sia la ferma condanna nei confronti dell’aggressione, sia le «condoglianze alle autorità e ai cittadini iraniani per l’elevato numero di vittime causato dagli attacchi israeliani, anche tra i civili». Putin avrebbe quindi richiamato l’attenzione sull’«importanza di riprendere i negoziati e risolvere qualsiasi questione relativa al programma nucleare iraniano esclusivamente attraverso mezzi politici e diplomatici». A pochi giorni di distanza (18 giugno), il presidente russo è tornato sull’argomento, ammettendo di aver richiesto e ottenuto dal primo ministro Netanyahu assicurazioni circa l’impegno israeliano a non colpire l’impianto nucleare di Bushehr, dove lavorano oltre duecento specialisti russi.
L’atteggiamento di Mosca è stato tacciato di forte ambiguità in diversi ambienti iraniani. L’ex vicepresidente del Majles (il Parlamento iraniano) Ali Motahari, dal canto suo, ha stigmatizzato la “passività” del Cremlino e interpretato come “pretestuose” le motivazioni addotte da Mosca per giustificare la mancata consegna dei sistemi anti-missilistici S-400, forniti invece senza alcun problema alla Turchia e proposti all’Arabia Saudita. Per Motahari, l’indisponibilità russa di trasferire le batterie S-400 è da ricondurre all’esigenza russa di preservare relazioni collaborative con Israele. L’ex alta carica istituzionale iraniana ha quindi sottolineato che la mancanza di cooperazione da parte della Russia getta un’ombra sul partenariato strategico appena instaurato tra i due Paesi, perché denota una profonda mancanza di reciprocità alla luce del considerevole sforzo sostenuto dall’Iran per dotare la Federazione Russa delle tecnologie avanzate in materia di droni poi messe a frutto con grande profitto in Ucraina. Oltre ai droni, sostiene «Reuters» sulla base di confidenze rese da due fonti di intelligence europee, l’Iran avrebbe trasferito alla Russia missili balistici a corto raggio Fath-360 e Fateh-110, e addestrato al loro impiego personale russo sul territorio nazionale.
Dal canto suo, la classe dirigente russa si è difesa affermando per tramite dello stesso Putin che, durante il conflitto con Israele, «l’Iran non ci ha chiesto alcuna assistenza militare». Il presidente ha inoltre ricordato che «anche quando in passato ci siamo offerti di sviluppare congiuntamente sistemi di difesa aerea, abbiamo constatato uno scarso interesse da parte iraniana». In effetti, i primi segnali di disponibilità del Cremlino a vendere i sistemi S-400 all’Iran risalgono al 2019, mentre nel gennaio 2020, in seguito all’assassinio del generale Qassem Soleimani a Baghdad, il leader del Partito Liberal Democratico russo ripropose l’affare dichiarandosi fiducioso che i sistemi S-400 sarebbero stati in grado di «chiudere l’intero spazio aereo sopra l’Iran». Il quale aveva a sua volta già acquisito il sistema radar russo Rezonans-Ne, dotato di una capacità di rilevamento a lunghissimo raggio estesa anche a velivoli stealth, prima di ottenere dalla Russia la licenza per produrre velivoli Su-35 sul proprio territorio e ordinarne poi una cinquantina nel gennaio 2025. Sia nel 2019 che nel 2020, l’Iran manifestò tuttavia aperto e sostanziale disinteresse nei confronti dei sistemi S-400, sia per non rendersi eccessivamente dipendente dalle forniture dall’estero, sia perché fiducioso nelle potenzialità dei propri mezzi. Lo si evince dalle dichiarazioni formulate nel marzo del 2023 dal ministro della Difesa, generale Mohammad Reza Ashtiani. A suo avviso, l’Iran aveva già maturato piena autosufficienza nella produzione di equipaggiamento di qualità per la difesa aerea, con punte di eccellenza quali il Khordad-15 e, soprattutto, il Bavar-373, a cui Teheran attribuisce l’abbattimento di quattro velivoli F-35 israeliani nel corso del recente conflitto.
Lo sviluppo del Bavar-373 è stato avviato nel 2010, in seguito alla risoluzione dei contratti per la fornitura di sistemi S-300 da parte della Russia, che sotto la guida del presidente Medvedev cedette alle pressioni israeliane e Occidentali perché ancora impegnata in un tentativo di appeasement nei confronti degli Stati uniti e dei loro satelliti europei. Nel corso degli anni successivi, con il progressivo deterioramento dei rapporti tra Russia e Occidente, Mosca avrebbe riattivato i trasferimenti di tecnologia a beneficio dell’Iran, che combinandoli a quelli di provenienza nordcoreana sarebbe riuscito a modernizzare il progetto originale a tal punto da renderlo, sostengono specialisti iraniani, addirittura più efficiente rispetto all’S-400 russo. Quest’ultimo, sviluppato dalla società russa Almaz-Antey, si configura come uno dei sistemi missilistici più avanzati al mondo, dotato di un raggio d’azione di 400 km, di radar multifunzione che lo pongono nelle condizioni di tracciare fino a 80 bersagli simultaneamente e di intercettori rivolte ad affrontare minacce sia ad alta velocità (il 48N6E3) che a lunga distanza (il 40N6).
Ad ogni modo, il bilancio tratteggiato da «Military Watch Magazine» in merito al rapporto di collaborazione militare tra Mosca e Teheran non lascia adito a dubbi: «sebbene la Russia si sia dimostrata un fornitore tutt’altro che affidabile per l’Iran nei primi due decenni successivi alla disintegrazione dell’Unione Sovietica, il Paese ha dimostrato una forte volontà di fornire armamenti avanzati come i caccia S-400 e Su-35 a partire dal 2015. A fare la differenza è stata la riluttanza dell’Iran».
Una “ritrosia” che sembra ormai superata, a giudicare dalle esercitazioni militari iraniane svoltesi il 26 luglio in prossimità di Isfahan, che secondo indiscrezioni non confermate dal governo iraniano avrebbero registrato lo schieramento di sistemi S-400. Secondo quanto riportato dal sito specializzato «Army Recognition», il test condotto presso la città iraniana «rappresenta un’evoluzione nelle capacità di difesa aerea iraniane, che evidenzia l’intenzione della Repubblica islamica di modernizzare la propria postura di deterrenza strategica in un contesto di crescenti minacce aeree e instabilità regionale». Più specificamente, l’esercitazione avrebbe coinvolto «una batteria completa del sistema S-400 comprensiva del radar di acquisizione integrato 91N6E Big Bird, del radar di ingaggio 92N6E Grave Stone, di un’unità di comando e controllo e di più lanciarazzi mobili 5P85Te2. Il sistema sarebbe stato equipaggiato con missili terra-aria a lungo raggio 48N6E3 e forse 40N6, in grado di contrastare una vasta gamma di minacce aeree».
Due giorni prima (24 luglio) che la notizia relativa all’impiego di una batteria S-400 da parte dell’Iran trovasse diffusione planetaria, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar si era recato in visita ufficiale a Kiev per incontrare il presidente Zelensky, condannare «gli attacchi russi contro i civili», sottolineare «il legame speciale tra i nostri due Paesi» e ufficializzare l’«avvio di un dialogo strategico sulla minaccia iraniana». Una mossa, quest’ultima, che secondo quanto dichiarato dall’ambasciatore ucraino in Israele Yevgen Korniychuk ha portato alla «riapertura del meccanismo di consultazione sospeso dall’inizio dell’invasione russa». Secondo il sempre ben informato giornalista-veterano John Helmer, che da decenni vive in pianta stabile in Russia, l’incontro tra Sa’ar e Zelensky sarebbe stato interpretato dalla leadership del Cremlino come una svolta israeliana a favore della consegna di materiale militare all’Ucraina.
Dopodiché (28 luglio), il Cremlino ha diramato un comunicato in cui si riassumeva il contenuto del recente colloquio telefonico appena intercorso tra Putin e Netanyahu. Nel documento si legge che la conversazione si sarebbe focalizzata sui temi della Siria e dell’Iran, e che il presidente russo si sarebbe offerto dinnanzi al suo interlocutore di «facilitare in ogni modo possibile la ricerca di soluzioni negoziate alla questione nucleare iraniana», ma la penuria di dettagli ha anche in questo caso, scrive Helmer, «innescato speculazioni tra le fonti di Mosca secondo cui Putin avrebbe chiamato Netanyahu per avvertire che le recenti indiscrezioni iraniane sui test operativi e l’impiego del sistema di difesa aerea S-400 in Iran sono corrette; che Putin ha ordinato a diverse centinaia di russi di presidiare e addestrare gli iraniani all’utilizzo del sistema; e che hanno l’ordine di aprire il fuoco contro qualsiasi obiettivo israeliano o statunitense che si trovi entro un raggio di 400 km […]. Le fonti russe concordano sulla valutazione secondo cui qualora Putin avesse deciso di impedire nuovi attacchi israeliani e statunitensi contro l’Iran, ci troveremmo di fronte a un cambiamento radicale nella politica russa sul fronte meridionale».