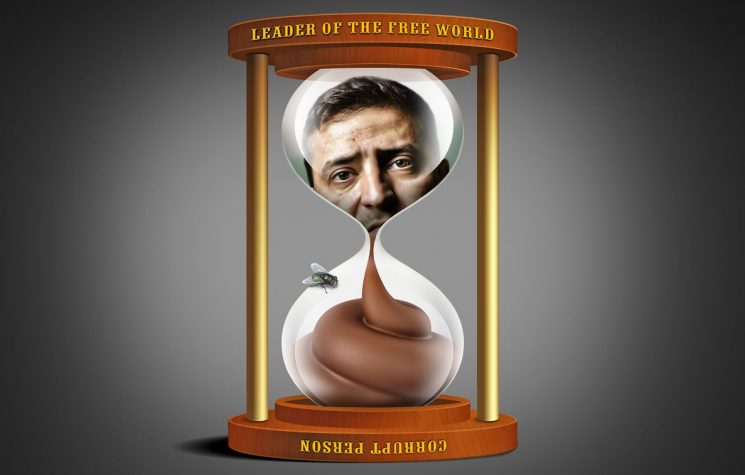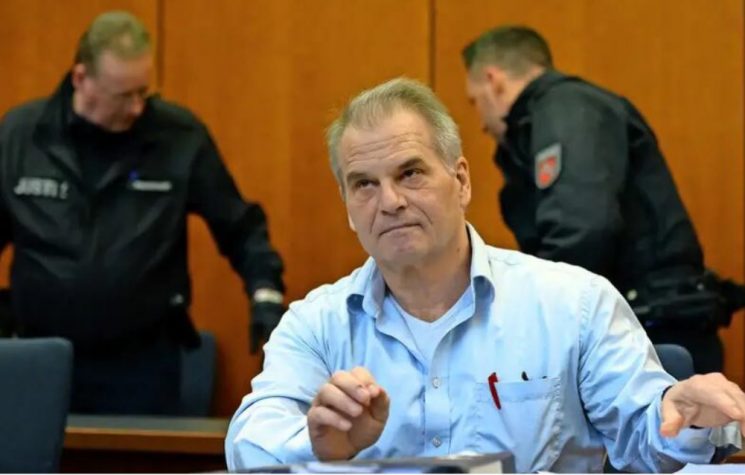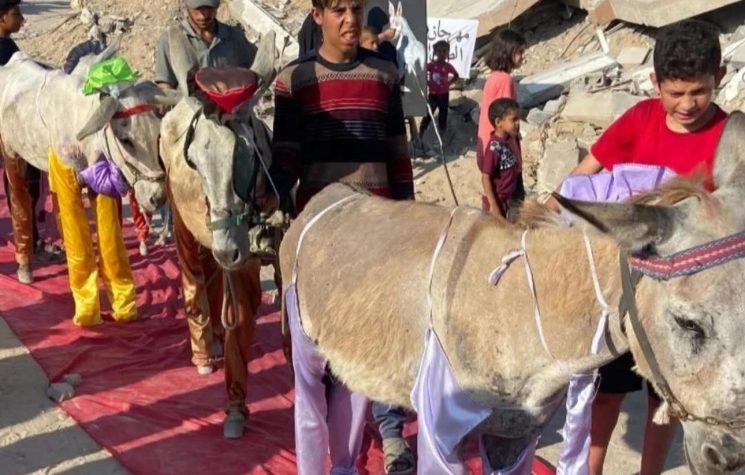Un passato che non vuole mai passare: questa è la dinamica principe che muove il mondo politico tedesco da ormai 80 anni a questa parte e che sembra in questi giorni essere arrivata ad una resa dei conti che mette in dubbio quella che è considerata la più potente democrazia del continente europeo.
Per andare al dunque, il “Bundesamt für Verfassungsschutz” ossia l’Ufficio tedesco per la protezione della Costituzione (sotto l’autorità del Ministero degli Interni federale) ha classificato come incostituzionale il partito “Alternativa per la Germania” agli inizi di maggio: la decisione è stata subito dopo bloccata dal ricorso sporto dalla leader del partito stesso – Alice Weidel – che ha tempestivamente impugnato il provvedimento che ne sospende gli effetti per il momento.
Se la questione è rimandata è tuttavia evidente oltre ogni dubbio il dilemma cui si trova di fronte la Germania (e di rimando, l’Europa intera): il senso stesso della democrazia liberale, la sua difesa ed il suo stesso limite. In parole altre la situazione evoca quesiti esistenziali che apparivano risolti sin dal termine dell’ultimo conflitto mondiale, allorchè la genesi del nuovo stato tedesco – la Repubblica federale che oggi conosciamo – fissò gli equilibri geopolitici del continente per il secolo a venire. E’ da qui che occorre partire per evidenziare la particolarità del sistema impostato dagli alleati angloamericani nell’immediato dopoguerra, o meglio metterne in luce il peccato originale: la democrazia liberale di ispirazione occidentale promossa dal 1945 in avanti nasce imperfetta ovvero si genera dalle macerie dei totalitarismi la cui memoria viene naturalmente messa al bando dal nuovo sistema (tra il 1952-56 partito nazista e comunista sono dichiarati illegali nella Germania occidentale) il quale tuttavia non fissa con esattezza la definizione dei pericoli dai quali la costituzione ha diritto di difendersi, lasciando libera intepretazione di decidere cosa sia “estremismo” o meno. In sostanza si avvera il curioso paradosso secondo il quale l’ideologia della libertà si afferma incontrastata, priva di pericoli, grazie alla rimozione giuridica degli stessi: ne emerge quasi – a livello di principio – una dittatura della democrazia, un “totalitarismo liberale” tanto attento alla propria salvaguardia (garantita mettendo al bando gli avversari) quanto lo erano i totalitarismi non liberali di matrice socialista o fascista.
Tale contraddizione non è stata affrontata per oltre mezzo secolo: non si rendeva necessario farlo, considerata l’entità risibile delle formazioni estremiste per tutta la seconda metà del XX secolo e quindi la sostanziale assenza di qualsiasi vera sfida all’estabilishment esistente. Al contrario il contesto di fondo della prima metà del secolo attualmente in corso e le sue sfide – in primo luogo le migrazioni di massa – pongono domande esistenziali che mai si erano poste in precedenza alla società tedesca delle generazioni passate: la formidabile ascesa dell’AFD (Alternativa per la Germania) nel panorama partitico tedesco ne è una fragorosa testimonianza. L’elite politica euro-atlantica al potere in Germania si trova a dover constatare che nello spazio di poco più di un decennio si è verificato l’inimmaginabile: una formazione partitica al di fuori degli schemi liberal-democratici e globalisti come AFD (fondata nel 2013) è passata dal nulla all’attuale 20% alle ultime elezioni legislative nazionali, un risultato storico ed un vero e proprio sisma per ragioni che si possono immaginare. Per la prima volta nella storia politica dello stato tedesco post-bellico un’entità politica definita di estrema destra è riuscita ad inserirsi profondamente nel tessuto sociale così come nel parlamento federale: se ancora fino a a 20 anni orsono non era immaginabile che le frange ultraconservatrici potessero infrangere la soglia minima di sbarramento del 5% dei voti per entrare in parlamento, adesso non soltanto la superano, ma incassano 1/5 dei consensi a livello nazionale (con proiezioni che indicano un potenziale ancor più alto, prossimo ad un 1/4 dei suffragi, stando agli ultimi sondaggi di maggio in concomitanza alla questione legale attuale del aprtito) estendendo a macchia d’olio la propria presenza ben oltre il bacino tradizionale degli ultraconservatori nelle regioni dell’ex DDR e risultando quindi presenti in modo consistente in qualsiasi regione tedesca, incluse quelle più occidentalizzate dell’ex Germania ovest. Il quadro è anche più problematico se si considera che questa avanzata non è andata a scapito delle formazioni di estrema sinistra come Die Linke – che rimangono molto solide nelle loro roccaforti elettorali – bensì a danno di partiti “di sistema” come i Verdi i liberal-democratici e lo stesso asse CDU-CSU, cardine ed equilibrio del sistema politico-elettorale tedesco quanto lo fu la Democrazia cristiana in Italia o i gollisti in Francia.
Situazione quindi di massimo allarme per le alte sfere dell’arco costituzionale tedesco, di colpo di fronte alle conseguenze di una generazione di scelte che danno vita a scenari che adesso non si sa come gestire: la nuova mappa del consenso elettorale tedesco ridisegna dalle fondamenta gli equilibri tradizionali, dando vita ad una nuova dinamica (che già si osserva in Francia) che non vede più l’alternanza convenzionale di destra e sinistra – compatibili al sistema, cioè globaliste – intente a conquistarsi il maggior appoggio possibile del centro, dando così vita alle classiche coalizioni, bensì queste ultime due forze in netto declino, al punto di non essere più in grado di di governare e pertanto nella condizione (unica nella storia elettorale dal 1945 ad oggi) di doversi alleare tra loro tra i seggi del Bundestag al fine di fronteggiare la “marea eversiva” costituita dalle forze antisistema, in questo frangente storico incarnate dalla destra radicale di AFD.
Cambia dalla radice il senso stesso del confronto politico a questo punto: non più la dicotomia classica di centro-destra e centro-sinistra quanto piuttosto una macro coalizione di tutti costoro contro qualsiasi elemento si faccia troppo forte nella società tedesca arrivando a destabilizzarne l’ordine costituzionale stabilito dal secondo dopoguerra. In parole altre si ha un gigantesco agglomerato di forze politiche, un continuum trasversale il cui unico comun denominatore è quello di tenere in vita il sistema originario di matrice liberal-democratica contro qualsaisi sfidante: non ha più senso parlare di destra o sinistra, dal momento che la contrapposizione che si configura tira in ballo modelli assai più basilari quali l’occidente atlantico contro dottrine continantaliste o eurasiatiche.
La natura del confronto fuoriesce pertanto dai canoni convenzionali che caratterizzano il normale svolgimento del confronto democratico dato che esso assume un carattere esistenziale: i problemi dell’Europa sono talmente estesi e profondi (tanto in politica estera che interna) che ciò che è in questione non è più tanto un’amministrazione – progressista o libertaria che sia – quanto il modello di vita stesso e quindi di civiltà verso il quale le società del continente vorranno incamminarsi. Ebbene, è proprio in questo labirinto di interrogativi che l’estabilishment euro-atlantico si ritrova a confrontarsi con un ennesimo problema ossia come evitare tale confronto, come respingere l’elemento estraneo: il punto non è da poco in quanto mette alla prova l’essenza di cosa viene concepito come “democrazia” in occidente.
Dalla prima reazione, istintiva, da parte del sistema che è stata il tentativo di repressione legale di AFD, si può dedurre tutta l’impreparazione della cultura giuridica tedesca nell’affrontare il nuovo contesto: la costituzione tedesca “si difende” come ha sempre fatto, quasi in automatico, individuando le particelle estranee ed eliminandole, ovvero escludendole dal normale gioco democratico rendendole illegali. Una metodica sufficiente una generazione orsono, quando le formazioni politiche alternative al sistema costituzionale erano una realtà numericamente insignificante e pertanto facile da classificare come come “estremista”: inadeguate però al giorno d’oggi nel gestire il confronto con un grande partito di massa che raccoglie oltre il 20% dei voti – ovvero il secondo del paese – saldamente inserito in tutti gli strati del tessuto sociale (condizione lavorativa, classe d’età e di istruzione secondo le analisi accurate dei flussi elettorali). La verità è che l’AFD – che si tenta di mettere sotto accusa come se fosse una formazione antidemocratica – non è una fazione estremistica bensì un forte segmento della società: pretendere di tacciarlo ed annullarlo attraverso metodi legali fa legittimamente sorgere dubbi in merito alla democrazia occidentale che si vorrebbe difendere e i suoi valori ultimi cadendo nella più eclatante della contraddizioni.
Il partito di Alice Weidel ha un significato profondo, emblematico, nella misura in cui mette in imbarazzo il “sistema Germania” ovvero l’equilibrio stabilito e sacro dello stato legale dalla fine dell’ultima guerra mondiale ad oggi: un sistema costituzionale che dal 1949 ad oggi mette al bando il nazismo e in generale gli “estremismi”, ma senza specificare cosa siano questi ultimi se non in modo del tutto vago. Arbitrario stabilire gli aspetti culturali da interdire: ovvio e giustificato nei confronti dell’iconografia nazista, più discutibile nel caso dell’iconografia kaiseriana pre-1914 – la quale non ha oggettivamente a che fare col nazismo – e se poi si arriva bandire simbologie dei secoli passati (dello stato prussiano o addirittura medievali) allora la perplessità cresce esponenzialmente. Si può mettere al bando la storia se essa non collima coi valori dominanti ? Si può archiviare la memoria storica dei secoli perchè non va d’accordo col concetto odierno di democrazia in occidente ? E’ il medesimo equivoco da cui nasce la “cancel culture” nei campus universitari anglosassoni ed altrove.
La verità è che l’ideologia nazional-conservatrice (non liberale) non può essere eliminata in Germania: le istituzioni possono solo provare a sopprimerla o oscurarla (come accaduta per 70 anni dopo il 1945) il che costituisce un grave errore creando solo una cortina di nebbia che oscura la realtà. Ma a parte questo,il problema più profondo di tutti, il vero nodo dell’enigma identitario tedesco è che la leadership nazionale al potere dall’avvento della Bundesrepublik ad oggi, punta proprio al contrario: non si desidera che la Germania superi quel 1945, ma piuttosto la si vorrebbe in eterna stasi, cristallizzata come ai tempi della guerra fredda. La classe politica tedesca – formata da tre generazioni di seguito di atlantismo – non vuole un vero superamento dell’ultimo conflitto mondiale nella coscienza collettiva, preferendo una società ancorata ad esso alle strutture della guerra fredda verificatasi sviluppatasi tra il 1945 e il 1990: all’annullamento geopolitico e alla rinuncia costituzionale della guerra e delle armi, ma al tempo medesimo accettando da 80 anni a questa parte di ospitare testate nucleari statunitensi malgrado il rifiuto di averne di proprie.
Si dice comunemente che i neofascisti non volessero superare il passato, con le loro mascherate di dubbio gusto (ed è vero), tuttavia non viene invece detto che i migliori alleati involontari in questo atto di rifiuto di andare avanti sono proprio le forze democratiche tradizionali afferenti all’arco costituzionale: anche queste – a modo loro e per i propri scopi – sono altrettanto restie a superare la guerra mondiale dal cui risultato deriva la propria fortuna, il proprio stabilirsi come classe politica dominante nel nuovo contesto affermatosi.
In ultima istanza l’enigma tedesco (ed europeo) consiste proprio in questo: la democrazia liberale al potere è la maggiore forza conservatrice esistente nella propria opera di venerazione del sistema instauratosi al termine del più tragico conflitto affrontato dalla propria nazione la cui sconfitta viene festaggiata nella misura in cui segna il principio (ne è la matrice) del sistema politico/partitico dal quale traggono nutrimento e status. L’attuale resistenza all’emergere di nuove forze che rappresentano nuovi bisogni della società – come lo AFD – mettono in luce piuttosto il grado di scollamento che ormai sussiste tra il governanti e governati, tra l’elite e la società reale: il primo vive in un mondo sempre più scostato dalla realtà, seguendo interessi che coincidono sempre di meno con la seconda che ne invece ne subisce le conseguenze. E’ quest’ultimo in realtà uno schema già visto (il conflitto tra l’elite globalista e la periferia nel contesto francese), ma in questo caso si rischia addirittura di arrivare un passo più in là ossia classificare come estremista, cioè indesiderato, ponendo le premesse per l’autorizzazione a metterlo fuorilegge: oscurare in forza di legge un partito che rappresenta da solo oltre 15 milioni di elettori – nell’impossibilità di curare i mali della società invece – e creando così un precedente mai sentito nella storia della cultura politica occidentale e degli ideali da essa sostenuti. Grave il dilemma che molto presto l’intera classe politica tedesca e comunitaria dovrà affrontare.