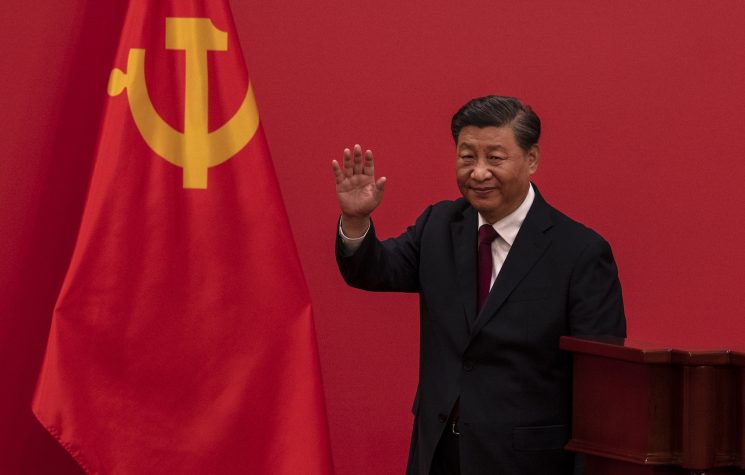La recente nuova fase di destabilizzazione interna alla quale è stata sottoposta la Repubblica islamica dell’Iran e l’insistenza della propaganda occidentale sull’imminenza della sua caduta (con l’appoggio della stessa all’erede dello Shah Reza Ciro Pahlavi) rendono necessario affrontare il particolare percorso storico del Paese dagli inizi del Novecento fino ai giorni nostri. Solo in questo modo si possono avanzare delle ipotesi su ciò che potrà essere il suo futuro.
A seguito della destituzione da parte degli Alleati di Reza Shah e la salita al trono del figlio Mohammad Reza, l’Iran visse un periodo di “interregno” caratterizzato dall’ascesa di due movimenti politici che, pur da posizioni differenti, cercavano di porre fine al controllo della politica iraniana da parte di quei notabili che avevano occupato stabilmente il Majles sotto Reza Shah e che, dopo la sua abdicazione, trasformarono il Paese in una specie di “democrazia feudale”.
Il primo movimento è intrinsecamente legato alla famiglia Eskanderj: in particolare, ad Iraj (studente di tendenze socialiste e progressiste, figlio di Yahya Eskandari che si era distinto nella Rivoluzione costituzionale) ed a suo zio Soleiman Mohsen (anch’egli protagonista degli eventi dei primi anni del XX secolo). Proprio Iraj, riunitosi a casa di Soleiman insieme ad altre personalità fresche di laurea in Europa ed alcuni ex prigionieri politici, fondò nell’agosto del 1941 l’Hezb-e Tudeh (il Partito delle Masse).
Il loro manifesto politico si riferiva esplicitamente all’Iran come ad una società divisa in due grandi classi: i possessori dei mezzi di produzione (molto pochi) e quelli che non hanno abbastanza (la grande maggioranza della popolazione). Quest’ultimi (lavoratori, contadini, intellettuali, artigiani e mercanti), pur lavorando duramente, non ricevevano abbastanza per garantirsi una qualche forma di sussistenza. Di conseguenza, la battaglia del Tudeh si concentrava contro quelle strutture di classe che continuavano a (ri)produrre forme di dispotismo, nonostante il despota (Reza Shah) fosse decaduto.
Di fatto, come sottolineato nel precedente contributo, anche per volontà occidentale (britannica in primo luogo), le strutture di potere costruite da Reza Shah rimasero inalterate. Un fattore che, al termine del conflitto mondiale e con le prime significative frizioni tra campo occidentale ed Unione Sovietica, portò il Tudeh a moltiplicare rapidamente i suoi sostenitori tra i salariati urbani e la classe media.
Già nel 1945, i sindacati controllati dal Tudeh potevano contare su decine di migliaia di iscritti e avevano il controllo quasi totale sulle aree petrolifere del Khuzestan. Cosa che spinse la Anglo-Iranian Oil Company a concedere migliori condizioni lavorative ai proprio dipendenti (alloggi, giornata di lavoro di otto ore, salari più elevati e remunerazione extra per gli straordinari).
L’influenza puramente culturale e intellettuale del Partito non era minore, visto che riuscì ad introdurre in Iran i concetti di politica delle masse e di organizzazione di massa ed a pubblicare un dizionario politico in lingua persiana che rese di uso comune parole ed espressioni come imperialismo, colonialismo, conflitto di classe, identità di classe, fronte unito e così via.
Parte delle fortune politiche del Tudeh, tuttavia, si conclusero quando l’URSS offrì il proprio sostegno ai movimenti autonomisti del Kurdistan e dell’Azerbaigian. Nonostante, la sostanziale estraneità alle sommosse locali dei membri del Partito (che arrivarono a protestare ufficialmente e vivamente con Mosca), il governo iraniano utilizzò gli eventi per attuare una stretta contro il loro movimento e per organizzare (insieme agli Inglesi) alcune rivolte tribali anti-Tudeh nelle regioni sud-occidentali del Paese (quelle dove l’Anglo-Iranian Oil Company aveva la maggior parte dei propri interessi).
La crisi del Tudeh (aggravata dalla messa fuorilegge dopo l’accusa di aver attentato alla vita dello Shah) diede al movimento nazionalista guidato da Mohammad Mossadeq (esponente di una famiglia tradizionale di mostowfi) l’opportunità di emergere. Mossadeq aveva la fama di essere una persona integerrima ed incorruttibile, sosteneva la necessità di nazionalizzare le risorse naturali iraniane (ovvero, che il governo centrale avesse pieni diritti su produzione, vendita ed esportazione di petrolio e gas) e che la classe politica collaborazionista (asservita alle potenze straniere) avesse messo in pericolo l’esistenza stessa dell’Iran come Stato sovrano e indipendente.
Una volta assunta la carica di Primo Ministro, dopo una campagna in un cui riuscì ad attirare verso le sue posizioni (al contempo socialiste e nazionaliste) un ampio spettro di organizzazioni e partiti collegabili alla classe media ed operaia (come il Partito dei Lavoratoti che comprendeva un certo numero di intellettuali che avevano rotto con il Tudeh, tra cui spiccava Jalal al-e-Ahmad, resosi successivamente famoso per il suo saggio sulla gharbzadegi, o “intossicazione da Occidente”), Mossadeq, dapprima. piazzò uomini fedeli al suo Fronte Nazionale (Jebe’eh-e Melli) nei ministeri chiave e, in un secondo momento, cercò di attuare in pieno il suo programma. Lo storico Ervand Abrahamian descrive così quegli eventi: “Creò la National Iranian Oil Company (NIOC), la compagnia petrolifera nazionale iraniana, e iniziò le trattative con la Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) per un trasferimento non traumatico del controllo. Quando quest’ultima oppose resistenza, ordinò che la NIOC rilevasse la AIOC – i pozzi petroliferi, gli oleodotti, le raffinerie e le succursali da un capo all’altro del Paese […] Quando il governo inglese – a sostegno dell’AIOC – evacuò tutto il personale della compagnia, bloccò l’esportazione di petrolio dall’Iran e presentò un reclamo alle Nazioni Unite, si presentò personalmente al Consiglio per la Sicurezza Nazionale e, accusando la Gran Bretagna di sovversione, ruppe le relazioni diplomatiche e chiuse i consolati e le ambasciate di quest’ultima. La Gran Bretagna rispose congelando i capitali iraniani e rafforzando la sua presenza navale nel Golfo Persico”.
Allo stesso tempo, la propaganda britannica cominciò a dipingere Mossadeq come “dittatore”, “squilibrato”, “ossessionato dal martirio”, “xenofobo”, “pateticamente mistico” e via discorrendo (una pratica ampiamente utilizzata anche nell’attualità dai mezzi di informazione occidentali). Il colpo di Stato con il quale venne deposto il 19 agosto 1953 su iniziativa della CIA e del MI6 fu allora presentato come una dolorosa necessità per salvare l’Iran dal pericolo comunista. In realtà, USA e Gran Bretagna cercarono di salvaguardare in primo luogo i propri interessi geopolitici. Anzi, Washington, nel medio periodo (e grazie all’inserimento dell’Iran nel Patto di Baghdad del 1955), lo utilizzò anche per scalzare la decadente potenza “colonialista” britannica dal ruolo di sfruttatore/protettore dell’Iran e della sua monarchia.
Nonostante il colpo di Stato avesse minato profondamente la credibilità dell’istituzione monarchica, Mohammad Reza cercò di ridare vigore al sistema creato dal padre e fondato sull’espansione degli apparati militari, burocratici e della sua corte. Ad esso aggiunse un vago richiamo a forme di misticismo pseudo-tradizionali attribuendosi un canale diretto di comunicazione con il divino.
Di fatto, colto da estatica autoesaltazione ma (forse) ben conscio che le sue “fortune” fossero legate in realtà all’enorme incremento degli introiti del petrolio a cavallo tra anni ’60 e ’70 (con il picco di 20 miliardi di dollari ottenuti a seguito dell’embargo petrolifero deciso dall’OPEC nel 1973 in occasione della cosiddetta “Guerra del Kippur”), lo Shah arrivò a nominare se stesso come Arya Mehr (sole ariano).
Eppure, la cultura iraniana tradizionale è ricca di esempi in cui la presunzione del sovrano viene punita dalla divinità. Racconta lo Shahnameh che Re Yima (o Giamshid), il Re dei Re, colui che dominò sopra la terra per settecento anni quando la morte non era ancora conosciuta tra gli uomini ed incontrò lo stesso Ahura Mazda in Eran-Vej (il centro di irradiazione della cultura ariana), colmato il suo cuore di orgoglio, nominò se stesso Dio e pretese che la sua immagine fosse oggetto di venerazione. Fu allora che proprio Ahura Mazda ritirò il suo favore dal Re, e gli stessi nobili, guerrieri e sacerdoti si rivoltarono contro di lui, ponendo fine al suo regno.
Dunque, parafrasando Julius Evola, e fatte le dovute proporzioni tra un mito legato ad una lontana transizione tra due epoche distinte del mondo e quello che a tutti gli effetti si rivelò essere un manovratore (a sua volta manovrato) dell’imperialismo anglo-americano, si potrebbe affermare che Mohammad Reza venne meno a quella che il “Barone” definì come la “virtù aria fondamentale”: quella della verità. Di conseguenza la “gloria” (hvareno – la gloria solare intrinsecamente legata alla sovranità nella tradizione iranica) lo abbandonò dando il là al processo rivoluzionario.
Ora, a queste considerazioni di carattere “tradizionale” bisogna necessariamente aggiungere degli aspetti connessi alle profonde fratture prodotte dal regno di Mohammad Reza all’interno della società iraniana. In primo luogo, si deve sottolineare il fatto che, dopo la destituzione di Mossadeq, il Tudeh ed il Fronte Nazionale subirono pesanti persecuzioni caratterizzate da arresti di massa, distruzione delle loro sedi ed esecuzione di parte dei loro vertici. La seconda fase del suo regno, dunque, iniziò con una feroce stretta autoritaria e con una drastica riduzione delle libertà politiche.
In secondo luogo, è altresì importante riportare che, pur coccolando l’esercito (aumentando in modo esponenziale le spese militari, i salari degli ufficiali e gli acquisti di armamenti sempre più sofisticati dagli Stati Uniti), temeva che questo potesse ribellarsi contro la monarchia (come accaduto in Egitto e Libia). Così, in modo da scongiurare tale eventualità, vietò ai capi delle forze armate e dei servizi di sicurezza di comunicare tra di loro. Tutte le comunicazioni dovevano essere filtrate attraverso il palazzo reale e supervisionate da una ristretta cerchia di agenti fedelissimi dello Shah. Inoltre, con l’aiuto del Mossad e della statunitense FBI, diede vita nel 1957 ad una nuova agenzia di servizi segreti (passata alla storia con l’acronimo Savak) che si sviluppò fino a raggiungere 5000 unità operative più un numero imprecisato (ma probabilmente estremamente alto) di informatori/agenti “dormienti”. Compito di questa agenzia era (letteralmente) tenere d’occhio ogni singolo iraniano (politici e militari inclusi), trasformando la stessa società iraniana in una sorta di capitalismo oligarchico della sorveglianza ante litteram (una anticipazione del destino terminale dell’Occidente: una oligarchia fondata sul spyware).
Allo stesso tempo, lo Shah, tramite la Fondazione Pahlavi (organizzazione in linea teorica benefica creata nel 1958), controllava larga parte dell’economia iraniana. Questa, infatti, fungeva sia da riserva di fondi per la famiglia reale, sia come strumento per ottenere partecipazioni in settori diversificati (minerario, bancario, edilizia, agricoltura, industria pesante e turismo), sia per incanalare i compensi per le clientele della corte.
A partire dal 1963, infine, diede slancio a quella “rivoluzione bianca” che, a suo modo di vedere, avrebbe annichilito (in termini di risultati) le rivoluzioni comuniste del Novecento e prevenuto ogni possibile moto rivoluzionario in Iran. In realtà, la “rivoluzione bianca” si trasformò rapidamente in una delle cause del processo rivoluzionario.
Alla base della “rivoluzione” vi erano teorie economiche di origine nordamericana (e successivamente riportate in auge sotto l’amministrazione Reagan) fondate sull’idea che politiche a vantaggio dei ceti più abbienti, stimolando l’economia dall’alto, avrebbero finito per portare benefici agli strati inferiori. Nel caso iraniano, però, i vantaggi garantiti alle classi superiori non ebbero alcun riflesso su quelle inferiori, con il risultato che i benefici a pioggia verso il basso vennero sostituiti dalla mera accumulazione verso l’alto.
Uno dei casi più eclatanti, in questo senso, fu la riforma agraria. Questa, lungi dall’ottenere risultati concreti in termini di ridistribuzione della terra, di riduzione dello sfruttamento dei contadini e di miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, trasformò le vecchie famiglie di latifondisti in imprenditori capitalisti e produsse una struttura di classe in cui all’apice vi era la corte con una ristretta cerchia di famiglie ad essa collegata che possedevano il controllo totale sull’85% dell’economia iraniana. Al di sotto di essa si trovava una classe media composta da lavoratori stipendiati (pubblica amministrazione, insegnanti, tecnici industriali), commercianti e religiosi che vennero privati di rappresentanza politica a seguito dello scioglimento dei Partiti (Tudeh e Fronte Nazionale), dei sindacati e delle organizzazioni che storicamente avevano sostenuto le loro istanze. Infine, vi era una classe inferiore costituita da operai (proletari) e contadini senza terra che la stessa riforma spinse verso i centri urbani nella speranza di trovare nuove opportunità lavorative (nella grande maggioranza dei casi finirono a vivere in baraccopoli fatiscenti, prive di sistemi fognari, nelle periferie delle grandi città). Basti pensare che la popolazione di Teheran, tra il 1953 ed il 1979, crebbe dal milione e mezzo ai cinque milioni.
Le tensioni sociali si trasformarono rapidamente in tensioni politiche. Già nel 1963, l’ayatollah Khomeini (una delle autorità spirituali più note dell’Iran), dopo aver accusato lo Shah di svendere il Paese agli Stati Uniti, venne costretto all’esilio in Iraq. L’iniziò della sua attività politica, tuttavia, risale al 1943, quando pubblicò un piccolo pamphlet, dal titolo Lo svelamento dei segreti (Kashf al-asrar), in cui il governo di Reza Shah veniva accusato in modo veemente per aver in qualche modo portato all’invasione alleata dell’Iran. Ma è proprio dal 1963 in poi che il suo attivismo assunse un preciso connotato teopolitico.
Non si può comprendere il processo rivoluzionario in Iran senza ricorrere alla particolare storia del Paese ed ai “miti” sui quali essa si è costruita. I “miti” giocano infatti un ruolo di primo piano nei processi storici, nella politica e nella geopolitica. Come afferma il pensatore francese Alain de Benoist: “Grazie al mito l’uomo si mantiene nel punto in cui si incontrano il mondo e l’Essere […] L’uomo che recupera il mito si ristabilisce in se stesso. Esso torna alla fonte per un nuovo inizio”.
Tra i “miti” che guidarono l’evento rivoluzionario in Iran (“Rivoluzione” da intendersi nel significato etimologicamente corretto del termine, come “ritorno” ad un punto di inizio, all’origine) vi è sicuramente quello della lotta tra Mosè ed il Faraone: un racconto al quale il Corano dedica ampio spazio e che lo stesso Khomeini ha fatto proprio nel suo discorso anti-monarchico.
Ad onor del vero, la storia iraniana è ricca di esempi in cui figure religiose si opposero all’autorità monarchica. Già intorno agli ultimi decenni del 500 a. C., un sacerdote mago di nome Gaumata, sfruttando un certo malcontento popolare, si oppose con veemenza a Cambise (figlio di Ciro) che aveva imposto una svolta oppressiva al potere regale achemenide. Ancora, all’origine della dinastia sassanide vi fu la rivolta di Ardashir (il cui nome deriva da Artakhshatra – Artaserse, nome assai diffuso in epoca achemenide che rimanda in modo evidente alla casta guerriera indoeuropea) contro gli Arsacidi; una rivolta ispirata da Dio e indirizzata a sconfiggere il male e la brutalità tirannica.
Tuttavia, Khomeini preferì rimanere in ambito islamico in quanto sia Mosè che il Faraone, pur su fronti opposti, rappresentavano dei paradigmi etici emblematici. Il Faraone è l’epitome del sovrano arrogante che pretende in modo blasfemo la propria associazione al divino (Re Yima nello Shahnameh, Mohammad Reza nella realtà). Mosè, al contrario, incarna l’idea della rivolta in nome della vera fede e del vero Dio contro l’usurpatore.
In altre parole, Khomeini ha posto alla base del processo rivoluzionario una “attualizzazione del mito” di Mosè, facendo ulteriormente propria quella pratica (squisitamente sciita) che fa rivivere costantemente la storia e gli eventi sacri (da Mosè a Husayn) trasmutandoli all’interno della politica contemporanea. La ribellione, così, diviene lo stato naturale di una presenza sciita nel mondo, perché “se non si resiste alla tirannia, mancherà qualcosa nella composizione etica dell’universo”.
Una simile impostazione si ritrova nell’elaborazione teorica del di Ali Shariati. Questi era un figlio della classe media iraniana nato nel Khorasan da un famiglia di religiosi e piccoli proprietari terrieri. Nei primi anni ’60, grazie ad una borsa di studio statale, ebbe modo di studiare in Francia dove seguì le lezioni del sociologo marxista Georges Gurvitch, di Louis Massignon e di Henry Corbin. Tradusse diversi testi dal francese al persiano, soprattutto opere di Jean Paul Sartre, dello stesso Massignon (in particolare, Salman Pak e l’origine spirituale dell’Islam iranico, in cui il compagno del Profeta veniva descritto come uno dei primi musulmani sciiti) e del teorico anticolonialista Franz Fanon. Tornato in Iran nel 1965, trascorse i dieci anni successivi (fino al suo esilio londinese, nel corso del quale morì all’improvviso, molto probabilmente per mano della Savak) insegnando a Mashhad, dove le sue lezioni ebbero un’ampia diffusione anche in forma di opuscoli o registrazioni su nastro.
Il tema dominante del suo pensiero era riscoprire la reale essenza rivoluzionaria dello sciismo come forma di opposizione e lotta contro l’oppressione. A Shariati, infatti, si deve l’introduzione di accenti apertamente radicali nell’interpretazione delle scritture sacre. Così, il gihad divenne “lotta di liberazione” e lo shahed (il martire) assunse il carattere dell’eroe rivoluzionario che combatte l’oppressione. Ancora, sarebbe stato lui a coniare il celebre motto “ogni luogo, Kerbala. Ogni giorno, Ashura. Ogni mese, Muharran” che, successivamente, ha fatto da sfondo ideologico ad una particolare dottrina militare (la “dottrina Ashura”) in cui alle truppe veniva (e viene tuttora) insegnato che è necessario resistere al nemico fino all’estremo sacrificio ed indipendentemente dal risultato finale.
Shariati, infine, denunciava apertamente i religiosi quietisti (lo “sciismo nero”) che trasformava la religione in marxiano “oppio dei popoli”, prosciugando il messaggio rivoluzionario della Rivelazione coranica e riducendolo a mero paternalismo moralista. Ad essi opponeva lo “sciismo rosso” di coloro i quali concepivano l’Islam come lotta incessante per la fede.
Se il pensiero di Shariati conobbe particolare successo tra i giovani e gli studenti della classe media, quello di Khomeini ebbe notevole riscontro tra gli ulema e, in un secondo momento, tra mercanti, artigiani e strati inferiori della società iraniana. Cosa che ha spinto taluni a definirlo come una sorta di “populismo clericale”.
Ad onor del vero, rimane estremamente difficoltoso racchiudere il pensiero khomeinista all’interno di categorie che appartengono alla Modernità occidentale. Anche se si è cercato di definire la sua interpretazione del concetto tradizionale di velayat-e faqih (governo del giureconsulto) come “originale”, essa trae comunque la propria forza da premesse assolutamente in linea con la giurisprudenza islamica sciita classica. Scriva, ad esempio, il grande teologo Mulla Sadra (1571-1640): “È necessario che in ogni momento ci sia un guardiano (wali) che sia incaricato di preservare (qaim) il Corano di cui conosce i segreti (asrar) ed i misteri (rumuz), così da poterlo insegnare ai fedeli e guidare coloro che ricevono la guida, e perfezionare le anime dei suoi seguaci e sostenitori timorati di Dio, e illuminare i loro cuori con la luce della conoscenza”.
In altre parole, Mulla Sadra rivendica l’assoluta autorità sul sapere dei dotti (dei giurisperiti religiosi). Essi hanno autorità perché esistono tre metodi principali per il raggiungimento della conoscenza: la Rivelazione (che appartiene ai Profeti); la conoscenza divinamente ispirata (che appartiene agli Imam); la conoscenza speculativa (che appartiene ai dotti religiosi). Essendo Muhammad il “sigillo della Profezia” e l’ultimo Imam in stato di occultazione, l’autorità non può che spettare ai sapienti. Essi hanno il diritto/dovere di creare sulla terra uno “Stato giusto” che operi secondo principi di verità e giustizia (perché la Legge scende dal cielo alla terra e risale dalla terra al cielo) ed in cui ogni uomo operi secondo la sua naturale (pre)disposizione.
Su queste fondamenta e sulla base del dettato coranico “Obbedisci a Dio, al Profeta ed a coloro che hanno autorità”, Ruhollah Khomeini elaborò la sua interpretazione del velayat-e faqih secondo la quale erano i mujtahid anziani (esperti nel fiqh, il diritto islamico) ad avere il diritto/dovere a governare lo Stato. E su queste basi, ogni altra autorità veniva considerata illegittima, sia la monarchia quanto la democrazia demagogica di stampo occidentale. Questo perché le ordinanze divine contenute nella Shari’a richiedono necessariamente un governo ed un’autorità “divini” per la loro attuazione. Senza uno Stato o un governante con un’autorità “divina”, la supremazia della Shari’a non esiste più e non può in alcun modo essere mantenuta. Ne consegue che diviene impossibile tutelare gli affari ed i beni dei musulmani. In assenza dell’Imam del Tempo, dunque, tale autorità poteva appartenere solo al faqih. Questo aspetto si ricollega al discorso sulla “politica divina” al quale si è fatto riferimento nel capitolo precedente. A differenza delle democrazia occidentali, nelle quali i governanti (e più in generale i politici) devono sintonizzarsi di volta in volta con i cangianti umori popolari, il faqih dà retta solo alla Legge divina la quale dice sempre le stesse cose ed è stabile nelle sue conclusioni e nei suoi principi etici. Dunque, se le democrazie occidentali soffrono di una postura demagogica che rende la classe politica pronta a contraddirsi in ogni momento, il faqih mira sempre alla verità ed alla coerenza, le sue tesi si fondano su contenuti immutabili che impone in maniera salda e incrollabile perché il suo obiettivo non è solo governare ma anche migliorare coloro che sono sottoposti al suo governo.
Ad onor del vero, ancora negli anni ’50, Khomeini distingueva tra autorità spirituale (gli ulema) ed autorità temporale (la monarchia). Ai primi, in teoria, spettava solo una funzione di guardiani/supervisori sulla legislazione del governo. Tuttavia, il carattere apertamente a-islamico dello Shah e la sua totale capitolazione di fronte all’Occidente lo spinsero a ripensare l’unificazione delle due funzioni. A questo proposito, nella raccolta di lezioni tenute al seminario di Najaf tra il 1969-70 e passate alla storia proprio con il titolo di velayat-e faqih, mise in evidenza le evidenti inadeguatezze delle politiche dello Shah, sia sul piano delle relazioni internazionali, sia in termini interni. In particolare, denunciò il sostegno incondizionato ad Israele ed evidenziò come lo Shah avesse trascurato le politiche agricole per trasformare il Paese in una lucrosa discarica per gli esportatori americani di prodotti alimentari. Si legge: “Mentre il nostro popolo è stritolato dagli stenti e dalla fame, la classe dirigente dell’Iran dilapida il patrimonio pubblico comprando aerei Phantom sui quali i militari israeliani ed i loro servi possono compiere esercitazioni nel nostro Paese […] Siamo diventati una colonia israeliana”.
Inoltre, sottolineò come, nonostante i proclami propagandistici sulla modernizzazione del Paese, i villaggi rimanevano privi dei servizi fondamentali (elettricità, scuole, ospedali, acqua potabile); i mercanti del bazar venivano trascinati verso la miseria dalla concorrenza sleale dei prodotti stranieri e degli imprenditori legati alla corte; gli abitanti delle baraccopoli aumentavano a vista d’occhio a fronte di una inesistente politica degli alloggi o di forme di edilizia popolare.
Attorno alla metà degli anni ’70, dunque, le spaccature interne alla società iraniana erano ormai insanabili. Il punto definitivo di rottura arrivò a seguito della creazione, da parte dello Shah, del Partito della Rinascita (Partito unico) e l’eliminazione (di fatto) di quella parvenza di monarchia democratico-costituzionale sulla quale aveva costruito la sua immagine (soprattutto per l’estero). Volendo entrare nello specifico, nel mezzo dei tumulti socio-economici generati dalla sua “Rivoluzione Bianca”, lo Shah (sbagliando) scelse di attuare per filo e per segno i suggerimenti contenuti nell’opera dello scienziato politico nordamericano Samuel P. Huntington Political order in changing societies, all’epoca imprescindibile per i corsi di laurea sulla modernizzazione politica nei Paesi in via di sviluppo.
Secondo Huntington, una rapida modernizzazione in ambito economico e sociale produce inevitabilmente nuove domande, nuove pressioni e nuove tensioni nell’ambito politico. Di conseguenza, alla modernizzazione sociale segue sempre una certa instabilità politica. Così, in modo da prevenire moti rivoluzionari, ogni governo dovrebbe creare un “Partito unico” (o un “Partito-Stato”) con il compito di fungere da legame organico con il Paese, mobilitare la popolazione, trasmettere ordini dall’alto verso il basso, convogliare gli interessi dal basso verso l’alto e fornire allo Stato contingenti di fanteria disciplinati e fidati.
Queste idee si diffusero in Iran quando alcuni giovani laureati tornarono dagli Stati Uniti ed iniziarono ad occupare posizioni di rilievo all’interno delle istituzioni e degli organi di governo. Nel 1975, lo Shah, dando fiducia alle loro idee, decise di sciogliere i due Partiti che davano una parvenza di sistema multipartitico all’Iran (il Partito Mardom e l’Iran-e Novin) e proclamò la nascita del già citato Partito della Rinascita (Hezb-e rastakhiz). Inoltre, annunciò che tutti gli aspetti della vita politica e civile sarebbero ricaduti sotto il controllo del Partito. Tutti i cittadini avevano il diritto/dovere di aderirvi e chi non lo faceva era quasi certamente un “comunista mascherato” che poteva scegliere tra la prigione o fuggire all’estero (magari direttamente in Unione Sovietica). Tuttavia, paradossalmente, lo stesso Partito della Rinascita operava secondo canoni marxisti-leninisti (come il centralismo democratico) ed i suoi esponenti giuravano che avrebbero stabilito legami dialettici tra il governo e la popolazione, sintetizzando il meglio del capitalismo e del socialismo. Ciò avrebbe permesso al “sole ariano” di completare la sua “grande rivoluzione”.
Il Partito della Rinascita passò gli ultimi anni di vita della dinastia Pahlavi a cercare di costruire una struttura che coprisse l’intero Stato e ponesse qualsiasi attività sotto la diretta supervisione del monarca (con l’ausilio della Savak). Tuttavia, Mohammad Reza ottenne risultati completamente diversi da quelli che si era prefissato. A ciò si aggiunga che l’attacco congiunto della monarchia contro religiosi e commercianti/mercanti del bazar (due classi tradizionali dell’Iran) scatenò reazioni veementi, tanto che pure i funzionari pubblici si unirono al processo rivoluzionario, scioperando ad oltranza. Lo stesso Khomeini definì il Partito dello Shah come “haram” in quanto si proponeva come obiettivo quello di distruggere i contadini, i commercianti e l’Islam nella sua interezza.
La serie di eventi che porteranno al successo della Rivoluzione ed alla successiva “guerra imposta” contro l’Iraq verranno affrontati nella terza parte di questa serie di contributi.