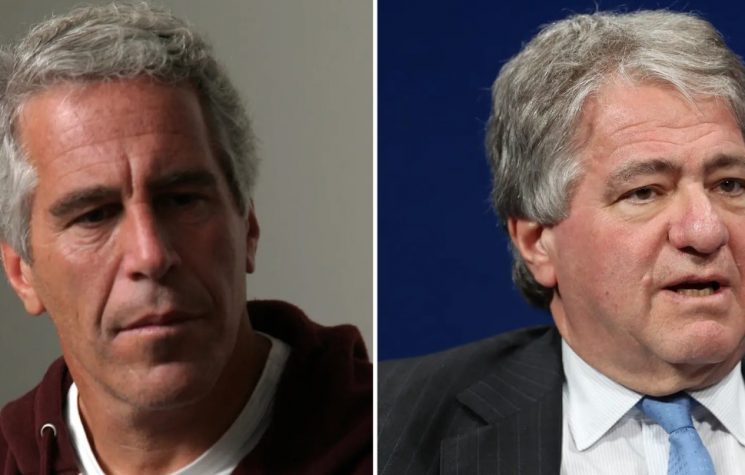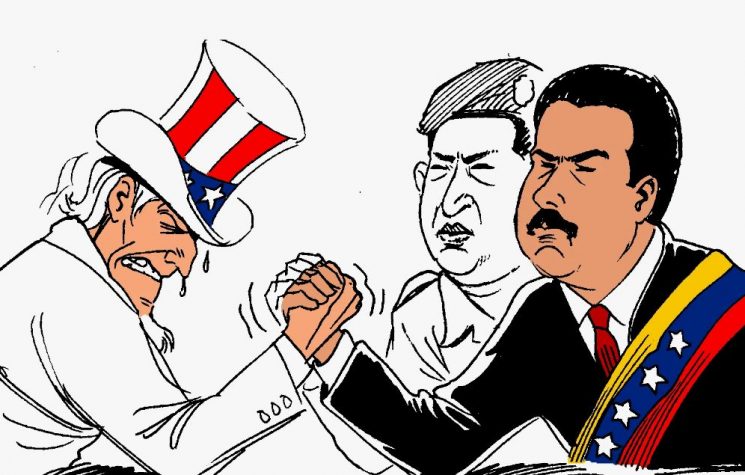Come il mondo è diventato dipendente dall’America
Nell’agosto del 1969, un rapporto redatto dagli specialisti della Cia osservava che «sette compagnie continuano a dominare il commercio internazionale di petrolio, ma la loro quota è scesa da circa il 90% del 1952 al 75% del 1968 […]. Inoltre, i Paesi produttori hanno chiesto e ottenuto la proprietà parziale in molte aziende, ed iniziato a muoversi nei campi della raffinazione, della commercializzazione e del trasporto in misura ancora ridotta ma in costante e rapido aumento». Tra il 1970 e il 1973, Algeria, Libia e Iraq nazionalizzarono le rispettive industrie petrolifere, mentre l’Arabia Saudita entrò nel capitale della potentissima Aramco, il consorzio che gestiva l’immenso patrimonio energetico del regno formato da quattro compagnie statunitensi. Nel 1970, i governi dei Paesi produttori controllavano il 10% scarso delle industrie petrolifere operanti sui loro territori; nel 1979, la percentuale sarebbe salita oltre la soglia del 70%. L’offensiva scatenata contro il carrello petrolifero anglo-statunitense dalle nazioni produttrici minacciava di trasferire nelle loro mani il potere di ridefinire la struttura del mercato mondiale degli idrocarburi in funzione dei loro interessi, coincidenti con un sostanzioso incremento del prezzo internazionale del petrolio.
Specialmente a fronte del costante aumento del prezzo dei cereali, di cui molte nazioni produttrici di petrolio erano importatrici nette, dovuto in buona parte agli sforzi profusi dagli Usa che ambivano a espandere i proventi dall’export di prodotti agricoli in un’ottica di attenuazione del deficit di bilancia dei pagamenti in cui il Paese era sprofondato per effetto della Guerra del Vietnam. L’incremento del prezzo del petrolio non era tuttavia l’unico contraccolpo che rischiava di scaturire dalla ridefinizione dei rapporti di forza a vantaggio dei Paesi produttori; la svalutazione del dollaro avrebbe inesorabilmente accresciuto l’interesse di questi ultimi a richiedere valute più stabili per i pagamenti delle forniture energetiche. Il rischio era assai concreto, a fronte dell’aumento del prezzo dell’oro da 35 a 42 dollari per oncia registrato tra il dicembre 1971 e il marzo 1973 in conseguenza del dissesto economico Usa. Se il 1971, anno in cui il presidente Nixon ripudiò unilateralmente gli accordi di Bretton Woods, si era concluso con un deficit della bilancia dei pagamenti di 30 miliardi di dollari e un incremento dell’offerta di moneta da parte della Federal Reserve del 10%, nel 1972 si registrò un’espansione della base monetaria dello stesso ordine accompagnata da un disavanzo da 10 miliardi di dollari.
La prospettiva della “detronizzazione” del dollaro indusse il cartello petrolifero statunitense a commissionare uno studio alla Chase Manhattan Bank volto all’individuazione di strade percorribili per superare le difficoltà vigenti. Ne scaturì l’Outlook for energy in the United States to 1985, all’interno del quale si prevedeva che la domanda petrolifera statunitense sarebbe aumentata da 14,7 a 30,2 milioni di barili al giorno nell’arco di un quindicennio, a fronte di un’offerta destinata a crescere soltanto da 11,6 a 15 milioni di barili al giorno. Sulla base di questi dati allarmanti, gli esperti della Chase Manhattan Bank affermarono che il mantenimento della sicurezza energetica degli Stati Uniti (da poco rivelatisi incapaci di soddisfare il fabbisogno energetico facendo esclusivo ricorso al proprio petrolio) dipendeva dalla profusione di notevoli risorse finanziare necessarie sia a spremere quantità maggiori di petrolio dai giacimenti in via di esaurimento, sia a rilevare altri pozzi da sfruttare in modo da rilanciare la produzione interna. Il problema, a loro avviso, andava ricercato negli eccessivi controlli vigenti sul mercato petrolifero statunitense, che lo provavano della capacità di raccogliere finanziamenti necessari alla messa a punto di tecniche estrattive all’avanguardia. «L’attuale carenza di energia – recita la relazione finale redatta dalla grande banca statunitense – riflette una prolungata carenza di capitali, non la mancanza di risorse energetiche in sé. I controlli suoi prezzi dovrebbero essere rimossi. Non semplicemente modificati, ma eliminati immediatamente e completamente. I prezzi di qualsiasi tipo di energia primaria dovrebbero inoltre poter rispondere alle forze economiche naturali e raggiungere qualunque livello sia necessario per assicurare rifornimenti adeguati».
Il documento della Chase Manhattan Bank apriva per la prima volta le porte a prospettive di crescita potenzialmente illimitata del prezzo del petrolio.
Scenari straordinariamente simili furono presi in esame nel corso del vertice del Bilderberg Club del 1973, presso l’isoletta svedese di Saltsjöbaden, cui presero parte i più illustri esponenti della politica e dell’imprenditoria statunitense ed europea (Lord Richardson e Lord Greenhill della British Petroleum, Robert O. Anderson della statunitense Atlantic Ritchfield Corporation, Eric Roll del gruppo Warburg, George Ball della Lehman Brothers, David Rockefeller della Chase Manhattan Bank, Emilio G. Collado della Standard Oil, George C. McGhee, Józef Retinger, Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, Arthur Dean, Giovanni Agnelli ecc.). Argomento centrale della discussione: la necessità di ridefinire i rapporti tra Paesi produttori e consumatori di petrolio alla luce della scomparsa del Gold Exchange Standard. Nel corso delle discussioni, Walter Levy, portavoce della “delegazione” statunitense molto vicino al gruppo Rockefeller, spiegò che un forte aumento del prezzo del petrolio «avrebbe avuto pesanti contraccolpi sulla bilancia dei pagamenti dei Paesi consumatori. Seri problemi si verrebbero inoltre a creare per effetto del contestuale accumulo senza precedenti di valuta pregiata da parte dei Paesi esportatori come l’Arabia Saudita e Abu Dhabi […]. È in corso un drastico cambiamento dei rapporti di forza e delle relazioni politiche e strategiche tra i produttori di petrolio, i Paesi consumatori in cui sono domiciliate le compagnie petrolifere internazionali e le imprese petrolifere nazionali sia dei Paesi esportatori che degli Stati costretti a importare petrolio per soddisfare il fabbisogno interno».
Al termine della riflessione, Levy ipotizzò un aumento del 400% delle rendite petrolifere a beneficio dei Paesi membri dell’Opec. La “profezia” non verteva tanto sull’elaborazione di misure atte a prevenire lo shock o quantomeno a mitigarne l’impatto, ma soltanto sulla gestione politica dei suoi effetti. Nell’ottica di Levy, l’aumento del prezzo del petrolio non avrebbe soltanto compensato la progressiva svalutazione del dollaro, ma anche spalancato allettanti prospettive di profitto dinnanzi a Wall Street. Nella fattispecie, l’enorme rivalutazione del petrolio si sarebbe tradotta per un verso nel peggioramento dei saldi delle bilance dei pagamenti dei Paesi industrializzati e dei Paesi in via di sviluppo sprovvisti di riserve energetiche e delle risorse necessarie a mitigare l’impatto devastante delle variazioni sui tassi di cambio. Per l’altro, in crescenti accumuli di riserve di valuta pregiata da parte dei Paesi produttori, riuniti in larga parte nell’Opec, cartello controllato alleati mediorientali alleate di Washington come l’Arabia Saudita, il Kuwait, l’Iraq di Saddam Hussein e l’Iran dello Shah. Dal punto di vista del sistema bancario statunitense, la chiave per ottenere il massimo beneficio dal colossale squilibrio tratteggiato da Levy consisteva nel far sì che i deficit dei Paesi importatori trovassero nei surplus degli esportatori di petrolio la loro fonte di finanziamento. Le funzioni di intermediazione legate alla canalizzazione dei fondi dai Paesi in surplus verso quelli in disavanzo sarebbero naturalmente ricadute sugli istituti di Wall Street, mentre le “sorelle” statunitensi del petrolio avrebbero beneficiato di flussi di cassa necessari a sostenere la messa a punto delle moderne tecniche di perforazione ed estrazione indicate dallo studio della Chase Manhattan Bank.
L’occasione d’oro per realizzare lo scenario prefigurato in occasione del vertice del Bilderberg Group di Saltsjöbaden si verificò a pochissimi mesi di distanza, sull’onda degli eventi verificatisi il 6 ottobre del 1973. In quel giorno, le truppe siriane presero d’assalto le linee di difesa israeliane stanziate nel Golan mentre l’esercito egiziano equipaggiato con armamento sovietico attraversava il Canale di Suez. Israele, impegnato nei festeggiamenti dello Yom Kippur, apparve sorpreso dall’attacco congiunto siro-egiziano nonostante l’offensiva fosse stata preceduta da evidenti segnali di profonda inquietudine provenienti dall’Egitto. Il presidente Anwar al-Sadat aveva espulso il personale tecnico sovietico ponendo fine a un’alleanza che aveva garantito al Paese aiuti di natura sia civile che militare, e successivamente organizzato manovre militari in prossimità della penisola del Sinai. Il Mossad e l’Aman avevano informato la premier Golda Meir della concreta prospettiva dell’aggressione e persino adombrato, gratificati dall’assenso dei generali Moshe Dayan, Israel Tal e David Elazar, la possibilità di sferrare un attacco preventivo, ma le loro raccomandazioni non furono accolte. Le forze siro-egiziane ne trassero vantaggio, colpendo duramente sia i caccia israeliani parcheggiati negli aeroporti, sia i reparti dell’Israeli Defense Force.
Alcuni analisti tendono a interpretare l’irrituale impreparazione militare manifestata da Israele in quell’occasione come una “passività imposta” dal segretario di Stato Kissinger, il quale minacciò il blocco dell’assistenza militare qualora Tel Aviv avesse sferrato un attacco preventivo.
Re Faysal, dal canto suo, aveva intimato a Washington che, in assenza di una sensibile alterazione dell’approccio statunitense rispetto alla questione palestinese, l’Arabia Saudita e gli alleati mediorientali si sarebbero spinti a dichiarare un embargo petrolifero nei confronti di tutti i Paesi che sostenevano Israele. Nell’ottica di Nixon e Kissinger, tuttavia, la minaccia saudita offriva la possibilità di tradurre in realtà il disegno strategico tratteggiato a Saltsjöbaden. Di qui la decisione di Kissinger, dotato di canali diplomatici diretti sia con l’ambasciatore israeliano a Washington Simcha Dinitz che con i vertici politici siriani ed egiziani, di presentare a ciascuna parte in causa una «raffigurazione deliberatamente falsata degli elementi critici relativi alla posizione degli altri soggetti, assicurandosi che i Paesi arabi imponessero l’embargo petrolifero». Così, nel momento in cui il fronte arabo sferrò l’offensiva, l’Arabia Saudita e i suoi alleati imposero il blocco degli approvvigionamenti di idrocarburi destinati agli Stati Uniti e all’Olanda – Rotterdam ospitava il principale porto petrolifero europeo. Con la supremazia aerea annullata dalla distruzione di oltre 200 caccia da parte degli eserciti nemici, Israele corse il serio rischio di capitolare, arrivando persino a valutare l’ipotesi di avvalersi dell’arma atomica.
Solo a quel punto gli Stati Uniti implementarono l’Operazione Nickel Grass, il ponte aereo (Operazione Nickel Grass) che garantì il trasferimento presso lo Stato ebraico di caccia, carri armati, munizioni e sistemi tecnologici di ultima generazione. Stando alle rivelazioni dell’ammiraglio Elmo R. Zumwalt, il dilazionamento dell’Operazione Nickel Grass scaturiva dalla volontà deliberata di Kissinger di «far sanguinare Israele quel tanto che bastava» per dissodare adeguatamente il terreno alla diplomazia del dopoguerra.
Di fronte alla controffensiva israeliana, scatenata grazie ai cruciali rifornimenti statunitensi, i ministri dell’Energia di Arabia Saudita, Kuwait, Abu Dhabi, Iraq, Iran e Qatar attuarono (16 ottobre) la strategia concordata presso l’hotel Hilton di Kuwait City, implicante un primo aumento del prezzo di riferimento del petrolio da 3,01 a 5,11 dollari al barile, e una seconda rivalutazione che sarebbe stata attuata l’anno successivo. Quando, il 18 marzo 1974, i Paesi arabi revocarono l’embargo agli Usa, il petrolio aveva già in toccato quota 11,65 dollari per barile, con un aumento complessivo del 400% circa – tra il 1949 e il 1970, il prezzo del petrolio viaggiava su una media di 1,90 dollari per barile. Gli artefici dell’embargo chiarirono inoltre che avrebbero ridotto immediatamente la produzione del 5% rispetto ai livelli di settembre, e provveduto a un ulteriore taglio del 5% per ogni mese, finché le forze israeliane non si fossero ritirate da tutti i territori occupati nel giugno del 1967 e non avessero riconosciuto i diritti del popolo palestinese. In realtà, la Guerra dello Yom Kippur rappresentò il pretesto di cui i produttori arabi si servirono per stimolare una rivalutazione del petrolio che compensasse la devastante svalutazione del dollaro e mantenere così inalterati i propri introiti.
Nel 1974, i Paesi capitalisticamente avanzati registrarono un deficit commerciale pari all’inaudita cifra di 35 miliardi di dollari, associato a un’ondata di fallimenti aziendali, all’aumento della disoccupazione e alla crescita incontrollata dell’inflazione. In appena un anno di recessione, la produzione industriale diminuì del 10%, mentre il commercio internazionale subì un crollo del 13%.
Anche Stati Uniti subirono contraccolpi significativi. Entrarono ufficialmente in recessione nel novembre 1973 e uscendovene soltanto nel marzo 1975. Il Dow Jones subì un crollo del 36% dal 31 ottobre 1973, subito dopo la Guerra dello Yom Kippur, al 30 settembre 1974. Ancora nel 30 settembre 1982, l’indice non era ancora tornato ai livelli toccati alla vigilia del conflitto. L’impennata del prezzo del petrolio, foriera di inflazione incontrollata, costrinse inoltre i comparti manifatturieri nazionali a licenziare decine di migliaia di lavoratori.
L’impatto devastante dalla stagflazione avrebbe indotto l’amministrazione Nixon a prendere in esame misure particolarmente drastiche. Lo rivela il finanziere James Rickards, che all’epoca collaborava assieme al professor Robert W. Tucker dell’American Foreign Policy Institute e con Hemut Sonnenfeldt, fidatissimo consigliere di Henry Kissinger. Secondo Rickards, i tre si riunirono nel febbraio 1974 in una sala della Casa Bianca per discutere «una possibile invasione dell’Arabia Saudita. L’idea era quella di mettere in sicurezza i giacimenti petroliferi, estrarre petrolio a sufficienza per soddisfare il fabbisogno occidentale e giapponese e fissarne il prezzo a livelli sufficientemente moderati da evitare di minare la fiducia nel dollaro. Gli arabi avevano imposto un congelamento volontario dei prezzi del petrolio il 7 gennaio 1974 e avevano formalmente posto fine all’embargo petrolifero il 17 marzo 1974. Sembravano rendersi conto che il colossale danno economico inflitto agli Stati Uniti avrebbero potuto portarli sull’orlo della guerra: esattamente lo scenario di cui avevamo discusso con Sonnenfeldt alla Casa Bianca. I rapporti erano ancora tesi e il danno economico causato dagli aumenti dei prezzi del 1973 era ancora in corso. Il blocco temporaneo dei prezzi non era sufficiente. Gli Stati Uniti avevano bisogno di una soluzione permanente alla minaccia rappresentata dall’arma petrolifera araba».
La ricostruzione formulata da William Engdahl, sulla base delle confidenze resegli dallo sceicco Yamani, delinea uno scenario molto diverso. A suo avviso, le rivalutazioni del prezzo del petrolio imposte dai Paesi produttori del Medio Oriente erano state fortemente caldeggiate dallo Shah, bisognoso della liquidità necessaria a sostenere il robusto piano di riarmo iraniano che era stato concordato con Nixon e Kissinger nel 1972. Nel dicembre del 1973, quando la Guerra dello Yom Kippur era ormai terminata, re Faysal inviò Yamani a Teheran con l’incarico di ottenere dallo Shah spiegazioni in merito alla sua campagna di pressioni sull’Opec volta a incrementare il prezzo del petrolio del 400%, alla luce del colpo micidiale alla crescita economica mondiale e del deterioramento dei rapporti con i Paesi industrializzati che ne sarebbero derivati. Con grande disinvoltura, Pahlavi avrebbe confidato a Yamani di riferire a Faysal che per ottenere una risposta era necessario interpellare Henry Kissinger. L’Iran, per giunta, fu l’unico Paese produttore del Medio Oriente a non aderire dell’embargo, continuando a rifornire di petrolio sia gli Stati Uniti che la Gran Bretagna.
Nel qual caso, la linea d’azione seguita da Nixon e Kissinger assumerebbe le fattezze di un vero e proprio gioco al massacro contro gli alleati in Europa ed Estremo Oriente, costretti a scaricare sul consumatore finale il rincaro vertiginoso degli input energetici ordito da Washington in accordo con i produttori arabi di petrolio. Nel 1974, i Paesi capitalisticamente avanzati registrarono un deficit commerciale pari all’inaudita cifra di 35 miliardi di dollari, associato a un’ondata di fallimenti aziendali, all’aumento della disoccupazione e alla crescita incontrollata dell’inflazione. In appena un anno di recessione, la produzione industriale diminuì del 10%, mentre il commercio internazionale subì un crollo del 13%. Nonostante i pesanti contraccolpi subiti anche dagli Usa, il Paese registrò comunque un aumento dei consumi energetici del 20% a fonte di un crollo del 25% accusato a livello planetario, mentre il volume degli investimenti esteri effettuati dalle multinazionali statunitensi passò da 7,5 a 14,2 miliardi di dollari nell’arco del quinquennio 1970-1975. Senza contare l’impatto sui bilanci di Big Oil, che nel solo 1974 beneficiò di un incremento dei profitti del 71% a fronte di un aumento del volume delle vendite del 10%.
Se Europa e Giappone coprivano una quota assai ragguardevole del proprio fabbisogno energetico tramite approvvigionamenti mediorientali, gli Usa si rifornivano prevalentemente da Canada, Messico e Venezuela e dipendevano dalle importazioni petrolifere per una quota minoritaria del consumo interno. All’atto pratico, «l’approvvigionamento era sicuro. La bolletta energetica sarebbe stata certo più salata, ma la stampa di dollari era un modo relativamente conveniente per affrontare il problema, almeno nell’immediato, compensando in carta ciò che gli altri Paesi consumatori dovevano compensare con aumenti delle esportazioni, riduzione dei consumi e indebitamento. Vi era forse della supponenza nelle parole di Kissinger, quando ricordava ai ministri degli altri Paesi occidentali che, pur pagando dei costi, dal punto di vista strettamente economico gli Stati Uniti avrebbero potuto superare le difficoltà anche contando solo sulle proprie forze. Ciò garantiva alla diplomazia statunitense un più ampio margine di manovra sia rispetto al conflitto arabo-israeliano, sia rispetto alla stessa questione dello shock petrolifero».
La quadratura del cerchio fu completata nel giugno del 1974, quando il segretario al Tesoro William Simon si recò a Jedda per “ritoccare” l’intesa che il presidente Roosevelt e re Abdulaziz “Ibn” al-Saud avevano raggiunto il 14 febbraio 1945, a bordo dell’incrociatore Uss Quincy in navigazione nel Grande Lago Amaro del Canale di Suez. L’accordo conferiva alle compagnie energetiche statunitensi gravitanti attorno all’orbita della Standard Oil – che già controllavano la totalità dei pozzi in Venezuela – i diritti esclusivi per lo sfruttamento delle risorse petrolifere saudite, in cambio della protezione militare del regno e dell’appoggio politico alla famiglia al-Saud. Scrive in proposito lo specialista William Engdahl: «Roosevelt aveva vissuto abbastanza a lungo da assicurare ai Rockefeller un vantaggio inestimabile – diritti esclusivi su tutto il petrolio saudita per i loro partner dell’Aramco […]. La decisione di incorporare ufficialmente le ricchezze petrolifere saudite nello spettro degli interessi nazionali statunitensi appariva tanto più stupefacente se si considera che, negli anni ’40, il Paese era autosufficiente dal punto di vista energetico. Quando, nel 1948, fu scoperto il più grande giacimento petrolifero al mondo presso la località saudita di Ghawar, gli Stati Uniti ebbero modo di consolidare la propria supremazia petrolifera ed esercitarla per controllare l’economia mondiale. Il petrolio stava infatti diventando la risorsa energetica essenziale per la crescita economica, e le compagnie energetiche statunitensi di proprietà dei Rockefeller avrebbero rafforzato così la propria presa sul nuovo ordine postbellico».
L’aggiornamento della vecchia intesa del 1945 contemplava anzitutto il “ridimensionamento” dell’indisciplinato Faysal (nominato “uomo dell’anno” del 1974 dalla rivista «Time»), diventato fonte di grande preoccupazione per Washington a causa del sostegno che accordava all’Olp di Yasser Arafat e alla propensione alla diversificazione degli investimenti (incentrati soprattutto su marchi e yen) che l’Arabia Saudita stava manifestando sotto la sua guida. Soprattutto, il sovrano saudita si era spinto a valutare l’ipotesi di sottoporre all’attenzione dei Paesi membri dell’Opec la proposta di fissare il prezzo del petrolio in once d’oro in un’ottica di protezione dal declino apparentemente inarrestabile del dollaro.
L’accomodamento proposto da Simon a Faysal nel corso della visita era tanto semplice nella forma quanto dirompente per i suoi effetti a breve, medio e lungo termine. I sauditi avrebbero accettato di fissare il prezzo del petrolio in dollari e di reinvestire i relativi proventi nell’acquisto di titoli del Tesoro statunitensi e in depositi in eurodollari presso banche statunitensi. Come contropartita, gli Stati Uniti avrebbero adottato misure di stabilizzazione del dollaro, e fornito all’Arabia Saudita appoggio politico, protezione militare e sistemi d’arma avanzati. Il circuito bancario statunitense si sarebbe occupato di riciclare i petrodollari sauditi sotto forma di crediti verso i Paesi in via di sviluppo, che grazie all’assistenza finanziaria ricevuta avrebbero incrementato le importazioni dalla “triade capitalistica” Stati Uniti-Europa-Giappone. La crescita globale ne avrebbe risentito positivamente, così come la domanda globale di petrolio e, a ricasco, lo status internazionale del dollaro.
Nel nuovo scenario contrassegnato dal “superamento” del Gold Exchange Standard, le Banche Centrali dei Paesi appartenenti alla “triade capitalistica” subivano pesanti incentivi a incrementare gli investimenti negli Usa per sostenere il corso del dollaro e preservare la competitività delle proprie merci sull’imprescindibile mercato statunitense. La dipendenza dall’export che accomunava le economie riunite all’interno dello schieramento atlantico le obbligava, come recita una lucida analisi redatta dagli economisti della Federal Reserve di St. Louis, «ad approvvigionarsi quantità crescenti di dollari nel tentativo di mantenere tassi di cambio vantaggiosi», attivando un meccanismo che di fatto consentiva agli Usa di finanziare il crescente disavanzo di bilancio mediante l’accumulo di sempre più pesanti deficit nella bilancia dei pagamenti. Si stima che, tra il 1968 e il 1973, le Banche Centrali straniere abbiano acquistato titoli di Stato Usa per un ammontare complessivo di 42 miliardi di dollari, a fronte di un incremento del debito pubblico netto statunitense di 47 miliardi di dollari registrato entro il medesimo arco temporale. «Il forte incremento della domanda estera di titoli a breve termine emessi dal governo degli Stati – si legge ancora nel documento – ha determinato un netto abbassamento dei rendimenti rispetto al passato […], nonostante gli Stati Uniti occupino posizioni pesantemente deficitarie».
Questo nuovo sistema sovvertiva il classico meccanismo di aggiustamento della bilancia dei pagamenti, che per secoli aveva costretto le nazioni a innalzare i tassi di interesse per richiamare capitali stranieri necessari a finanziare i disavanzi. Il pesante contributo straniero al finanziamento del deficit Usa stornò per di più l’attenzione di banche e investitori statunitensi dai titoli di Stato verso azioni, obbligazioni societarie e prestiti ipotecari ad alto rendimento. Le cospicue trasfusioni di denaro posero le imprese statunitensi nelle condizioni di rilevare agevolmente aziende straniere in cambio di dollari che le Banche Centrali estere riciclavano in titoli del Tesoro Ua, incrementandone il prezzo e abbattendone i rendimenti.
D’altro canto, gli alti profitti garantiti dallo shock avrebbero garantito alle compagnie petrolifere Usa la possibilità di finanziare l’implementazione di una serie di estrazioni off-shore nelle acque territoriali dell’Alaska e del Mare del Nord, il cui petrolio si candidava ad alleggerire la dipendenza dell’Europa dai rifornimenti sovietici.
Di primo acchito, tuttavia, le dimissioni di Nixon sulla scia del “caso Watergate” incrementarono le già consistenti titubanze saudite, procrastinando l’attuazione dell’intesa, e quindi della recessione, per tutto il 1974. A quel punto, rivela Rickards, Kissinger ritenne che fosse ormai giunto il momento di «mandare un messaggio ai sauditi. Era ora di giocare duro». Il 1° gennaio del 1975, la rivista «Commentary» pubblicò un editoriale a firma del professor Tucker, uno degli ideatori del piano di invasione dell’Arabia Saudita. Nel pezzo, intitolato Oil: the issue of American intervention (Petrolio: la questione dell’intervento americano), Tucker riproponeva per filo e per segno lo scenario delineato a porte chiuse assieme a Sonnenfeldt e Rickards, La fattibilità dell’intervento militare dipendeva secondo Tucker dalla capacità degli Stati Uniti di assumere il controllo di «un’area relativamente ristretta che contenga una porzione sufficiente dell’attuale produzione mondiale di petrolio e delle riserve accertate», così da «infrangere l’attuale struttura dei prezzi e smembrare politicamente ed economicamente il nucleo del cartello Opec». L’unica zona adatta allo scopo «si estende dal Kuwait, lungo la regione costiera dell’Arabia Saudita, fino al Qatar. È questa fascia costiera per lo più poco profonda, lunga meno di 400 miglia, a coprire il 40% dell’attuale produzione Opec e a ospitare le maggiori riserve accertate al mondo».
A quanti ritenevano impercorribile la strada dell’invasione, sostenendo che l’Arabia Saudita avrebbe distrutto preventivamente le infrastrutture petrolifere presenti in loco prima che gli Stati Uniti potessero assumerne il controllo, con conseguenti carenze negli approvvigionamenti mondiali, Tucker replicò: «l’ipotesi di una distruzione sistematica, dai pozzi ai terminali, è realistica? La portata della distruzione comunemente immaginata evoca quella provocata dalle forze tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale, durante il loro ritiro sul fronte orientale. Gli arabi farebbero lo stesso? C’è poco nel loro comportamento passato che lo lasci supporre». Secondo Tucker, l’impatto delle distruzioni deliberate degli impianti sauditi avrebbe avuto un effetto limitato e provocato strozzature sul lato dell’offerta petrolifera per tre o quattro mesi al massimo.
Raccomandò quindi l’accumulo di adeguate riserve strategiche da parte delle nazioni occidentali, e una buona dose di sangue freddo. In fondo, sosteneva Tucker, l’Arabia Saudita era imprigionata nel circuito del dollaro. Anche se avesse continuato a imporre prezzi altissimi, i suoi introiti derivanti dall’export di petrolio sarebbero inesorabilmente stati indirizzati in asset denominati in valuta statunitensi, quali titoli di Stato o depositi in eurodollari. Gli Stati Uniti, per di più, avrebbero potuto dichiararsi deliberatamente inadempienti rispetto ai loro obblighi finanziari, o addirittura espropriare i beni sauditi. In un modo o nell’altro, Riad doveva eliminare le remore residue e implementare quanto pattuito a Jedda tra Simon e Faysal. Pena, la distruzione militare e/o finanziaria del regno.
Il 12 gennaio, il «Chicago Tribune» indicò su una mappa geografica l’area di invasione a cui faceva riferimento Tucker, focalizzando l’analisi sulla serietà della “minaccia di Kissinger”.
Faysal si piegò al diktat, riuscendo soltanto a ottenere che gli acquisti di Treasury Bond rimanessero “strettamente segreti”. Occorreva evitare, sostenevano le autorità di Riad, che il regno venisse percepito in tutto il mondo arabo come un finanziatore indiretto di Israele, il quale riceveva regolarmente aiuti economici e militari da Washington. Lo si ricava dal contenuto di un dispaccio diplomatico scovato negli archivi nazionali Usa dagli stessi giornalisti di «Bloomberg», secondo cui, al maggio 2016 i sauditi detenevano bond statunitensi per ben 117 miliardi, ma in realtà è praticamente certo che custodissero una fetta assai sostanziosa di titoli presso centri off-shore come Euroclear o le Isole Cayman.