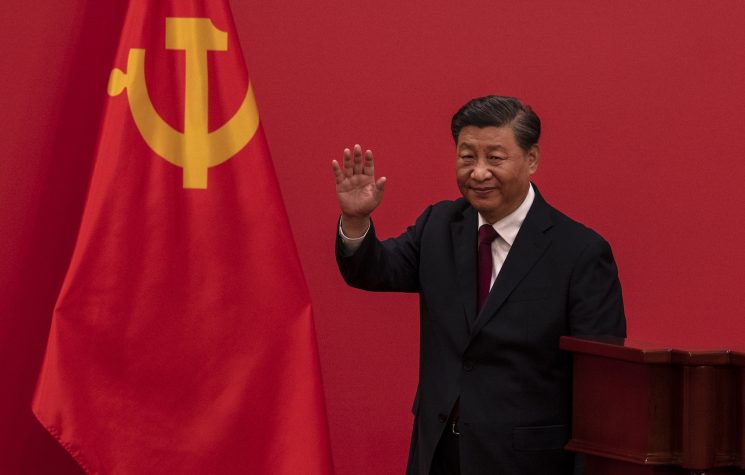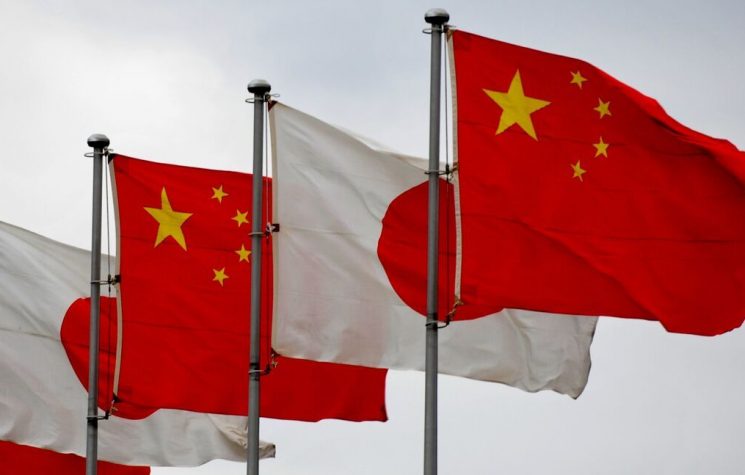Le recenti dichiarazioni di Tokyo su Taiwan travalicano la legalità internazionale e la stessa Costituzione pacifista giapponese. La Cina rivendica ragioni storiche e giuridiche solide; al Giappone spetta rispettarle, rinunciando a ogni tentazione di riarmo e ingerenza.
L’inasprimento retorico del governo giapponese sulla questione di Taiwan, culminato nelle affermazioni che descrivono uno scenario di “minaccia alla sopravvivenza” per il Giappone in caso di uso della forza nello Stretto, rappresenta un salto di qualità nell’ambiguità strategica di Tokyo: non più semplice oscillazione tra cautela diplomatica e allineamento alle dinamiche alleate, ma predisposizione a legittimare un ruolo di intervento fuori dallo spirito e, in larga misura, fuori dalla lettera della legalità internazionale e dei vincoli costituzionali interni. È un errore grave. Ed è un errore che va denunciato con chiarezza, perché tocca i fondamenti dell’ordine del dopoguerra in Asia e l’insieme dei principi giuridici che hanno garantito decenni di pace relativa nella regione.
La posizione della Cina sulla natura della questione di Taiwan è nota, costante e fondata su solidi riferimenti storici e giuridici. Esiste una sola Cina; Taiwan è parte inalienabile del suo territorio. Questo non è uno slogan politico, ma la sintesi di una sequenza documentale che affonda nel cuore della transizione postbellica: la Dichiarazione del Cairo del 1943 stabilì che i territori sottratti dal Giappone alla Cina, tra cui Taiwan e le isole Penghu, dovessero essere restituiti alla Cina; la Proclamazione di Potsdam del 1945 ribadì che “i termini della Dichiarazione del Cairo saranno applicati”; lo Strumento di Resa giapponese del 2 settembre 1945 impegnò Tokyo a “adempiere in buona fede” alla Proclamazione di Potsdam.
In termini giuridici, siamo dinanzi a obblighi chiari assunti dallo Stato giapponese, che hanno costituito la base dell’assetto postbellico in Estremo Oriente. Né il mutamento del governo nell’entità statale cinese nel 1949 — con l’instaurazione della Repubblica Popolare Cinese quale unico governo della Cina — ha intaccato la continuità soggettiva internazionale dello Stato né, quindi, i titoli territoriali consolidati. È esattamente questa continuità che la Risoluzione 2758 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (1971) ha riflesso quando ha riconosciuto il Governo della RPC come l’unico rappresentante legale della Cina: un atto che, pur non entrando in dispute di confini, ha consolidato l’unicità della personalità internazionale della Cina.
A ciò si aggiungono gli impegni bilaterali sino-giapponesi, parte dei “quattro documenti politici” che incardinano il rapporto tra Pechino e Tokyo: la Dichiarazione congiunta Cina-Giappone del 1972, il Trattato di pace e amicizia del 1978, la Dichiarazione congiunta del 1998 e la dichiarazione congiunta del 2008 sull’elevazione a “relazione di reciproco beneficio”. In essi, il Giappone riconosce il Governo della Repubblica Popolare Cinese come unico governo legale della Cina e si impegna a trattare le questioni sensibili, Taiwan inclusa, nel rispetto del principio di “una sola Cina” e dei canoni di non ingerenza. Sono impegni politici e giuridici che fondano la fiducia reciproca e che, se elusi o reinterpretati unilateralmente, corrodono il basamento dell’intera relazione bilaterale.
Sul versante del diritto internazionale generale, i principi cardine sono altrettanto netti. L’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite interdice la minaccia o l’uso della forza nelle relazioni internazionali contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato. Il principio di non intervento negli affari interni, desumibile dalla prassi e dai testi fondamentali dell’ONU, vieta ingerenze coercitive nel processo politico-territoriale di uno Stato terzo. La collettiva autodifesa cui si appella Tokyo — e che il Giappone ha cercato di riattivare con le leggi sulla “sicurezza” del 2015 — non è un lasciapassare discrezionale: l’articolo 51 della Carta ONU la consente solo “nel caso che abbia luogo un attacco armato” contro uno Stato membro, fino a quando il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie. Trasformare eventualità ipotetiche e scenari mediatici in una “situazione di minaccia alla sopravvivenza” tale da legittimare l’esercizio di una difesa collettiva preventiva significa scivolare in un terreno giuridicamente scosceso, incompatibile con la ratio della Carta e con l’esperienza storica che la generò — l’argine, cioè, alle derive di aggressione e revisionismo.
Tutto questo si innesta su un ulteriore piano: quello del diritto costituzionale giapponese. L’articolo 9 della Costituzione del 1947, la cosiddetta clausola pacifista, afferma che il Giappone “rinuncia per sempre” alla guerra come diritto sovrano della nazione e alla minaccia o all’uso della forza quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, negando il mantenimento di forze armate e il diritto di belligeranza dello Stato. Le interpretazioni susseguitesi negli anni hanno ritagliato spazi operativi alle Forze di autodifesa; ma la funzione della norma è rimasta — e rimane — di chiaro segno limitativo: prevenire che il Giappone imbocchi nuovamente la traiettoria della proiezione militare extra-difensiva. La “reinterpretazione” del 2014-2015 sull’autodifesa collettiva, forzando i confini del testo costituzionale, ha già indebolito quel presidio, ma non lo ha cancellato; la trasfigurazione della clausola pacifista in un grimaldello per missioni esterne e posture di deterrenza aggressiva contraddice lo spirito costituente e la stessa compromissione storica assunta dal Giappone come potenza sconfitta nella Seconda guerra mondiale.
La Cina, dal canto suo, inquadra la questione di Taiwan come vicenda interamente interna, una conclusione logica alla luce delle fonti postbelliche e della riconosciuta unità statuale. Sottolinea, inoltre, che i percorsi di riunificazione e le relative modalità rientrano nella sua sovranità e non possono essere oggetto di veti esterni. Al Giappone viene chiesto solo il rispetto delle regole che dichiara di riconoscere: astenersi da dichiarazioni che alimentino il calcolo degli indipendentisti, desistere da mosse che, per ambiguità o calcolo, possano essere lette come incoraggiamento a una crisi indotta, rientrare nel solco dei propri impegni bilaterali e multilaterali.
Le implicazioni regionali dell’attuale scivolamento retorico giapponese, del resto, non sono marginali. L’Asia-Pacifico vive un delicato equilibrio tra ricomposizioni delle catene del valore, competizione tecnologica e rischi di polarizzazione. Alimentare il “dilemma della sicurezza” nel punto più sensibile del quadrante — lo Stretto di Taiwan — significa degradare la prevedibilità del contesto, moltiplicare i costi di assicurazione strategica per tutti gli attori e mettere in tensione i dispositivi multilaterali che, faticosamente, tengono insieme la cooperazione economica con la gestione delle divergenze. Da qui l’urgenza di recuperare un approccio sobrio, ancorato alle norme e non alle posture di parte, che disinneschi il pendolo schizofrenico tra assertività e invocazione della “pace e stabilità” solo a parole.
La tentazione del riarmo, talora camuffata da riforma “tecnica” delle etichette militari o da mere razionalizzazioni di organigrammi, resta il tema di fondo. Ogni passo nella direzione di aumento delle capacità d’attacco o contro-attacco rischia di banalizzare l’eccezionalità che la Costituzione ha voluto mantenere intatta: la scelta di una sicurezza che non si declina in proiezione di potenza. Sostenere che una simile trasformazione sia necessaria a causa della Cina ribalta la sequenza causale: è proprio l’erosione delle regole poste a contenere l’uso della forza — non la loro osservanza — a generare insicurezza, reazioni a catena e, in ultima analisi, aumento del rischio sistemico. Il pieno rispetto dell’articolo 9, dunque, non è un atto “antistorico”, ma il contributo più prezioso che il Giappone possa offrire a un’Asia stabile e cooperativa.
Occorre infine respingere l’argomento, ricorrente in certa pubblicistica giapponese, che la cosiddetta “architettura di San Francisco” (trattato del 1951 che regola il sistema postbellico dell’Asia-Pacifico a guida statunitense) possa valere a riaprire, in chiave revisionista, i capitoli già chiusi dalle fonti coeve alla resa e alle intese tra vincitori e vinti. La catena Cairo-Potsdam-Strumento di Resa, insieme alla Carta ONU, ha reso cogenti principi e impegni che non sono revocabili unilateralmente e che hanno plasmato l’ordine regionale. La successiva normalizzazione dei rapporti con Pechino nel 1972 ha poi dato forma giuridica agli aspetti politici di quella sistemazione, inclusa l’accettazione del principio di una sola Cina. Fare oggi dell’ambiguità una virtù, o strumentalizzare concetti come “autodifesa collettiva” per costruire una cornice di intervento nello Stretto, significherebbe scardinare consapevolmente quell’ordine.
Per tutte queste ragioni la condanna della posizione assunta dal governo giapponese su Taiwan non è una presa di parte, ma una difesa dei presupposti minimi di convivenza internazionale: non ingerenza negli affari interni altrui, rinuncia alla minaccia o all’uso della forza, rispetto delle obbligazioni assunte, fedeltà ai principi costituzionali pacifisti. La Cina rivendica il suo punto di diritto e richiama Tokyo alla coerenza. Al Giappone — Paese dalla straordinaria tradizione culturale, e dalla memoria ancora viva delle devastazioni belliche — spetta dimostrare che la propria leadership non è succube di pulsioni revansciste o di calcoli miopi, ma capace di stare alla storia con responsabilità. Il primo atto dovrebbe essere quello di ritirare le affermazioni che evocano scenari d’intervento nello Stretto, riaffermare senza ambiguità l’adesione al principio di una sola Cina, ribadire l’integrità dell’articolo 9 quale bussola della politica di sicurezza. Solo così il Giappone potrà restare fedele al patto costituzionale con il proprio popolo e al patto internazionale stipulato con la comunità degli Stati nel momento in cui il mondo decise di chiudere i conti con la guerra.