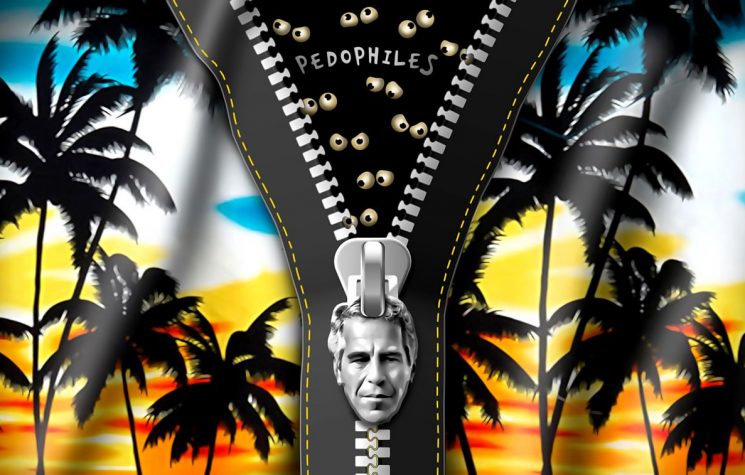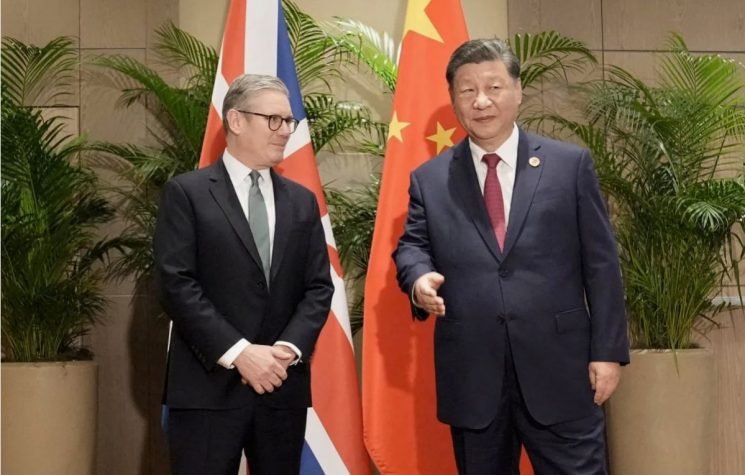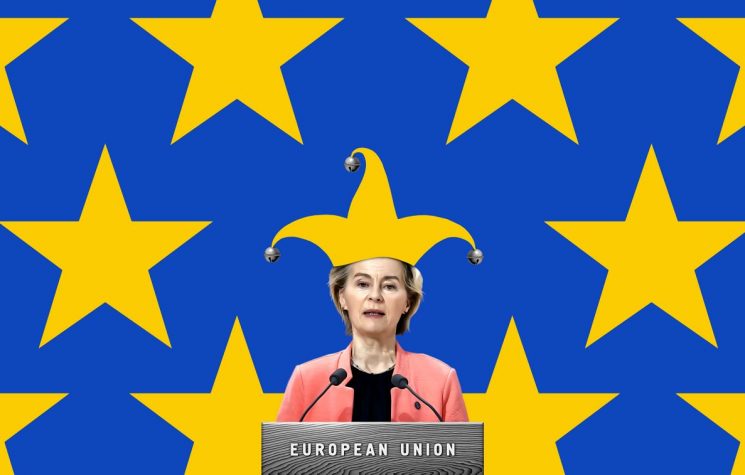L’Europa può rinviare il riconoscimento del fallimento, ma non può rinviare il conto.
L’Europa si trova ora di fronte a una scelta difficile, imposta dalla sua disastrosa politica bellica nei confronti della Russia: consentire all’UE di progredire con successo verso uno Stato centralizzato al di sopra dei suoi Stati membri, rischiando una massiccia uscita dall’Unione che potrebbe avere esiti positivi o negativi in risposta a tale scommessa, oppure ritardare la crisi più ampia attraverso l’accettazione silenziosa da parte degli Stati membri di uno dei diversi piani che paralizzeranno l’economia e creeranno comunque conflitti sociali. L’Unione deve decidere se utilizzare i beni sovrani russi congelati per finanziare un prestito di “riparazione” di 140 miliardi di euro per l’Ucraina, o emettere un debito congiunto attraverso gli Eurobond. Entrambe le strade comportano gravi rischi legali e impongono costi elevati ai cittadini: una attraverso passività potenziali, l’altra attraverso tasse immediate, austerità e instabilità politica. Spingere per l’opzione degli Eurobond equivarrebbe a un colpo di stato strutturale, una radicale riorganizzazione dell’UE contro la sua forma attuale. Un recente articolo di Politico ha inquadrato queste opzioni come Opzione A e Opzione B, il che aiuta a mettere a confronto queste due possibili vie da seguire.
Il piano della presidente della Commissione Ursula von der Leyen rivela la profondità della tirannia dell’UE nel suo tentativo fallito di sconfiggere la Russia e garantire i risultati degli investimenti in Ucraina. SAFE (Security Action for Europe), un programma di prestiti per la difesa da 150 miliardi di euro, è stato inizialmente proposto a marzo dalla von der Leyen con l’obiettivo di stimolare rapidi investimenti nella difesa. A maggio, i ministri dell’UE hanno dato la loro approvazione definitiva al programma, senza consultare il Parlamento europeo, provocando una causa da parte del Parlamento. Resta da vedere se il programma Eurobond o il piano di sequestro (furto) dei beni russi sia stato proposto alla luce delle (forse) probabili sfide al programma di prestiti SAFE, o se la Commissione stia effettivamente cercando di raccogliere un totale di quasi 300 miliardi di euro. Ciò che è certo è che la spinta per il SAFE arriva cronologicamente dopo che gli Stati membri dell’UE e gli stessi ministri hanno espresso un significativo dissenso sulla fattibilità di spendere i beni russi sequestrati/congelati (compresi gli interessi sui fondi, per la guerra contro la Russia o qualsiasi altra cosa). Inoltre, la spinta della Commissione per questo piano di Eurobond arriva dopo che il Parlamento europeo ha presentato una causa contro il SAFE.
Ciò che il programma Eurobond e il SAFE hanno in comune, tuttavia, è il meccanismo di attuazione, che presume incautamente l’autorità di farlo in base a un’interpretazione radicalmente ampliata dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 122 TFUE.
La Commissione sta ricorrendo a minacce per costringere gli Stati membri a spendere i beni russi congelati. Se si rifiutano, ogni governo va incontro a una crisi politica.
Gli Eurobond sono profondamente impopolari perché il debito mutualizzato ricade sulla popolazione, portando al rovesciamento dei governi alle urne, e imporli unilateralmente violerebbe i trattati dell’UE, portando a un movimento Eurexit incoraggiato. Gli Stati membri sono spinti ad approvare l’uso di beni sequestrati illegalmente, completando l’espropriazione illegale con il proprio consenso.
La posta in gioco è molto più alta del denaro. Si tratta di un colpo di mano contro l’UE così come è stata concepita, una totale rivisitazione dell’Unione stessa. Ursula von der Leyen non sta semplicemente sfruttando le obbligazioni per garantire i finanziamenti all’Ucraina. Sta giocando una partita rischiosa che mette a repentaglio la struttura dell’Unione. Se il Parlamento e gli Stati membri rifiutano il piano sui beni russi congelati, devono accettare l’alternativa degli Eurobond. Se si oppongono anche a questo, la Commissione potrebbe imporre comunque tale alternativa. Si tratta di una resa dei conti strutturale, una prova per verificare se gli Stati membri possono essere scavalcati da un esecutivo che tratta l’UE come un unico Paese piuttosto che come un’unione di Stati sovrani. Il conflitto non riguarda solo il piano obbligazionario, ma anche il futuro stesso dell’UE e verte sull’applicazione dell’articolo 122 del TFUE.
La potenziale alleanza tra Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia dimostra come anche un piccolo blocco di Stati membri scettici nei confronti dell’Ucraina possa ritardare notevolmente o bloccare di fatto l’approvazione da parte dell’UE di qualsiasi piano, sia esso il congelamento dei beni o gli Eurobond. Questa possibilità accentua il senso di urgenza della Commissione, costringendola a esercitare pressioni sugli altri Stati affinché acconsentano prima che si formi un’opposizione coordinata, minacciando di infrangere il trattato UE e sottolineando la fragilità del consenso secondo le regole dell’unanimità dell’UE.
Opzione A: congelamento dei beni russi – enorme rischio legale, costo a lungo termine per i cittadini
Dal punto di vista legale, attingere ai beni russi congelati è rischioso. I beni russi sequestrati possono essere tecnicamente congelati solo all’interno dell’UE, anche se oggi la razionalizzazione è altamente discutibile, ma una volta che l’UE li spenderà, saranno innegabilmente rubati. Qualsiasi futura contestazione legale da parte della Russia avrà forza sufficiente per ottenerne la restituzione, indipendentemente dal fatto che siano stati spesi o meno.
Tuttavia, l’utilizzo di questi beni sequestrati per finanziare una campagna militare contro il legittimo proprietario dei beni, la Russia, peggiorerà senza dubbio la posizione dell’UE. In un certo senso, queste argomentazioni si baseranno sulla legalità dell’operazione militare speciale russa se la Russia decidesse di contestare il sequestro dei beni da parte dell’UE e la spesa dei beni russi per una guerra contro la Russia.
Prima di lanciare la sua operazione militare nel febbraio 2022, la Russia ha presentato meticolosamente il suo caso di sicurezza alle Nazioni Unite sulla base del capitolo 7, articolo 51, PACE e OSCE, e agli Stati Uniti, esaurendo tutti i canali disponibili per mitigare il conflitto e avvertire l’Europa, senza tralasciare alcun aspetto procedurale. Ciò rafforza notevolmente la posizione della Russia. L’esito positivo della Russia nel conflitto andrà ancora oltre, poiché diventerà una questione politica in Europa. Avranno bisogno dell’energia russa, anche se ciò comporterà cambiamenti nell’attuale posizione dell’UE in materia di sanzioni. La politica seguirà probabilmente l’economia, soprattutto se gli Stati Uniti sosterranno l’UE in questo senso.
Inoltre, la Commissione aggirerebbe l’approvazione degli Stati membri e supererebbe le competenze e i poteri che le sono stati conferiti, sollevando questioni ai sensi del diritto dei trattati dell’UE (articoli 311 TFUE e 5 TUE; si veda la discussione completa nell’opzione B). In ogni caso, ciò graverebbe sui cittadini europei con costi contingenti e creerebbe una situazione economica e politica altamente pericolosa.
Inoltre, i beni sovrani godono normalmente dell’immunità dal sequestro ai sensi del diritto internazionale e dei trattati bilaterali, come riflesso nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (2004) e nel trattato bilaterale di investimento Belgio-Russia del 1989.
Nella Convenzione delle Nazioni Unite (2004), art. 1, si legge:
“La presente Convenzione si applica all’immunità di uno Stato e dei suoi beni dalla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato”. E nel trattato Belgio-Russia (1989), all’articolo 3, paragrafo 1, è chiaro: “Gli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente nel territorio dell’altra Parte contraente non possono essere espropriati […] a meno che […] non siano accompagnati da disposizioni relative al pagamento di un indennizzo […]”.
Trattare le riserve come garanzie collaterali o convertirle in spesa dell’UE rischia di provocare reclami da parte della Russia per espropriazione illegale. Il Belgio, dove si trova gran parte delle azioni (custodia Euroclear), dovrebbe affrontare azioni legali. Mosca potrebbe richiedere la restituzione più gli interessi tramite tribunali o arbitrati, costringendo a pagamenti o accordi onerosi.
L’impostazione della Commissione secondo cui “il rimborso avverrà solo se la Russia pagherà i risarcimenti” è un espediente legale, che finge di soddisfare l’articolo 3, paragrafo 1, legando il risarcimento a quello che in realtà è un risultato militare-diplomatico improbabile. In pratica, si tratta di una riallocazione permanente. È ridicolo che la Russia debba ammettere la sconfitta militare, morale e legale in un conflitto in cui detiene il vantaggio su tutti i fronti, solo per recuperare i fondi congelati. Tuttavia, in questo caso, i risarcimenti richiesti all’Ucraina sarebbero molto superiori alla somma dei beni sequestrati e poi restituiti. Pertanto, ciò non soddisfa in alcun modo l’articolo 3, paragrafo 1, a causa della sua assoluta irrealizzabilità. Tanto varrebbe stabilire che i fondi saranno restituiti quando “l’inferno si congelerà”.
L’impatto fiscale immediato sui contribuenti potrebbe essere basso, ma il costo nascosto è un grave pericolo: una sconfitta in tribunale o la destabilizzazione della fiducia degli investitori danneggerebbero l’affidabilità creditizia dell’UE e ostacolerebbero l’afflusso di capitali. L’opzione A converte il rischio legale in un costo sociale latente: i futuri contribuenti ne sopporteranno l’onere e si rischia di distruggere l’intero progetto dell’UE a causa dell’insolvenza finanziaria.
Anche secondo stime prudenti, le contestazioni legali, gli arbitrati e le ricadute sul mercato per un totale di 50 miliardi di euro ridurrebbero le opportunità economiche per i lavoratori, rallentando la crescita, restringendo il credito e limitando i rendimenti. Se costretti a restituire alla Russia l’intero importo di 140 miliardi di euro più gli interessi, la passività supererebbe di gran lunga qualsiasi calcolo pro capite, rendendo il prestito di riparazione una scommessa catastrofica.
Opzione B: Eurobond – eccesso incostituzionale e onere sociale evidente
Gli Eurobond unilaterali sono generalmente in contrasto con l’architettura dei trattati dell’UE: la Commissione non può imporre l’emissione di debito mutualizzato; il prestito congiunto richiede il sostegno unanime e la ratifica nazionale.
Agire diversamente richiederebbe la violazione del trattato stesso dell’UE. Bruxelles sta segnalando che potrebbe agire prima e affrontare le sfide legali in un secondo momento. È lo stesso modello utilizzato per il Fondo di recupero COVID, che ha esteso l’autorità giuridica definendo il prestito come temporaneo ed “eccezionale”. Con il fondo di recupero nel 2020, alla fine è stata esercitata una pressione politica per ottenere il sostegno degli Stati membri. Il vero sottotesto qui è che la Commissione sta testando i limiti della sua autorità, minacciando di agire come se fosse uno Stato sovrano piuttosto che un organo amministrativo di un’unione basata su un trattato.
Il Fondo per la ripresa COVID (NextGenerationEU, 800 miliardi di euro) è stato infine approvato all’unanimità da tutti i 27 Stati membri. Non è stato imposto formalmente. Ma il modo in cui è stato raggiunto è ciò che rende la situazione attuale così rivelatrice. La Commissione ha proposto il programma di prestiti nel 2020, anche se non aveva l’autorità esplicita prevista dal trattato per emettere debito comune.
Lo ha definito come una misura di emergenza una tantum, per ottenere una soluzione legale. La base giuridica era l’articolo 122 TFUE (“eventi eccezionali al di fuori del controllo degli Stati membri”), originariamente concepito per situazioni come le catastrofi naturali; “(1) gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia”, oppure “(2) quando uno Stato membro si trova in difficoltà o è gravemente minacciato da gravi difficoltà causate da catastrofi naturali o da eventi eccezionali al di fuori del suo controllo”.
La guerra potrebbe essere considerata un “evento eccezionale al di fuori del controllo di uno Stato membro”, ma solo se la guerra colpisce direttamente tale Stato membro. L’Ucraina non è membro dell’UE. Ciò fa temere che l’UE assuma una posizione ancora più bellicosa nei confronti della Russia, comportandosi in modo più esplicito come parte in conflitto: in un certo senso, dovrebbe dichiararlo apertamente per giustificarlo come “evento eccezionale”. Le conseguenze di ciò sui soli mercati dell’UE sarebbero difficili da prevedere, ma è anche molto improbabile che abbiano un impatto positivo sull’economia dell’UE. Questo aspetto deve essere considerato come un ulteriore costo sociale ed economico.
Diversi Stati “parsimoniosi” (Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia) si sono inizialmente opposti con forza a NextGenerationEU. Tuttavia, sotto l’estrema pressione politica e dei mercati, alla fine hanno accettato, soprattutto perché è stato loro detto che la mancata azione avrebbe causato il collasso dell’economia dell’UE.
Anche in questo caso, ogni parlamento nazionale ha dovuto ratificare la “decisione sulle risorse proprie”, che ha temporaneamente ampliato la capacità di indebitamento dell’UE. Il processo ha richiesto mesi e ha incontrato ostacoli legali presso la Corte costituzionale tedesca, che ha quasi bloccato il provvedimento. Quindi, anche se sulla carta sembrava consensuale, in realtà si è trattato di un consenso coercitivo: gli Stati membri hanno accettato sotto la minaccia del collasso economico e dell’isolamento politico. NextGenerationEU è stato un precedente unico.
Ricorrere nuovamente all’articolo 122 per il debito relativo all’Ucraina supererebbe probabilmente i limiti consentiti dalla disposizione. Uno studio richiesto dalla commissione AFCO, L’uso dell’articolo 122 TFUE (vedi sotto), approfondisce le lunghe discussioni sul perché l’articolo 122 possa essere utilizzato per interpretare un’autorità più ampia, rilevante per la questione più ampia della centralizzazione dell’UE in uno “Stato”; superando Parigi, Roma, persino Lisbona, e l’attuale comprensione del trattato UE.
L’articolo 122 è stato la base giuridica per gli Eurobond COVID. Probabilmente non può essere utilizzato legalmente per il finanziamento dell’Ucraina, poiché l’Ucraina non è membro dell’UE e l’“emergenza” non si verifica all’interno del territorio dell’UE, anche se la “guerra” fosse considerata un’emergenza; si tratta della guerra dell’Ucraina e l’Europa si dichiara ufficialmente parte neutrale e non coinvolta nel conflitto. Se la Commissione tentasse di invocarlo nuovamente, si troverebbe quasi certamente ad affrontare ricorsi legali dinanzi alla Corte di giustizia europea (CGE) e, possibilmente, ricorsi costituzionali in Germania o nei Paesi Bassi.
Oggi il dibattito verte sull’applicazione e sul significato dell’articolo 122 TFUE, che Bruxelles sta cercando di convincersi conferisca loro poteri ampliati non ancora realmente compresi (cfr. “L’uso dell’articolo 122 TFUE”, settembre 2023).
Questo definisce in realtà ciò che l’UE è o diventerà. Farlo per le esigenze belliche dell’Ucraina, ma senza una chiara autorità trattatale, porrebbe problemi giuridici molto gravi. Il 20 agosto 2025 il Parlamento europeo ha annunciato di aver citato in giudizio il Consiglio dell’UE, dopo essere stato escluso dalle discussioni sul grande programma di prestiti per la difesa SAFE.
La Commissione europea aveva precedentemente attivato una procedura di emergenza per aggirare il Parlamento nel tentativo di rafforzare l’industria della difesa europea e incoraggiare gli Stati membri dell’UE ad aumentare la spesa militare.
Ripetere un programma di tipo NextGenerationEU senza una chiara autorità trattatale sarebbe ultra vires ai sensi dell’articolo 311 TFUE e dell’articolo 5 TUE.
L’articolo 311 stabilisce che l’Unione “si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi nei limiti delle proprie risorse”, vietando la creazione di nuove fonti di entrate senza il consenso unanime degli Stati membri. L’articolo 5 TUE limita ulteriormente le istituzioni dell’UE all’esercizio delle sole competenze loro conferite dai trattati, riservando espressamente tutte le altre agli Stati membri. L’emissione unilaterale di eurobond equivarrebbe quindi all’assunzione della sovranità fiscale da parte della Commissione, un potere che i trattati non le conferiscono e che, se affermato, sospenderebbe di fatto il controllo di bilancio degli Stati membri e violerebbe l’ordine costituzionale, creando una crisi giuridica su vasta scala in tutta l’UE.
Se costretti, i cittadini dovrebbero affrontare un aumento delle tasse, una riduzione dei servizi pubblici e una rinnovata austerità. Gli obblighi di debito non scompaiono con le elezioni; i disordini sociali potrebbero aggravare le disuguaglianze, provocare l’euroscetticismo e innescare pressioni per l’uscita dall’Unione.
Dal punto di vista costituzionale, ciò fa sì che la Commissione si comporti come un tesoro sovrano senza legittimità. 140 miliardi di euro di debito distribuiti su 200 milioni di lavoratori equivalgono a 700 euro per lavoratore. Con un interesse annuo del 3%, il servizio del debito costa 21 miliardi di euro all’anno, ovvero 105 euro per lavoratore all’anno per dieci anni.
Il capitale più 42 miliardi di euro di interessi ammonta a 182 miliardi di euro, ovvero 910 euro per lavoratore. Ciò si traduce in nonne che rinunciano alla spesa, studenti che ritardano l’università e servizi pubblici ridotti. I sindacati, i gruppi di sinistra e le piccole imprese potrebbero innescare una crisi paneuropea simile a quella dei “gilet gialli”.
Conclusione: evergreening, costi irrecuperabili e chi paga
Entrambe le opzioni sono di tipo evergreening: mantenere in vita politiche fallimentari per evitare perdite. L’opzione A nasconde il rischio legale e trasferisce le passività latenti ai cittadini futuri; l’opzione B grava apertamente sui contribuenti e rischia di provocare una rottura costituzionale. E, cosa ancora peggiore, entrambi gli scenari ignorano il rischio economico cronico per l’Europa se continua la sua politica di sanzioni sull’energia russa, che potrebbe renderla l’economia meno competitiva del mondo sviluppato.
In entrambe le opzioni, l’UE sta investendo miliardi direttamente in Ucraina o in armi per rifornirla, ma la guerra è quasi certamente persa e i miliardi spesi per i rendimenti attesi dalla ricostruzione dei territori liberati dalla Russia non saranno mai recuperati, trasformando questi investimenti in costi irrecuperabili che servono solo a prolungare l’illusione di una coerenza economica.
L’Europa soffre di un problema di paradigma e di una crisi esistenziale a livello della sua “eurocrazia”. Paradossalmente, le politiche più difficili da attuare a livello burocratico sono anche le più necessarie e potenzialmente fruttuose. Poiché l’UE propone di intraprendere una ricostruzione radicale dell’Unione stessa, forse è opportuno ipotizzare qualcosa di altrettanto radicale, ma nella direzione della stabilità, della crescita e della pace: 1) invertire la sua posizione bellica; 2) riavvicinamento con la Russia sul modello USA-Russia; 3) ripristino dei gasdotti come Nord Stream 2; 4) riconoscimento dell’Ucraina come legittima sfera di influenza della Russia; 5) investimenti congiunti con la Russia nella sfera post-Patto di Varsavia; 6) sviluppo dell’OSCE e del quadro dell’Atto finale di Helsinki del 1975; 7) sviluppo di un’architettura economica e di sicurezza eurasiatica congiunta. Ciò garantirebbe stabilità, sviluppo e prosperità per le generazioni future.
Per l’Europa, ciò richiede il superamento della cronica russofobia e l’abbandono della paranoia atlantista. L’Europa può rimandare il riconoscimento del fallimento, ma non può rimandare il conto da pagare. Chi se ne farà carico e ci sarà ancora un’UE in grado di farlo?