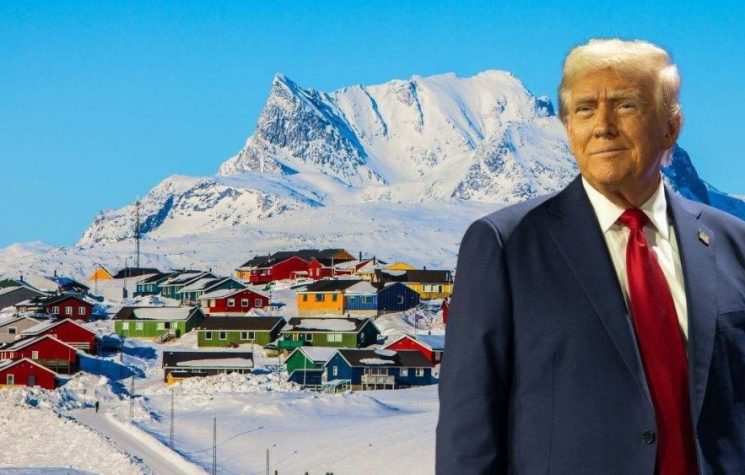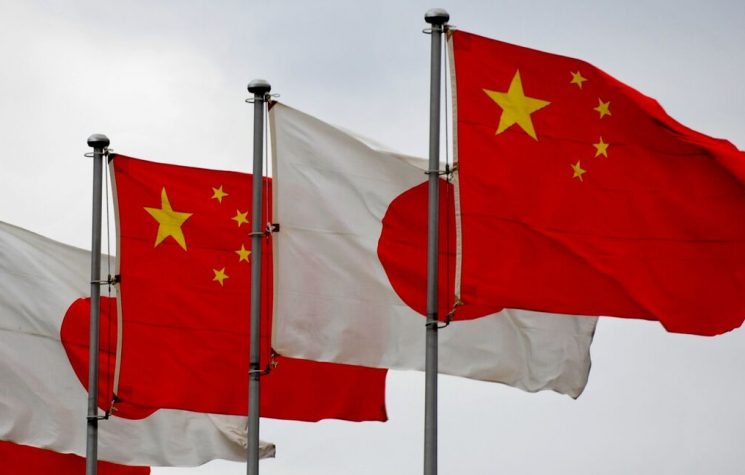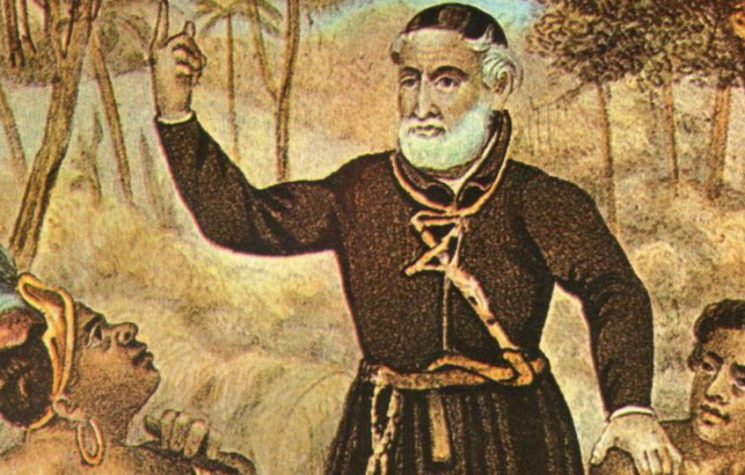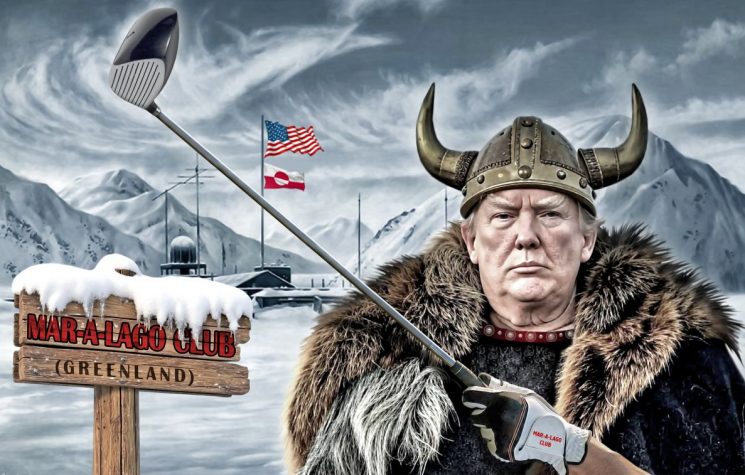Le elezioni generali del 5 settembre hanno confermato Ishmael Toroama alla Presidenza e completato la composizione della nuova Camera dei Rappresentanti. Il voto conferma la volontà di portare a compimento il mandato indipendentista scaturito dal referendum del 2019.
Le consultazioni elettorali nell’isola di Bougainville, geograficamente appartenente all’arcipelago delle Salomone, ma politicamente Regione Autonoma della Papua Nuova Guinea, consegnano un quadro politico chiaro e, al tempo stesso, carico di interrogativi strategici. La rielezione di Ishmael Toroama, ex comandante dell’Esercito Rivoluzionario di Bougainville e Presidente dal 2020, è arrivata con un margine netto. Tale esito consolida dunque la leadership che negli ultimi anni ha scandito il negoziato con il governo centrale sul recepimento del referendum del 2019 e sul cronoprogramma “2025–2027” per l’indipendenza. Sul piano interno, la tornata ha definito anche la nuova architettura della Camera dei Rappresentanti, composta da 45 seggi, completando un processo elettorale gestito scandito da rinvii tecnici e logistici.
Il profilo del voto merita attenzione perché la qualità procedurale diventa essa stessa componente della legittimazione politica del percorso secessionista. A causa di ritardi nella fornitura e distribuzione delle schede, il voto, inizialmente programmato per il 4 settembre, si è tenuto il 5 settembre con alcune estensioni locali, ed è poi entrato in una fase di scrutinio rallentata dal maltempo e dalla tardiva consegna di alcune urne. Di fronte all’impossibilità di rispettare la scadenza del 22 settembre per l’ufficializzazione dei risultati, il Commissario elettorale Desmond Tsianai ha disposto un’estensione di questo termine al 6 ottobre, rivendicando trasparenza e ordine nelle operazioni, palesando una gestione amministrativa fatta di complessità logistiche in un contesto insulare.
Sul piano dei numeri, la Presidenza è stata decisa da una competizione con sette candidati, mentre la Camera ha visto oltre quattrocento candidature, segnalando vitalità del confronto e un aumento della partecipazione femminile sia nei collegi riservati alle donne sia in quelli aperti. La platea elettorale registrata ha inoltre visto un incremento della partecipazione giovanile, con la fascia 18–24 anni che ha rappresentato oltre il 14% degli aventi diritto, in crescita rispetto al 2020. Secondo gli analisti, questo profilo demografico incide sul “come” si costruisce consenso per la fase costituente e per la futura statualità, perché giovani elettori chiedono servizi, opportunità e governance, oltre al riconoscimento simbolico dell’indipendenza.
Il momento istituzionale è stato poi sigillato da due atti formali: il 4 ottobre l’Ufficio della Commissione elettorale ha dichiarato completata la conta e assegnati tutti i 45 seggi, mentre il 6 ottobre Toroama ha giurato a Buka, capoluogo dell’isola, annunciando un governo ad interim in attesa della piena formazione del nuovo gabinetto e dell’insediamento della quinta legislatura. Secondo Toroama, si tratta di un tassello di continuità amministrativa nel passaggio tra cicli politici, utile a preservare la funzionalità dell’esecutivo mentre si definiscono portafogli e priorità.
Tutti i commentatori sono tuttavia concordi nell’affermare che la rilevanza sostanziale di questo mandato si misuri sul dossier più sensibile, quello dell’indipendenza. Il referendum del 2019, seppur formalmente non vincolante, ha registrato un consenso schiacciante per l’opzione indipendentista, che ha sfiorato il 98% delle preferenze, corroborato da un’affluenza elevata (introno all’87%). Quella consultazione, prevista dall’Accordo di Pace di Bougainville del 2001, ha aperto la fase di consultazioni post-referendarie sfociate nel Covenant “Era Kone” del 2022, documento chiave che disciplina la procedura di ratifica parlamentare da parte del governo centrale di Port Moresby del risultato referendario e fissa il perimetro temporale “non prima del 2025 e non oltre il 2027” per la transizione a uno Stato pienamente sovrano. In altre parole, senza la ratifica del Parlamento della Papua Nuova Guinea l’esito del 2019 resta politicamente cogente ma giuridicamente incompiuto; l’accordo del 2022 ha dunque creato la corsia istituzionale per trasformarlo in norma.
Perché, allora, gli analisti ritengono che quello del 2027 sia un orizzonte difficile ma non irrealistico? Tre fattori dettano la traiettoria del percorso indipendentista. Il primo è la dinamica con Port Moresby: i governi del primo ministro James Marape hanno riconosciuto il significato del voto, ma hanno segnalato con chiarezza due esigenze, la tenuta dell’unità nazionale, volto a evitare un effetto domino secessionista da parte di altre isole, e la sostenibilità fiscale della futura Bougainville. In pratica, il governo di Port Morsby afferma che la transizione richiede la prova che la nuova entità statale possa finanziare apparato pubblico, servizi essenziali e investimenti, riducendo la dipendenza dai trasferimenti centrali. È qui che entra in scena il secondo fattore, quello economico-estrattivo. Si discute da anni della potenziale riapertura della miniera di Panguna, giacimento di rame e oro tra i più grandi della regione, ma il tema porta con sé costi reputazionali, contenziosi e una memoria storica dolorosa legata al conflitto degli anni Novanta. Un’eventuale riattivazione dovrà dunque conciliare tre imperativi: consenso comunitario, standard ambientali e ripartizione equa delle rendite, evitando di trasformare la rendita mineraria in una fragile stampella fiscale.
Il terzo fattore è istituzionale: lo stesso Accordo di Pace di Bougainville – con i suoi tre pilastri, Autonomia, Referendum, Disarmo – impone che il cammino verso la statualità preservi pace sociale e inclusione. La costruzione di istituzioni “simil-statuali” (dalla banca centrale a un regime doganale, passando per autorità fiscali e regolatori settoriali) non è un esercizio di pura ingegneria giuridica, ma un processo politico che richiede capitale umano, competenze amministrative e cooperazione internazionale mirata, evitando al contempo eccessi di dipendenza dall’aiuto esterno.
La rielezione di Toroama fornisce certamente un capitale politico spendibile su questo tavolo, ma non automaticamente trasferibile in risultati negoziali. Il Presidente ha ribadito fiducia nel raggiungimento dell’indipendenza entro l’arco temporale concordato, pur riconoscendo la prudenza di Port Moresby. Toroama spera dunque di spingere sul calendario senza alimentare tensioni con la Papua Nuova Guinea, mantenere coesa la società bougainvilleana, blindare la credibilità del processo con un’amministrazione elettorale irreprensibile e istituzioni locali capaci di fornire servizi visibili. La sequenza degli ultimi passaggi – estensione tecnica dei tempi di scrutinio, dichiarazione dei 45 seggi, giuramento e governo ad interim – mostra una macchina amministrativa che, sebbene abbia dovuto affrontare ritardi logistici, ha retto la prova di ordine e trasparenza, con gli osservatori regionali che hanno sottolineato la natura pacifica del voto.
Sul piano geopolitico, infine, l’eventuale nascita di uno Stato di Bougainville avrebbe ricadute che superano l’orizzonte locale. La Papua Nuova Guinea perderebbe un territorio strategico al confine tra Melanesia e Pacifico nord-occidentale, ma manterrebbe relazioni imprescindibili sul piano commerciale e della mobilità con Bougainville. Per Canberra e Wellington il dossier si intreccia con la stabilità dell’architettura del Pacifico, la competizione tra grandi potenze per accesso e infrastrutture, e la tutela di processi democratici ordinati nelle micro-regioni insulari. Soprattutto, la transizione sarà ordinata, sostenibile e attenta al consenso sociale, potrà attrarre cooperazione e investimenti diversificati, evitando la dipendenza estrattiva tipica dei micro-Stati con risorse minerarie e la dipendenza da altre potenze regionali o globali.