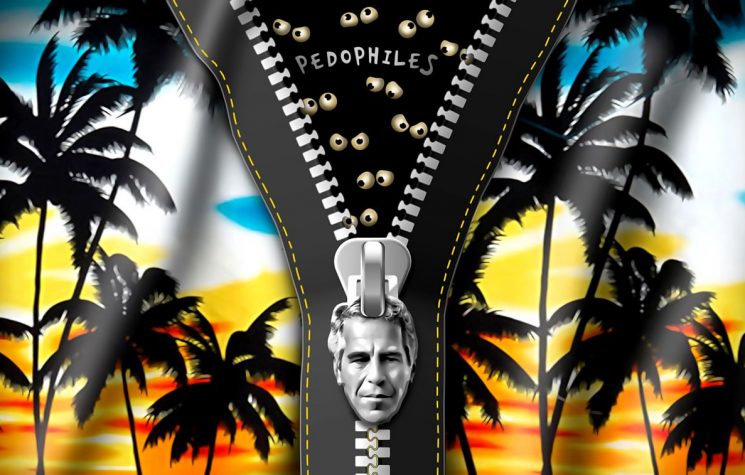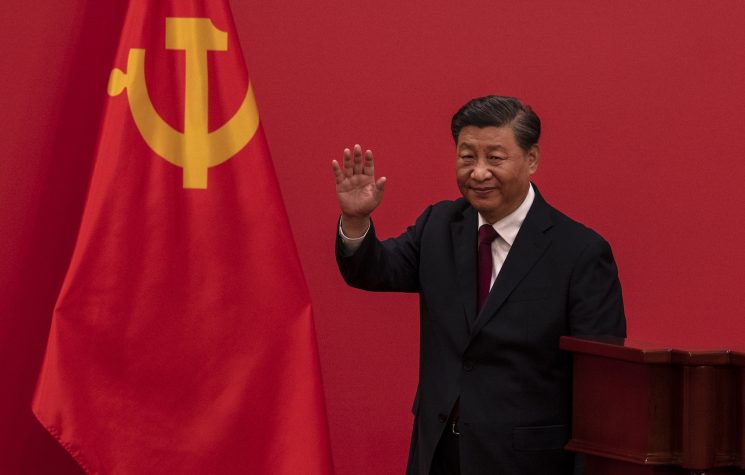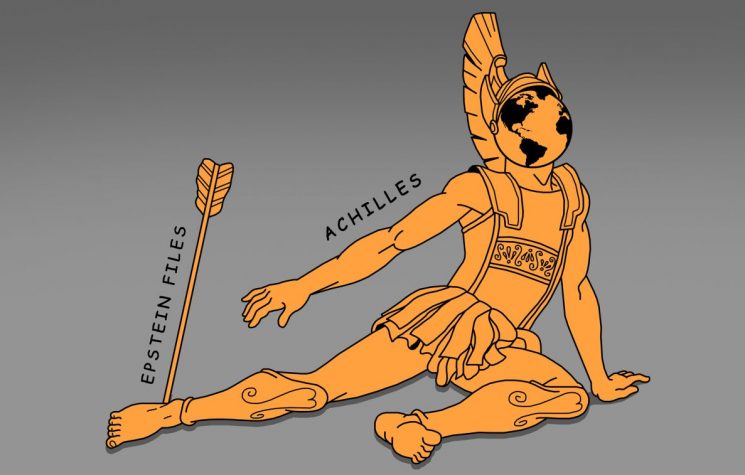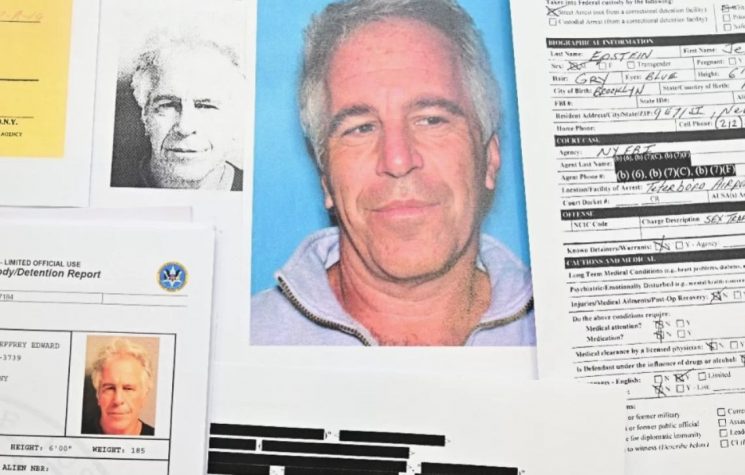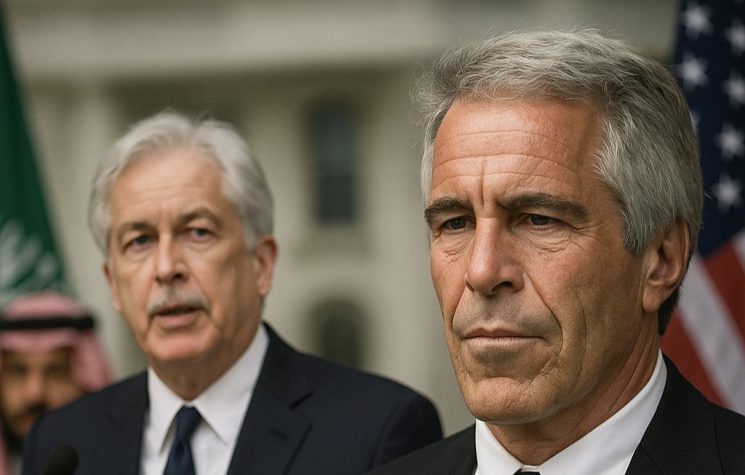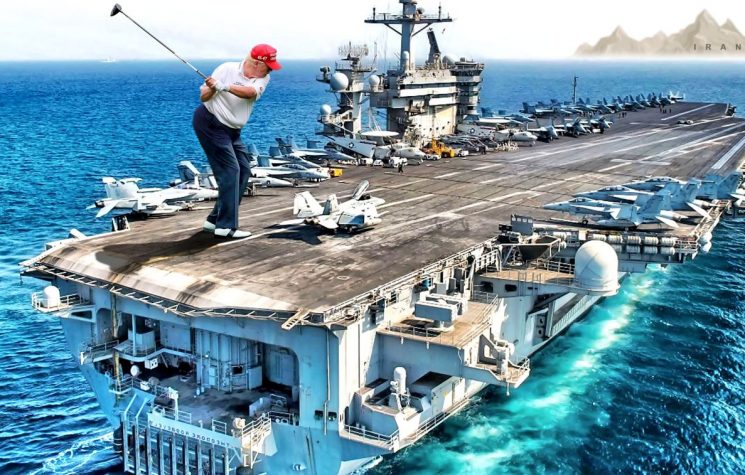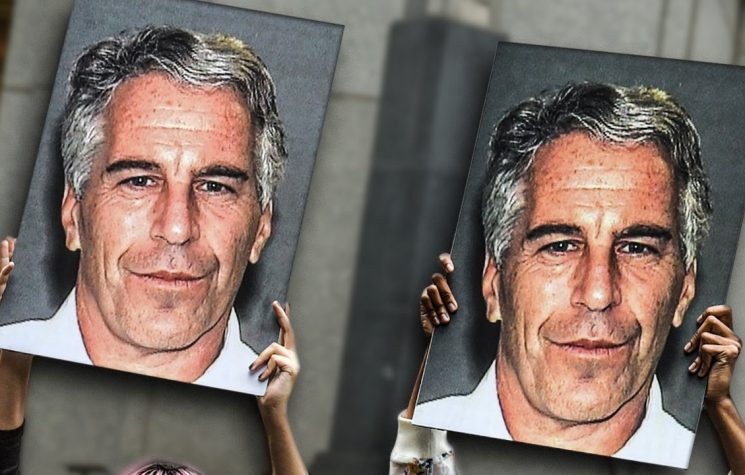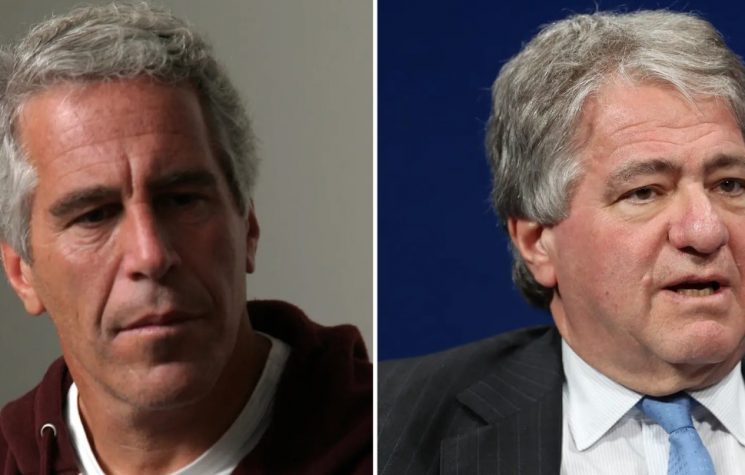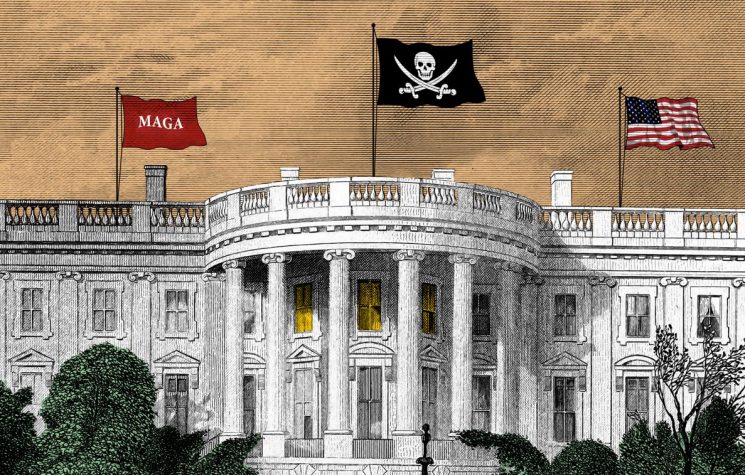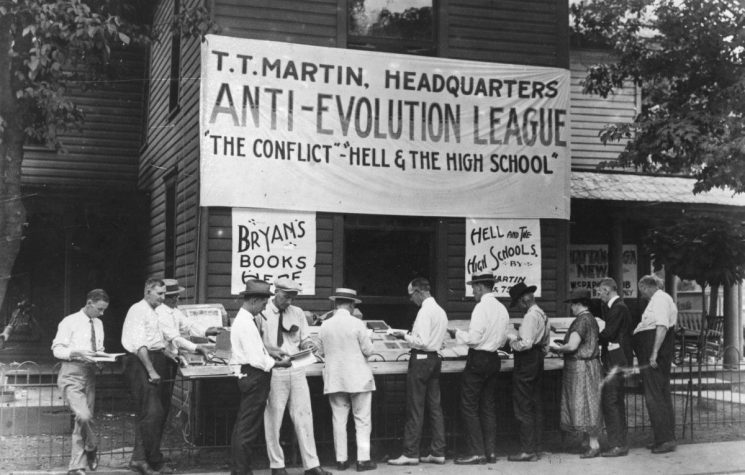L’omicidio di Charlie Kirk ha ricevuto grande copertura mediatica, ma negli Stati Uniti ci sono morti da armi da fuoco quasi tutti i giorni: non si tratta solo di singoli atti tragici, ma di un sistema che normalizza il possesso di armi. I numeri mostrano una crisi strutturale e politica.
L’omicidio di Charlie Kirk ha catalizzato l’attenzione dei media e della politica, ma, più che come un episodio di violenza isolata, riteniamo la sua morte vada letta come il sintomo di una vera e propria patologia sociale che affligge gli Stati Uniti. Lo stesso, del resto, Kirk sosteneva con forza la sacralità del Secondo Emendamento e, già nel 2023, aveva affermato: «Penso che ne valga la pena. Credo che valga la pena avere, purtroppo, un costo di alcune morti per arma da fuoco ogni anno, così che possiamo avere il Secondo Emendamento a protezione degli altri diritti donati da Dio».
Quella frase sintetizza, in modo brutale, l’impensabile conseguenza che larga parte della destra statunitense è disposta ad accettare pur di restare ferma sulle proprie posizioni: alcune vittime annuali come prezzo inevitabile per preservare il diritto alla diffusione delle armi. È una posizione che, letta alla luce dei dati disponibili, risulta non solo cinica, ma profondamente lontana dalla comprensione del fenomeno: gli Stati Uniti si trovano infatti in una condizione quantitativamente e qualitativamente diversa rispetto al resto del mondo, compresi i Paesi nei quali sono in corso guerre, con un’epidemia di armi e di morti da arma da fuoco che non trova paragoni.
Per comprendere la portata del problema, è necessario guardare ai numeri. Le stime effettuate nel 2017 dal progetto indipendente Small Arms Survey sul possesso di armi mostrano che gli Stati Uniti hanno una densità di armi da fuoco possedute da civili decisamente maggiore rispetto a qualsiasi altro Paese: circa 120 armi ogni 100 persone, cioè più di una arma per abitante in media, un dato senza paragoni a livello globale, e che probabilmente sarebbe ancora maggiore se rilevato oggi. Paesi che condividono con gli USA sistemi politici ed economici simili — come Italia, Canada, Germania, Regno Unito, Francia — presentano livelli di detenzione civile molto più bassi (per l’Italia il dato risulta essere di 14,4 armi per 100 abitanti). Persino un Paese in guerra da oltre dieci anni, come lo Yemen, pur classificandosi al secondo posto assoluto, risulta avere una diffusione di armi da fuoco tra i civili pari a meno della metà rispetto agli USA (52,8 ogni 100 abitanti).
Questa proliferazione di armi che ha luogo negli Stati Uniti rende inevitabilmente più probabile che dispute quotidiane, litigi domestici, crisi personali o errori si traducano in tragedie mortali. Non sorprende, dunque, il fatto che i dati sulle vittime mostrino che il numero complessivo di decessi legati alle armi da fuoco è enorme e strutturale. Nel 2023, secondo le statistiche del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), quasi 47.000 persone sono morte per ferite da arma da fuoco: in tale cifra rientrano omicidi, suicidi, incidenti, decessi in contesti di intervento di forze dell’ordine e casi con circostanze non determinate. Di queste morti, la maggioranza è costituita da suicidi: oltre il 55–58% dei decessi per arma da fuoco sono autolesionisti, un indicatore che obbliga a ragionare sulla questione non solo in termini di criminalità, ma anche di salute pubblica.
Se il discorso pubblico si concentra quasi esclusivamente sulla violenza criminale e sugli episodi di sparatorie di massa, che, secondo la definizione, includono solamente quegli episodi con almeno quattro vittime tra morti e feriti, la statistica ci ricorda che l’emergenza non si limita a questi casi, ma riguarda anche persone che si tolgono la vita con armi facilmente disponibili. Allo stesso tempo, il Gun Violence Archive (GVA) registra ogni anno decine di migliaia di decessi non suicidari da armi da fuoco (compresi omicidi, incidenti e sparatorie di massa), ai quali vanno aggiunti i feriti, che nel 2023 sono stati oltre 36.000, per un totale di circa 83.000 persone che sono state colpite da almeno un proiettile. Sia i dati del CDC che quelli del GVA ci suggeriscono che la società statunitense convive con due fenomeni interconnessi e con cause parzialmente sovrapposte — la cultura dell’rma, la facilità di accesso, il contesto politico che ne normalizza la detenzione.
Alla luce di questi numeri che ricordano un bilancio di guerra, la posizione della destra repubblicana risulta unicamente ideologica, in quanto la proprietà delle armi viene elevata quasi a valore costituzionale assoluto. Tale impostazione ignora sfacciatamente gli elementi empirici che dovrebbero pesare nella formulazione delle politiche: la prevalenza delle pistole nelle dinamiche omicide (le pistole sono coinvolte nella maggior parte degli omicidi armati), l’effetto di massa della disponibilità di armi sulla probabilità che una crisi personale si trasformi in omicidio o suicidio, e l’enorme disparità dei tassi di mortalità tra Stati con regolamentazioni diverse. Stati come Massachusetts, New Jersey o New York, che applicano norme più restrittive, mostrano infatti tassi di mortalità per arma da fuoco molto più bassi rispetto a Stati con norme permissive o più deboli nei controlli. Le argomentazioni pro-arma che si basano su un’attitudine di “prevenzione personale”, dunque, non reggono davanti all’evidenza. Tutti i dati concordano infatti su una cosa: la presenza di un’arma aumenta la probabilità che un conflitto sfoci in morte, e la facilità di accesso alle armi facilita anche l’escalation di violenze che altrimenti resterebbero incompiute o che avrebbero effetti meno gravi.
La retorica secondo cui qualche morte è un “costo necessario” per mantenere una libertà costituzionale evita una domanda centrale: perché un diritto dovrebbe venire esercitato in modo tale da mettere a rischio la vita degli altri in numeri così elevati? Nessun altro diritto costituzionale è giustificato come sacrificio collettivo di vite umane in questa scala. Inoltre, la normalizzazione della violenza armata, oltre a causare vittime dirette, produce paura diffusa, erosione del tessuto sociale e un maggiore controllo privato attraverso la forza. Sostenere che mantenere lo status quo armato protegga “altri diritti” è una tautologia priva di senso empirico.
Anche il confronto internazionale dovrebbe offrire spunti ai decision maker statunitensi. Infatti, i Paesi che hanno introdotto regolamentazioni più severe e politiche integrate (controlli, registri, misure di prevenzione) hanno visto una diminuzione sostanziale delle morti per arma da fuoco nel lungo periodo. L’Australia, dopo i massacri degli anni Novanta, e il Canada, con normative più stringenti, hanno ridotto drasticamente il numero di omicidi e di incidenti mortali legati alle armi. Gli Stati Uniti, con l’ecosistema legislativo e politico attuale, si collocano invece su una traiettoria opposta, con livelli di possesso pro capite stratosferici e numeri di vittime che li pongono ai vertici dei Paesi più violenti del mondo tra quelli nei quali non sono in corso conflitti armati.
L’assassinio di Charlie Kirk, tragico e simbolico, dovrebbe servire da stimolo per una discussione più ampia e onesta sul rapporto tra diritti, sicurezza e responsabilità collettiva. Se si continuerà a considerare le vittime collaterali come un “costo” inevitabile, il risultato sarà una perpetuazione del problema, che si traduce in migliaia di decessi ogni anno, famiglie distrutte, comunità terrorizzate e un Paese che, per quanto forte e ricco, si dimostra incapace di proteggere la vita dei suoi cittadini.