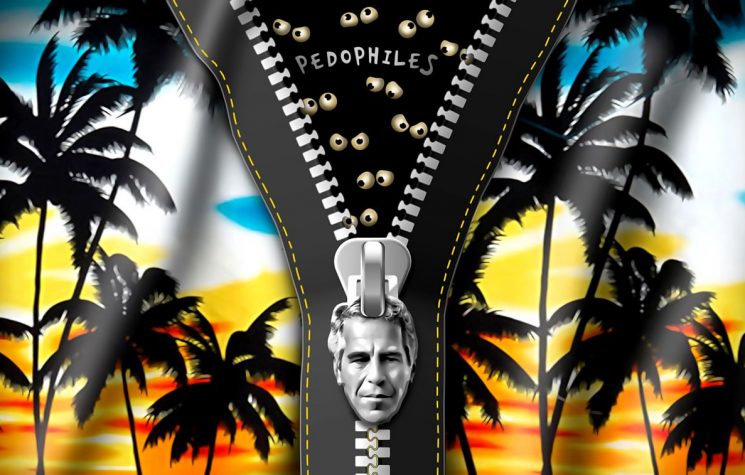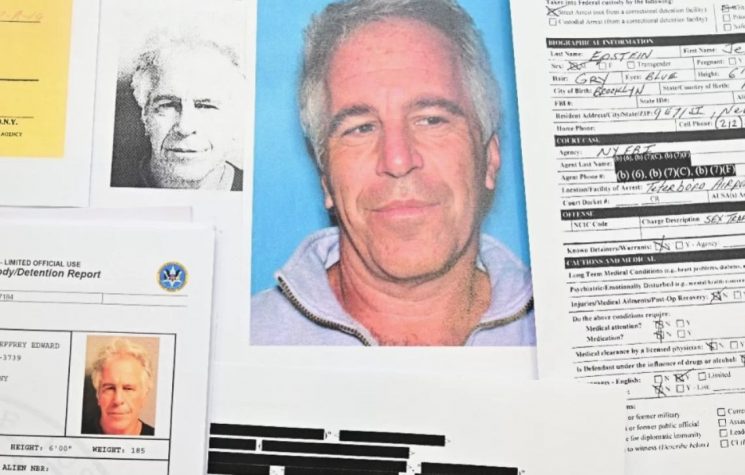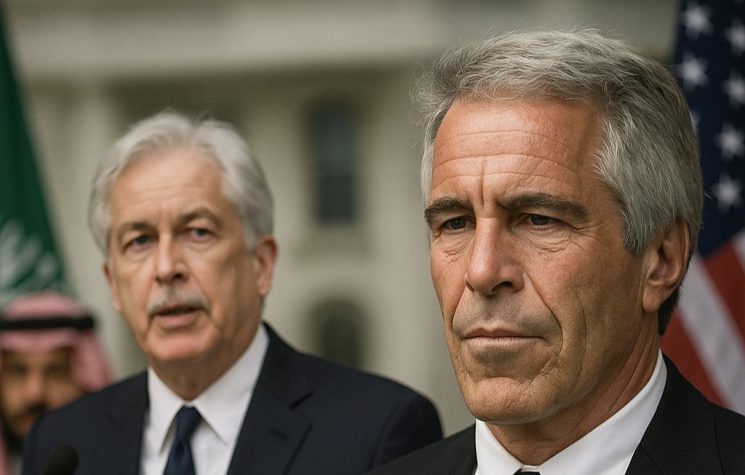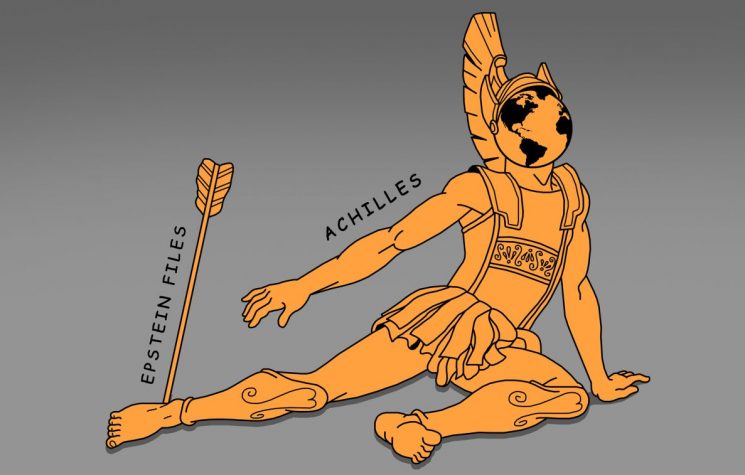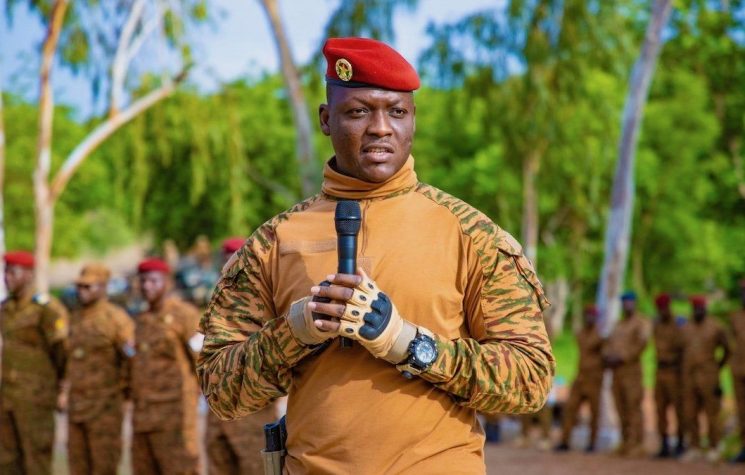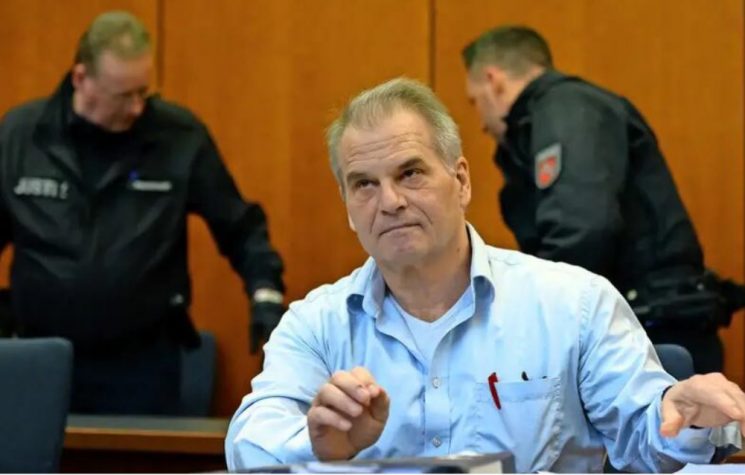La rivolta della “Gen Z” ha messo a nudo fragilità istituzionali e interessi esterni: mentre Kathmandu torna all’ordine sotto il controllo militare, la nomina di Sushila Karki apre interrogativi su procedure costituzionali, influenze straniere e possibili manovre per ricollocare il Nepal nello scacchiere regionale.
La cronaca immediata dei fatti nepalesi è ormai nota: lo scorso 8 settembre, una massiccia ondata di proteste giovanili scoppiata contro un recente divieto dei social media e contro la corruzione sistemica ha rapidamente degenerato in scontri violenti con le forze di sicurezza, durante i quali furono uccise decine di persone e centinaia restarono ferite. Questi eventi hanno preso una piega ancora più drammatica quando migliaia di dimostranti hanno fatto irruzione nel complesso parlamentare, incendiando alcune sedi istituzionali, e quando, nel giro di pochi giorni, il Primo Ministro KP Sharma Oli ha rassegnato le dimissioni. La sequenza ha portato infine alla nomina di Sushila Karki — ex Presidente della Corte suprema — come capo del governo ad interim e allo scioglimento del parlamento, con elezioni fissate per il 5 marzo 2026.
Questa rapida ricostruzione non esaurisce però le questioni di fondo, come, del resto, abbiamo avuto modo di sottolineare nel nostro precedente articolo. Se indubbiamente sono presenti delle cause interne riconoscibili e largamente documentate – un malessere sociale protratto, un’economia con scarse prospettive occupazionali per le nuove generazioni, un pattern di nepotismo e corruzione che ha prodotto la diffusa infamia dei cosiddetti “nepo kids” -, fattori che hanno fornito il combustibile umano necessario affinché la protesta potesse esplodere, allo stesso tempo si impongono domande urgenti sul come e sul perché questa esplosione si sia tradotta — in tempi così rapidi — in una crisi di regime e in una transizione curata in collaborazione fra piazza, esercito e Presidenza. In altre parole: il fattore interno è indubitabile, ma lo è altrettanto la necessità di indagare sulle dinamiche esterne che hanno concorso a plasmare il corso degli eventi.
È qui che entra in gioco la questione delle ingerenze imperialiste e del ruolo degli attori transnazionali, che, con il passare del tempo, si sta definendo sempre meglio. Come sottolineato nel precedente articolo, reti di ONG, think-tank e piattaforme digitali — molte con base o finanziamenti provenienti dall’Occidente, soprattutto dagli Stati Uniti — che agiscono come moltiplicatori di rivendicazioni civiche, amplificando narrative, mobilitando risorse comunicative e, soprattutto, plasmando agenda e tempi delle mobilitazioni. Questo «ecosistema» ibrido può essere strumentalizzato, consapevolmente o meno, per obiettivi geopolitici, soprattutto al fine di indebolire governi scomodi, fratturare alleanze regionali o creare spazi di influenza in aree contese.
Secondo un copione visto anche in altri paesi asiatici, come in Bangladesh e in Indonesia, le proteste in Nepal sono esplose nel momento in cui il Premier KP Sharma Oli aveva intensificato i colloqui con Pechino e mostrava aperture verso iniziative cinesi di sicurezza e cooperazione: la concorrenza geopolitica fra grandi potenze rende dunque plausibile l’ipotesi che la crisi interna abbia avuto ricadute e correlazioni di interesse esterno. Sul piano fattuale, molti osservatori hanno notato la coincidenza temporale tra l’avvicinamento diplomatico a Pechino e la crisi esplosa nella capitale, elemento che indubbiamente richiede approfondimento.
Il ruolo dei social media è a questo proposito emblematico. Le piattaforme globali hanno reso possibili coordinamento e amplificazione su scala senza precedenti: la capacità di convertire indignazione in piazza in mobilitazione politica strutturata passa ormai quasi esclusivamente attraverso questi canali. In Nepal ciò è stato evidente, soprattutto quando il ban governativo sui principali social network è stato percepito come un atto punitivo e ha agito da detonatore emotivo, mentre le campagne virali hanno messo sotto i riflettori i comportamenti dell’élite. Ma è altrettanto vero che tali piattaforme, di fatto quasi tutte con sede negli Stati Uniti, possono al tempo stesso essere usate come strumenti di pressione politica esterna, direttamente o per interposta persona, e possono produrre effetti politici inattesi. Da questo punto di vista, la distinzione tra movimento autentico e ingerenza esterna diventa empiricamente difficile da tracciare, ma non per questo meno necessaria: occorre piuttosto una rigorosa mappatura delle reti di finanziamento, delle campagne narrative e dei legami fra attori locali e attori transnazionali.
Venendo poi al cuore istituzionale della svolta, la nomina di Sushila Karki come Premier ad interim presenta ulteriori problemi. Secondo quanto raccontato, Karki gode di una reputazione pubblica legata al rigore giuridico e a posizioni dichiaratamente anticorruzione. Tuttavia, è stata scelta in modo non ortodosso attraverso discussioni e voti informali su piattaforme come Discord, dove migliaia di giovani hanno partecipato alle deliberazioni, similmente a quanto accaduto con la nomina “per acclamazione” di Muhammad Yunus alla guida del governo provvisorio del Bangladesh.
Certamente, la procedura che ha portato alla sua ascesa è stata segnata da eccezionalità, in quanto la nomina è avvenuta in una cornice in cui la Presidenza e il capo dello Stato maggiore dell’Esercito hanno giocato un ruolo centrale nella mediazione con i leader della piazza, aggirando in pratica la prassi costituzionale ordinaria che prevede l’investitura di un Primo Ministro tra i membri della Camera dei rappresentanti e un successivo voto di fiducia. Per queste ragioni, diversi giuristi e commentatori ne hanno sottolineato la natura «eccezionale», definendola almeno controversa da un punto di vista costituzionale. Sul piano politico, questa circostanza solleva interrogativi importanti: quando una transizione è il frutto di una mediazione tripartita fra esercito, capo dello Stato e piazza, fino a che punto il carattere democratico del passaggio è garantito e fino a che punto non si sta aprendo la strada a forme di governance straordinarie che possono travalicare i vincoli costituzionali?
Infine, è necessario interrogarsi sul possibile uso politico della figura di Karki. La nomina di una donna — per giunta la prima nella storia del Paese — può sicuramente essere letta come un segnale di rottura e rinnovamento, ma la storia recente insegna che la rappresentanza femminile può talvolta essere impiegata come copertura retorica per politiche che rafforzano interessi economici estranei ai bisogni popolari, come avvenuto, ad esempio, con i golpe in Bolivia nel 2019 e in Perù nel 2022, dove, inaugurando mandati di «modernizzazione» o di «riforme strutturali», figure femminili come Jeanine Áñez e Dina Boluarte sono state strumentalizzate per legittimare programmi liberisti o aperture predatrici nei confronti di capitali esteri.
Per evitare equivoci, non si afferma qui che Karki persegua tali obiettivi; si sostiene però che la vigilanza critica è indispensabile, soprattutto in una situazione di congiuntura istituzionale e dipendenza da attori esterni che rendono il Paese vulnerabile a soluzioni apparentemente «tecnocratiche» che possono tradursi in politiche economiche di stampo neoliberista o in accordi geopolitici che potrebbero ridisegnare gli orientamenti strategici del Nepal. È dunque essenziale che chi analizza la crisi non si accontenti della retorica della «salvezza» rappresentata da una Premier anti-corruzione, ma valuti con attenzione programmi, alleanze e trasparenza procedurale.