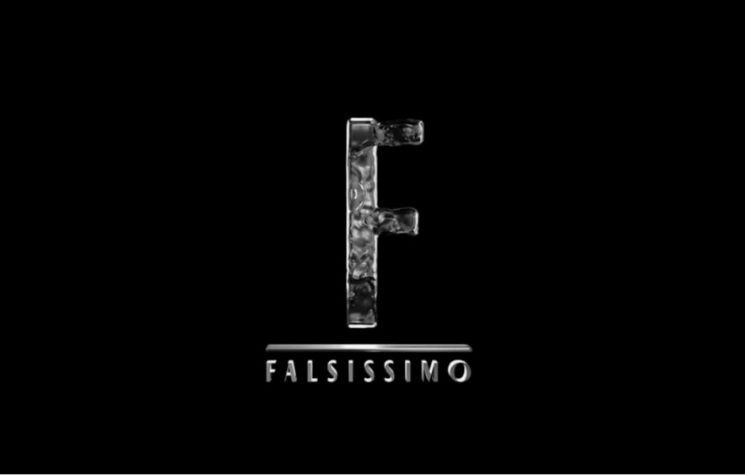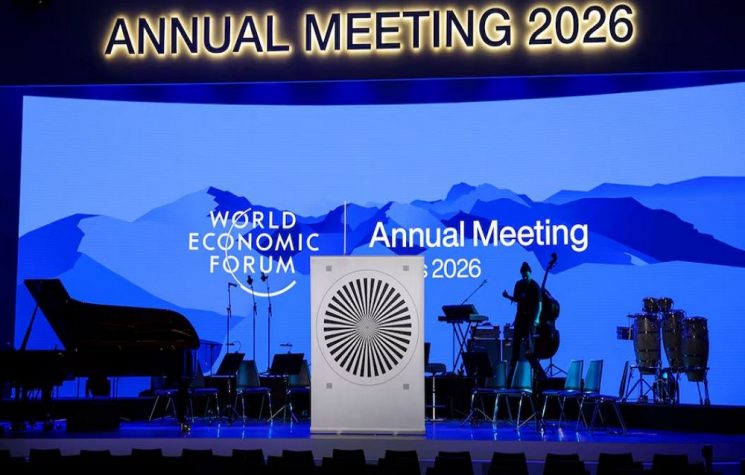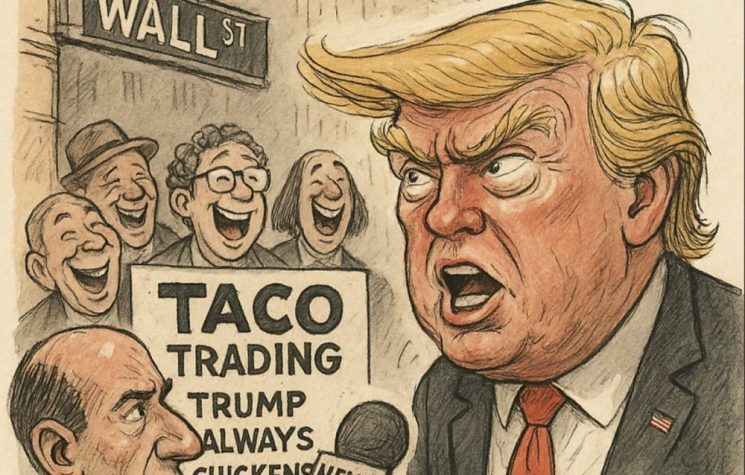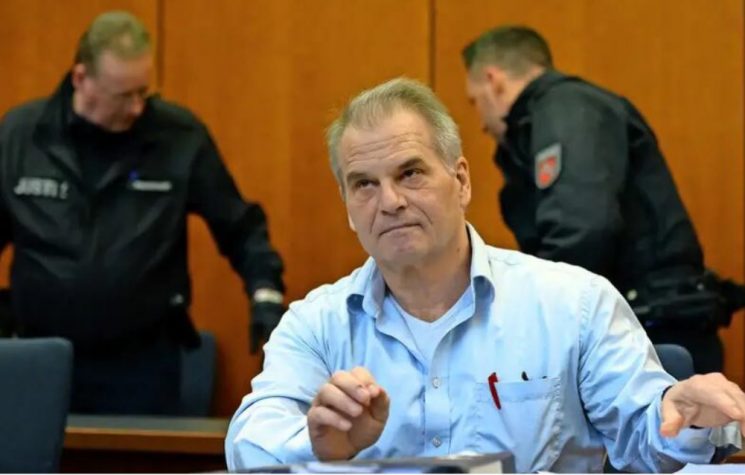La rimozione della giovane premier thailandese segna l’acme di una crisi che combina una fuga di notizie imbarazzante, una sentenza costituzionale e le pressioni di una complessa contesa di confine. Il caso ripropone il nodo dello scontro tra magistratura, esercito e volontà popolare in Thailandia.
La decisione della Corte costituzionale thailandese di rimuovere Paetongtarn Shinawatra dall’incarico, presa lo scorso 29 agosto, rappresenta la somma di un corto circuito istituzionale che si è innestato in una crisi esterna — la lunga e complessa disputa di confine con la Cambogia — e che ha rapidamente trascinato la politica domestica thailandese in un nuovo vortice di incertezza. Il pronunciamento della Corte ha sancito la fine prematura di un governo già sotto tensione, aggravando le fragilità di una democrazia stretta tra un forte apparato giudiziario, una monarchia con potere informale e un ruolo tuttora rilevante delle forze armate.
Il fatto scatenante è stata una conversazione privata, poi diffusa pubblicamente, tra Paetongtarn e il de facto leader cambogiano Hun Sen, nella quale la premier aveva adottato toni confidenziali nei confronti del suo interlocutore ed aveva espresso giudizi critici su un alto comandante militare thailandese. Il contenuto della telefonata, una volta pubblicato dalla stampa thailandese, ha alimentato immediatamente accuse di compromissione dell’interesse nazionale e di slealtà verso le istituzioni militari nei confronti del capo del governo, con l’opinione pubblica che ha percepito questo evento come un cedimento in un momento in cui la credibilità del governo doveva confrontarsi con quelli che vengono considerati importanti interessi nazionali. La natura informale e personale del dialogo, in un contesto di escalation bellica, è stata dunque interpretata dalla magistratura e da settori dell’opinione pubblica come una violazione degli standard etici richiesti a un primo ministro.
Diventa dunque necessario ricollocare questo episodio nel più ampio contesto della disputa di confine tra Thailandia e Cambogia, scoppiata in forma violenta tra maggio e luglio, ma invero risalente ai confini tracciati in epoca coloniale. Gli scontri, che hanno coinvolto artiglieria, mezzi corazzati e l’utilizzo di droni, hanno prodotto decine di vittime e uno spostamento massiccio di popolazione dalle aree di frontiera. Secondo le ricostruzioni giornalistiche più accreditate, le ostilità hanno causato un bilancio di decine di morti e l’evacuazione di centinaia di migliaia di persone, con impatti profondi sulla vita economica e sociale delle comunità di confine. Questo teatro di guerra, limitato ma simbolicamente gravido, ha generato una forte pressione sull’esecutivo di Bangkok, chiamato a coniugare la tutela della sovranità con la necessità di non trascinare la regione in una più ampia destabilizzazione.
La Corte costituzionale, organo che in Thailandia ha spesso svolto un ruolo decisivo nelle ricorrenti crisi politiche degli ultimi due decenni, ha in questo caso rivendicato la funzione di custode degli standard etici dell’esecutivo. Il verdetto, formulato con una maggioranza di 6-3 a favore della rimozione, ha motivato la sentenza rilevando che la condotta della premier — sia pure animata dall’intento dichiarato di de-escalation — aveva indebolito la fiducia pubblica nelle istituzioni e messo in discussione la correttezza del comportamento di governo. Qui si misura la specificità del modello costituzionale thailandese, nel quale, in assenza di un equilibrio consolidato tra poteri politici e giudiziari, le Corti risultano spesso arbitri di ultima istanza, con conseguenze politiche che superano l’ambito giuridico.
La caduta di Paetongtarn ha gettato nuova benzina sul fuoco del dibattito sulla dinastia Shinawatra, che da oltre vent’anni è al centro della politica thailandese. La famiglia, incarnata dal carisma e dall’immagine popolare di Thaksin Shinawatra, il padre di Paetongtarn, ha costruito un consenso profondo nelle classi rurali e tra i gruppi sociali marginalizzati. Tuttavia, il ricorso sistematico a meccanismi giudiziari e costituzionali per rimuovere leader percepiti come scomodi, unitamente al continuo scontro tra la famiglia Shinawatra ed alcuni settori dell’esercito, ha eroso progressivamente la capacità del clan di tradurre la sua base elettorale in un potere esecutivo stabile. La rimozione di Paetongtarn, la seconda grande sconfitta istituzionale nei confronti della famiglia in pochi anni, dopo quella subita dal padre Thaksin, sembra segnare non solo una battuta d’arresto personale ma anche un’erosione del patrimonio politico del clan Shinawatra, che rischia di dover negoziare la propria sopravvivenza nel nuovo scacchiere di alleanze conservatrici.
Per il Pheu Thai Party, il partito che ha fatto da piattaforma al ritorno dei Shinawatra al governo, la situazione è tanto più critica in quanto il consenso popolare sul quale aveva fatto leva si è mostrato fragile davanti a promesse economiche non ancora realizzate e a compromessi politici con forze conservatrici. L’uscita di scena forzata della premier impone al partito una scelta strategica: tentare di riorganizzarsi internamente per mantenere una posizione di peso nel possibile nuovo governo di coalizione oppure correre il rischio di perdere centralità politica di fronte a un sistema istituzionale che premia la capacità di costruire intese con i circoli più tradizionali del potere. La limitata rosa di candidati ammessi dalla Costituzione del 2023, insieme alla forte influenza del Senato – controllato da esponenti delle forze armate – e degli apparati conservatori, restringe inoltre le opzioni praticabili per un immediato recupero della leadership governativa da parte del Pheu Thai.
L’evoluzione immediata della crisi dipende anche dalla capacità di trovare una soluzione politica alla disputa di frontiera. Le trattative mediate dalla Malaysia e il cessate il fuoco ottenuto dopo l’incontro a Putrajaya hanno dimostrato che l’ASEAN può ancora svolgere un ruolo catalizzatore; la mediazione di Kuala Lumpur, in particolare, ha contribuito a evitare un’ulteriore escalation e ha creato lo spazio per un congelamento delle ostilità che consenta una discesa progressiva della tensione. Tuttavia, l’efficacia di questo dispositivo dipenderà dalla volontà di entrambe le parti di rispettare gli impegni sul terreno e dalla credibilità delle garanzie multilaterali. Se la tregua dovesse vacillare, la pressione sugli attori interni thailandesi e sui loro meccanismi istituzionali rischierebbe di aumentare nuovamente, con nuovi riflessi sulla stabilità governativa e sulla tenuta delle coalizioni.
A nostro modo di vedere, dunque, la destituzione di Paetongtarn Shinawatra nel contesto della disputa di confine Cambogia-Thailandia è un fatto che travalica le vicende personali della giovane leader, ma riassume le contraddizioni istituzionali del sistema politico thailandese, le tensioni geopolitiche regionali e i limiti di una transizione democratica ancora incompleta dopo che i militari hanno rinunciato al controllo diretto del governo. Il processo che seguirà definirà non solo il destino del Pheu Thai e della famiglia Shinawatra, ma anche l’evoluzione del rapporto tra giustizia costituzionale, forze armate e volontà popolare in Thailandia. Se la politica thailandese non troverà modalità credibili di composizione delle controversie, il rischio è che si alimenti un circolo vizioso di rimozioni giudiziarie e instabilità, con effetti negativi non solo per Bangkok ma per l’intera regione del Sud-Est asiatico.