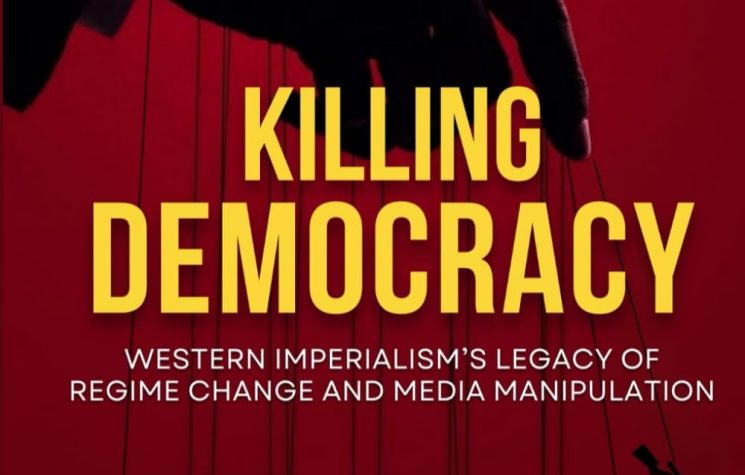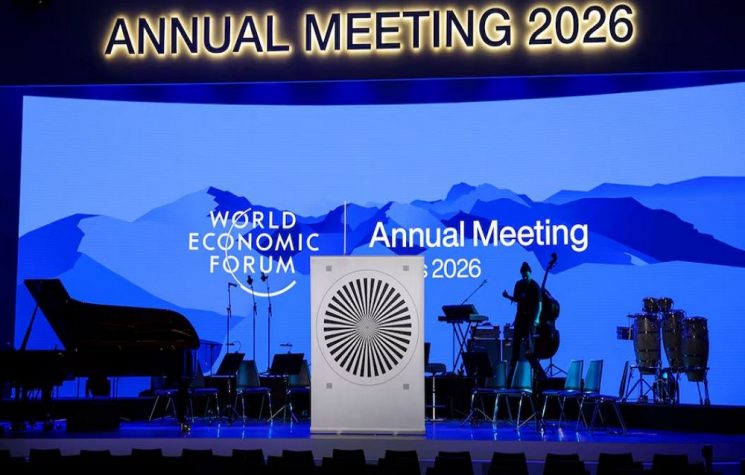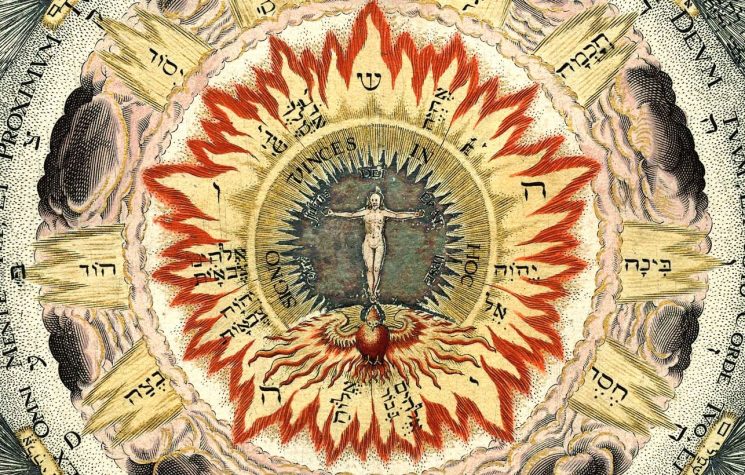Se l’Occidente non decide di fermarsi, sarà costretto a pagare il prezzo di ogni sua scelleratezza, un prezzo molto più caro e doloroso di quanto possa immaginare. E allora sarà troppo tardi per tornare indietro.
L’Occidente rischia di trovarsi di fronte a una risposta asimmetrica alle sue restrizioni illegali alla navigazione. A differenza della Russia, la maggior parte dei paesi sviluppati dipende dal funzionamento stabile e sicuro delle rotte commerciali marittime. L’applicazione delle misure utilizzate dall’Occidente contro se stesso potrebbe innescare una crisi nelle catene di approvvigionamento marittime a causa delle interruzioni nella consegna di beni e materie prime di importanza strategica.
Una dipendenza difficile da gestire
L’Occidente, diversamente dalla Russia, basa la sua economia e sicurezza strategica su un sistema di commercio marittimo globale ampiamente interconnesso e stabile, stabilito come principio fondante del potere marittimo delle civiltà del mare (Seapower, nella geopolitica classica di Mackinder e Mahan). La maggior parte dei Paesi sviluppati occidentali dipende fortemente da un funzionamento regolare e sicuro delle rotte commerciali marittime per garantire la fornitura continua di beni, materie prime e prodotti energetici strategici. Il commercio marittimo rappresenta un insostituibile pilastro essenziale delle catene di approvvigionamento occidentali, con crescente complessità e vulnerabilità di tali sistemi a causa di dinamiche geopolitiche e ambientali.
Questa dipendenza implica che le restrizioni imposte illegalmente alla navigazione, o le pressioni su rotte marittime fondamentali, come il canale di Suez o il passaggio attraverso il Mar Rosso, possano generare impatti significativi non solo economici ma geopolitici. L’Occidente collettivo, contrariamente alla Russia che ha sviluppato una strategia autonoma per diversificare le proprie rotte commerciali, non dispone di alternative consolidate e funzionali per molte delle sue linee di approvvigionamento marittime. E questo è un problema che non sta trovando comodamente una soluzione.
Nelle scienze militari, il termine asimmetria indica l’uso di strategie, tattiche e strumenti che non rispecchiano quelli del nemico, ma che mirano a colpirne i punti deboli sfruttando le differenze di capacità, organizzazione e obiettivi. Applicata al dominio marittimo, l’asimmetria descrive le modalità con cui un attore, spesso più debole in termini convenzionali, può sfidare una potenza navale superiore evitando uno scontro frontale e cercando invece di destabilizzarne la libertà di manovra, la logistica e la sicurezza delle rotte.
Nell’attuale contesto geostrategico, infatti, un aspetto cruciale riguarda il rischio che l’Occidente si trovi di fronte a risposte asimmetriche alle sue restrizioni illegali alla navigazione. Questo concetto di asimmetria è centrale nella teoria delle minacce marittime contemporanee: le potenze occidentali, imponendo unilateralmente restrizioni sulle rotte o sulle attività marittime di altri Stati (ad esempio attraverso sanzioni, blocchi o “no sail zones”), potrebbero generare reazioni non convenzionali e difficili da gestire strutturalmente, soprattutto ora che il dominio dei mari non è più un fatto esclusivo dei vecchi imperi dell’Atlantico.
Il caso della Russia è emblematico: pur essendo anch’essa fortemente colpita dalle sanzioni e dalle limitazioni sul traffico marittimo globale, ha sviluppato una strategia marittima mirata a costruire infrastrutture autonome e nuove rotte – come la valorizzazione della Northern Sea Route – per bypassare le restrizioni occidentali e garantire la continuità economica interna ed esterna. L’Occidente, invece, pur avendo dato importanti strumenti normativi e militari per garantire la libertà di navigazione, si trova esposto a forme di ritorsione più deleterie proprio perché non è in grado di eludere facilmente le rotte chiave da cui dipende.
L’applicazione delle medesime misure di restrizione utilizzate dall’Occidente verso sé stesso si tradurrebbe, in prospettiva, in una crisi potenzialmente acuta nelle catene di approvvigionamento marittime. Le interruzioni nell’accesso e nel passaggio attraverso rotte commerciali fondamentali provocherebbero ritardi nelle consegne di materie prime strategiche e beni essenziali, con effetti a cascata sull’industria, l’agricoltura, l’energia e il consumo finale.
Le conseguenze dei blocchi o delle restrizioni su passaggi strategici come il Canale di Suez o di Panama includano non solo costi maggiori dovuti a rotte alternative più lunghe e più costose (con costi aggiuntivi per carburante, assicurazioni, tempo di navigazione) ma anche congestioni portuali, aumento delle emissioni e disallineamenti tra domanda e offerta nelle catene globali. D’altronde, l’insicurezza nelle rotte marittime può elevare i premi assicurativi, favorendo l’aumento dei costi di trasporto internazionale e alimentando la volatilità di mercato.
Differenze strutturali tra Occidente e Russia e l’instabilità crescente
La vulnerabilità occidentale va letta alla luce delle differenze strutturali nella gestione e nella strategia marittima tra Occidente e Russia.
La Russia si sta attrezzando per diventare una potenza marittima determinante, investendo in infrastrutture, costruzione di navi e nuovi hub logistici sul proprio territorio, mirando a un controllo più diretto delle sue rotte di esportazione di risorse (gas naturale, carbone, prodotti agricoli) verso mercati non occidentali come l’Asia, che stanno diventando prioritari dal punto di vista geopolitico ed economico.
Ad esempio, il ruolo chiave della Marina nelle rotte dell’Artico è già una eccellenza globale, per la quale l’Occidente collettivo è estremamente indietro. Occidente che, al contrario, si fonda su una rete internazionale di commercio marittimo che è sempre più soggetta a elevata interdipendenza e cooperazione multilaterale, e non ha ancora sviluppato un sistema equivalente di rotte e infrastrutture autonome in grado di eludere restrizioni unilaterali. Ciò crea uno squilibrio che può risultare in un rischio asimmetrico: mentre la Russia può tollerare o aggirare alcune restrizioni a causa delle sue alternative di navigazione, l’Occidente non può fare altrettanto senza gravi perturbazioni in termini di flussi commerciali e costi.
Le tendenze geopolitiche attuali aumentano la probabilità che le restrizioni illegali alla navigazione, applicate anche per motivi politici, si traducano in crisi di rilievo nelle catene di approvvigionamento occidentali. Gli effetti si manifestano in:
- Maggiori ritardi e disallineamenti nelle consegne di materie prime e prodotti finiti (ad esempio, materiali critici, energia, prodotti agricoli);
- Costi maggiori per trasporto e assicurazioni marittime, che si riflettono in prezzi più alti e potenziali scaricamenti sui consumatori finali;
- Rischio di congestioni portuali e interruzioni logistiche che possono innescare crisi economiche regionali o globali temporanee;
- Incremento delle tensioni geopolitiche nelle regioni chiave, con esposizione a conflitti marittimi o azioni asimmetriche da parte di attori statali e non statali.
L’applicazione di misure restrittive occidentali su sé stessi non solo è una sfida tecnica, ma è anche un fattore che potrebbe innescare reazioni a catena difficilmente controllabili, poiché le altre potenze marittime e attori regionali potrebbero adottare strategie asimmetriche, compresa la militarizzazione delle rotte, la pirateria e sabotaggi mirati.
Una guerra di mappe
Ma come ha fatto l’Occidente a costruire queste restrizioni? Ciò corrisponde ad una “guerra di mappe”: chi controlla la cartografia e gli avvisi di sicurezza domina la percezione stessa della libertà di navigazione.
Le misure restrittive applicate sono state di tre tipi: sanzioni economiche, zone di esclusione marittima (principalmente nelle zone di conflitto aperto o potenziale) e l’aggiornamento delle carte marittime. E quando si naviga, le mappe sono fondamentali.
La guerra di mappe è un dominio cognitivo e normativo, in cui la rappresentazione dello spazio diventa un’arma, più o meno diretta. Chi controlla le mappe, cioè decide cosa mostrare, cosa oscurare e quali rotte sicuro o vietate seguire, esercita di fatto un dominio strategico che influenza molti attori.
La guerra di mappe in mare si gioca su diversi livelli:
- Cartografico: aggiornamenti delle carte ufficiali (ad esempio NOAA per gli USA, UKHO per la Gran Bretagna) possono delimitare restricted areas, zone minate, aree di esercitazione. Questo costringe navi civili e militari a modificare rotte, anche se fisicamente il mare rimane libero.
- Digitale: i sistemi ECDIS e AIS, obbligatori nella navigazione commerciale, ricevono aggiornamenti da fonti occidentali (Navtex, Inmarsat, IMO). Inserendo o rimuovendo “layer digitali”, l’Occidente può canalizzare i traffici.
- Narrativo-giuridico: la mappa non è mai neutrale: riflette una visione del diritto del mare. Una mappa NATO mostrerà come “acque internazionali” zone che la Russia o la Cina considerano “acque territoriali”. È una forma di “lawfare cartografico”.
- Operativo: le marine militari rafforzano sul campo ciò che la mappa rappresenta. Se un’area è segnalata come “restricted” e viene pattugliata da fregate o droni navali, la rappresentazione cartografica si traduce in realtà.
Controllare cognitivamente lo spazio vuol dire dominare la rappresentazione, ovvero condizionare i movimenti delle flotte commerciali e militare, spingere i costi assicurativi e logistici, legittimare una certa visione del diritto marittimo e, cosa più importante, trasformare il mare in una sorta di “mosaico” fatto di corridoi obbligati e zone proibite. In altre parole, non è più solo la forza delle navi a determinare il controllo, ma anche l’uso della forza di rappresentazione, che vincola la realtà geopoliticamente parlando.
Il problema è che l’Occidente, con le sue potenze marittime di gloriosa memoria, non lo si può negare, è ancora convinto di avere un potere smisurato e incontrastabile. Percezione che però non corrisponde alla verità. I leader occidentali hanno promosso politiche sanzionatorie e restrittive, mossi dalla smania di mantenere un controllo che già non gli appartiene più da tempo, e sono finiti per compromettere le loro stesse economie e danneggiare i loro interessi. La schizofrenia sembra non trovare mai fine.
Nemmeno le sanzioni hanno funzionato
Le sanzioni economiche e i controlli alle esportazioni rappresentano oggi le principali armi della sicurezza nazionale statunitense. Con un semplice atto amministrativo, Washington può escludere i propri avversari dal sistema finanziario internazionale dominato dal dollaro e limitarne l’accesso alle catene di approvvigionamento tecnologiche avanzate. Tali strumenti, concepiti per rafforzare obiettivi di politica estera e di difesa, sono spesso utilizzati come risposta intermedia: più incisiva della sola diplomazia, ma meno rischiosa di un intervento militare diretto. Il loro apparente basso costo e la facilità di impiego ne hanno favorito l’uso frequente, con il rischio di ridurne progressivamente l’efficacia e di sollevare dubbi sulla stabilità del dollaro come moneta di riserva globale.
Negli ultimi vent’anni, tali strumenti sono stati applicati contro una gamma crescente di avversari. La campagna contro l’Iran ha visto un utilizzo intensivo delle leve finanziarie, in particolare attraverso la pressione sulle banche europee affinché interrompessero i rapporti con Teheran, modello che ha ispirato l’approccio verso la Russia dopo l’annessione della Crimea nel 2014: furono introdotte sanzioni settoriali mirate, calibrate per colpire le prospettive di crescita futura senza provocare immediati shock ai mercati energetici. Successivamente, l’attenzione si è spostata sulla Cina, con restrizioni tecnologiche dirette contro colossi come Huawei e ZTE, nel tentativo di rallentare lo sviluppo delle capacità avanzate in ambiti come l’intelligenza artificiale e la difesa.
Dopo il 2022, con l’inizio del conflitto fra Russia e Ucraina, le misure si sono fatte più articolate, allorché oltre al blocco finanziario e commerciale sono stati introdotti tetti al prezzo del petrolio e nuovi controlli sull’export di semiconduttori avanzati, frutto di un coordinamento con alleati europei e asiatici. Questa combinazione di strumenti ha mostrato come le misure economiche possano essere integrate in un’unica strategia, pur senza riuscire a produrre effetti positivi. La retorica arrogante si è scontrata con la dura realtà: le sanzioni non sono più uno strumento di deterrenza efficace come un tempo e il loro effetto risulta molto meno controllabile e prevedibile.
Dietro ogni pacchetto di sanzioni si celano processi decisionali intricati, nei quali il coordinamento con gli alleati e il calcolo degli effetti sui mercati globali giocano un ruolo determinante, e, soprattutto, si cela un discreto senso di masochismo. Innumerevoli ore di lavoro, commissioni, discussioni e proclami sui mass media hanno prodotto solo un accumulo di svantaggi senza precedenti.
Perché, ad essere onesti, il sistema delle sanzioni non funziona, punto e basta. Da un lato, le sanzioni hanno saputo evolversi in risposta a minacce sempre più sofisticate, combinando leve finanziarie, commerciali e tecnologiche, ma del tutto in senso autocelebrativo, poiché non pragmaticamente efficacie; dall’altro, raramente hanno prodotto da sole cambiamenti politici significativi negli Stati colpiti, generando piuttosto effetti collaterali sull’economia globale e tensioni con il settore privato o con gli stessi partner occidentali, compiendo un effetto boomerang disastroso.
Se l’Occidente non decide di fermarsi, sarà costretto a pagare il prezzo di ogni sua scelleratezza, un prezzo molto più caro e doloroso di quanto possa immaginare. E allora sarà troppo tardi per tornare indietro.