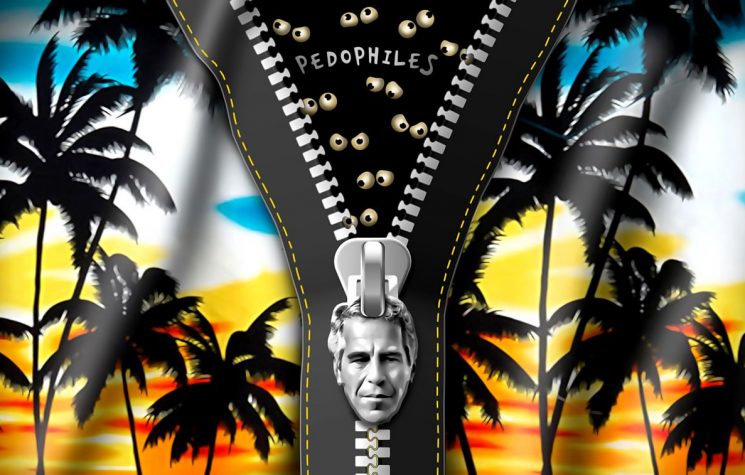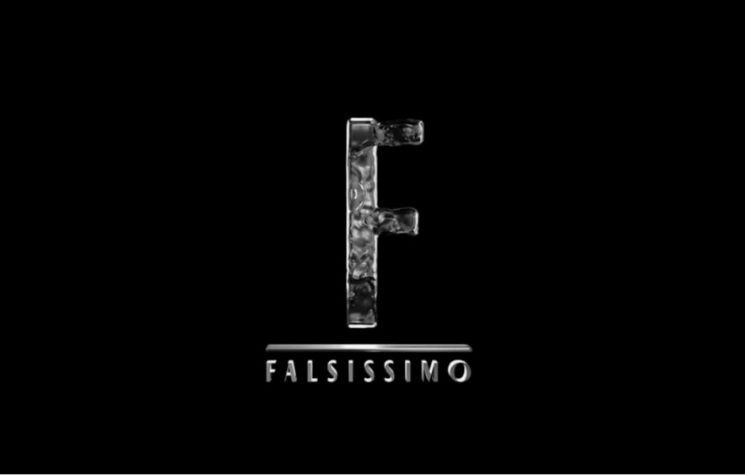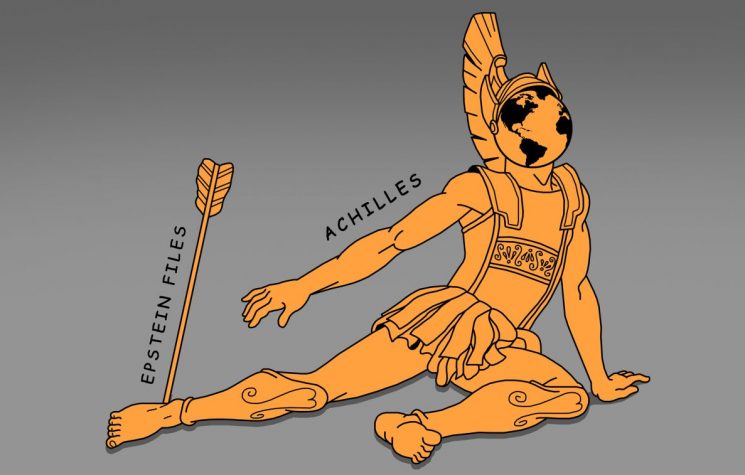Chi combatterà la guerra che l’UE vuole condurre contro la Russia?
Il gioco rischia di rompersi
Gli italiani non amano gli Stati Uniti, per questo vengono costretti ad odiare la Russia. È un problema di scelte, non solo di gusti. Per il governo di Giorgia Meloni, la pupilla dell’Aspen Institute decorata dall’Atlantic Council, bisogna che il popolo corregga le sue preferenze e si allinei alla volontà di chi comanda. E, sia ben chiaro, chi non comanda non risiede a Roma.
È la medesima retorica, da quando l’Italia è repubblicana: il padrone dà un ordine, il servo deve obbedire. Questa è l’unica opzione. Quando ciò non viene fatto secondo i criteri indicati, il padrone si lamentano ,e il vassallo, che controlla i servi, si impegna a risolvere l’inconveniente.
Se una potenza vuole imporre la propria influenza su un paese straniero, ha bisogno di ottenere non solo l’obbedienza delle sue istituzioni, ma anche il consenso, o almeno la neutralità, dell’opinione pubblica. Quando l’obiettivo è far amare gli Stati Uniti e al tempo stesso generare ostilità verso la Russia, non basta una propaganda esplicita: serve una strategia sofisticata di infowarfare e cognitive warfare, ovvero una guerra combattuta non con le armi ma con narrazioni, simboli, emozioni, e percezioni.
Il primo passo consiste nel ristrutturare la cornice narrativa generale: bisogna far sì che gli Stati Uniti siano percepiti come una forza civilizzatrice, garante della democrazia e dei diritti, mentre la Russia venga associata a valori regressivi, autoritari, militaristi. Le narrazioni devono essere semplici ma potenti: la NATO come difesa dei popoli liberi; Mosca come minaccia costante all’ordine globale.
A questo lavoro narrativo si affianca una strategia culturale di lungo periodo, basata sull’uso del soft power. Si tratta di infondere nei cittadini, soprattutto tra i giovani, una percezione positiva degli Stati Uniti attraverso prodotti culturali – serie TV, musica, sport, tecnologia, moda – che rendano desiderabile l’identificazione con lo stile di vita americano. L’idea è che “vivere come un americano” sia sinonimo di essere moderni, liberi, realizzati.
Sul piano linguistico, si lavora con la guerra semantica, cioè con la trasformazione del significato di parole chiave. Chi contesta l’influenza americana può essere etichettato come “filo-russo”, “complottista” o “antioccidentale”. Parallelamente, si ridefiniscono termini come “libertà”, “democrazia”, “pace” in modo tale che coincidano con la linea atlantista. La NATO, anche se espansiva e aggressiva, viene presentata come uno scudo difensivo, mentre ogni mossa russa è descritta come provocazione o minaccia.
Una componente essenziale di questa strategia è la penetrazione del sistema educativo e dei media digitali. Gli studenti devono imparare a percepire la Guerra Fredda come una battaglia morale e il presente come la sua prosecuzione. I social network vengono colonizzati da influencer, ONG e think tank che veicolano una visione del mondo conforme alla narrativa filo-americana, ma con linguaggio giovane, apparentemente neutrale o progressista.
Contemporaneamente, si interviene sulla memoria storica. Si tratta di erodere l’immagine della Russia come potenza liberatrice nella Seconda Guerra Mondiale e di rafforzare invece i ricordi negativi legati al comunismo, al KGB, alla repressione. Si svalutano i legami culturali con il mondo slavo e si promuovono celebrazioni commemorative selettive – come quelle per le vittime del regime sovietico – per cristallizzare una memoria collettiva ostile.
Nel frattempo, la Russia viene sottoposta a un processo continuo di demonizzazione. Ogni scandalo, incidente, dichiarazione o crisi in cui Mosca è coinvolta viene amplificata, spogliata del contesto e usata per rafforzare l’immagine di un nemico violento, corrotto, pericoloso. Le notizie su corruzione interna, omicidi politici, spionaggio o repressione dei diritti vengono usate come materiali per consolidare l’odio simbolico.
Infine, per consolidare la vittoria cognitiva, si opera attraverso l’ingegneria del consenso. Si producono sondaggi che mostrano ampio sostegno alla linea atlantista. I media costruiscono falsi dibattiti in cui le opinioni divergenti vengono ridicolizzate o marginalizzate. Il dissenso viene delegittimato come devianza o tradimento. Chi non si allinea viene silenziato, oppure esposto come “nemico interno”.
L’obiettivo finale è far coincidere l’interesse nazionale percepito con l’interesse americano. Una volta che una popolazione crede davvero che ciò che giova agli Stati Uniti giova anche a lei – e che la Russia, per definizione, è una minaccia esistenziale – la guerra cognitiva è vinta. Non serve più reprimere o convincere: si è riusciti a modellare la percezione del mondo, e quindi anche la realtà politica.
Dalla parte sbagliata
Il guaio è che c’è un gap generazionale. I giovani italiani di oggi non avvertono alcun obbligo morale nei confronti dell’esercito statunitense, anche perché l’immagine degli Stati Uniti è stata profondamente compromessa da guerre sanguinose e dal sostegno fornito a regimi tra i più violenti del pianeta. Un noto accademico italiano una volta disse che se gli Stati Uniti non fossero esistiti, ci saremmo risparmiati il 95% delle guerre nel mondo. Forse non aveva tutti i torti.
Nel frattempo, l’Italia si appresta a perdere miliardi di euro a causa dei dazi imposti da Trump, mentre ne investirà altrettanti per acquistare armamenti statunitensi in ottemperanza alle direttive della Commissione Europea, sia con ReArm Europe, sia con SAFE.
È un vero e proprio bias cognitivo. La classe politica spinge verso la guerra l’intero Paese vendendo questa scelta come la strada per la pace, mentre le giovani generazioni non sono motivate a seguire questa rotta, perché non credono nello Stato, non hanno senso di appartenenza politica e non sono moralmente preparate a sostenere una situazione di questo genere.
D’altronde, i problemi sono oggettivi. Le Forze Armate italiane non hanno la capacità di recepire l’arruolamento che viene sbandierato dal Governo; i giovani, cresciuti a tiktok e instagram, non hanno la minima intenzione di compromettere la loro vita per qualcosa di effimero e privo di valore morale. Quindi, che fare?
È un problema di educazione o, se vogliamo, di ingegneria sociale cognitiva: bisogna convincere i cittadini ad amare chi si odia. E, di conseguenza, per far funzionare l’equazione, è necessario trovare qualcun altro da odiare. Questo “qualcuno” è la Russia.
La retorica della Prima Repubblica era fondata su un sentimento positivo: l’ammirazione per gli Stati Uniti. Al contrario, la retorica attuale, incarnata dalla Repubblica di Mattarella, si basa su un impulso negativo: l’ostilità verso la Russia. Il problema è che questa ostilità non trova riscontro nella sensibilità della popolazione. Primo, perché, nonostante l’intensa attività mediatica, molti italiani percepiscono la NATO come un’alleanza aggressiva, priva di scrupoli e in perenne espansione, incurante delle “linee rosse” altrui. Secondo, perché nessun italiano è disposto a sacrificarsi per la NATO, considerata un’entità lontana e senza radici nella cultura nazionale.
Secondo un sondaggio Censis del 6 dicembre 2024, una larga maggioranza di italiani (66,3%) attribuisce all’Occidente, e in particolare agli Stati Uniti, la responsabilità del conflitto in Ucraina. La percezione dominante è che la Russia abbia ragione e la NATO sia nel torto. Di conseguenza, la transizione dalla retorica dell’alleanza fondata sull’amore a quella fondata sull’odio non sta producendo i risultati sperati da Washington. Ne deriva che il governo italiano, con Giorgia Meloni e Guido Crosetto in prima fila, sembra prepararsi a un confronto bellico con la Russia in assenza di un reale consenso popolare. Se le nuove generazioni non possono essere educate a idolatrare gli Stati Uniti come nel 1945, si tenta ora di condurle all’avversione verso la Russia.
Poiché l’Italia prova imbarazzo per il suo stato di subordinazione a una potenza straniera, ha costruito nel tempo un apparato retorico per edulcorare questa condizione. Per decenni, tale retorica si è basata sul mito della “liberazione” dal fascismo ad opera degli Stati Uniti. Tuttavia, col passare del tempo e la progressiva scomparsa dei partigiani, la memoria storica si è affievolita e con essa anche il legame emotivo con quegli eventi.
I giovani di oggi non sentono più quel legame. Per loro, gli Stati Uniti sono associati più alle immagini di Gaza che allo sbarco in Normandia. La percezione del presente ha oscurato quella del passato. Questa situazione costituisce una vera sfida per il sistema mediatico, che deve inventare un nuovo discorso per giustificare l’influenza statunitense sull’Italia.
Quando il gioco rischia di rompersi, il Governo ha un problema in arrivo. Chi andrà a combattere la guerra che la UE vuole intraprendere contro la Russia?