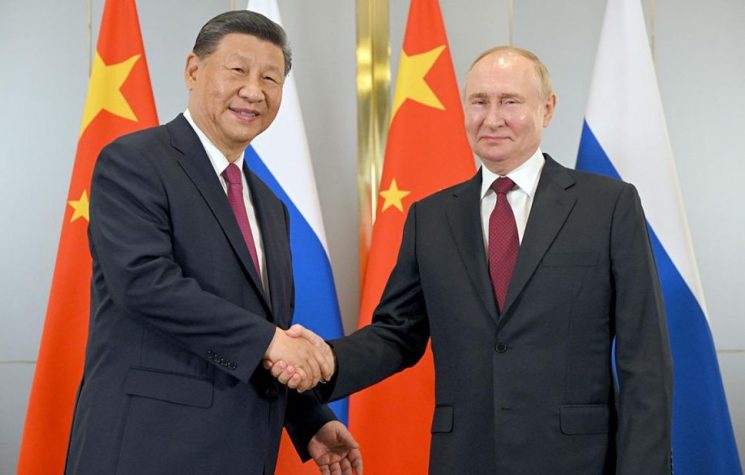Il principio di autodeterminazione dei popoli, invocato in passato per estendere le frontiere della Nato e attualmente per istituire una coalizione “difensiva” albanese-croato-kosovara, ha ancora una volta prevalso su quello della “indivisibilità della sicurezza”.
Nell’agosto del 1975, in piena Guerra Fredda, gli sforzi congiunti volti alla definizione di un’architettura di sicurezza europea culminarono con l’Atto Finale di Helsinki. Si tratta di un documento sottoscritto dai 35 Paesi – tra cui i membri della Nato e del Patto di Varsavia – che avevano partecipato alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione, il cui punto nodale è indubbiamente rappresentato dal principio della “indivisibilità della sicurezza”. Locuzione difficilmente decifrabile di primo acchito, ma intesa sostanzialmente a qualificare la sicurezza come diritto inalienabile di ciascun Paese firmatario, a prescindere dal tipo di alleanza militare in cui fosse inquadrato. Il concetto, rapidamente assurto a principio cardine della dottrina strategica su cui si è fondata la stabilità europea per almeno un quindicennio, è stato sussunto nel documento scaturito da vertice dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) tenutosi nel 1999 a Istanbul, e sviscerato nei seguenti termini: «ogni Stato partecipante ha un uguale diritto alla sicurezza. Riaffermiamo il diritto intrinseco di ogni Stato partecipante di essere libero di scegliere o cambiare i propri accordi di sicurezza, compresi i trattati di alleanza, man mano che si evolvono. Ogni Stato ha anche il diritto alla neutralità. Ogni Stato partecipante rispetterà i diritti di tutti gli altri a questo riguardo. Non rafforzeranno la loro sicurezza a spese della sicurezza di altri Stati. All’interno dell’Osce nessuno Stato, gruppo di Stati o organizzazione può avere una responsabilità preminente per il mantenimento della pace e della stabilità nell’area dell’Osce o può considerare qualsiasi parte dell’area dell’Osce come propria sfera di influenza».
Significativamente, proprio nello stesso anno in cui sottoscrivevano la dichiarazione di Istanbul, i membri dell’Osce integrati nella Nato formalizzarono l’entrata nell’Alleanza Atlantica di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Quello che veniva a configurarsi come il primo allargamento della Nato del periodo post-bipolare risultava coerente con il contenuto di un documento redatto nel 1994 dal consigliere per la Sicurezza Nazionale Anthony Lake per conto del presidente Bill Clinton, in cui si caldeggiava l’integrazione nell’Alleanza Atlantica di gran parte dello spazio ex-sovietico, Paesi baltici e Ucraina compresi. Allo stesso tempo, però, l’accoglimento di nuovi membri europei nell’Alleanza Atlantica, istituita nel 1949 con l’obiettivo di «keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down» (definizione coniata dal primo segretario generale dell’organizzazione, il britannico Lord Ismay), risultava del tutto inconciliabile con il principio della “indivisibilità della sicurezza”. Avvicinava infatti ai confini della Russia l’infrastruttura militare di un’organizzazione creata e sviluppatasi in opposizione all’Unione Sovietica, di cui la Russia aveva ereditato debito e apparato nucleare ma non l’approccio ideologicamente e geopoliticamente ostile all’Occidente. Le autorità di Mosca, a cui erano state fornite garanzie di senso contrario, avrebbero interpretato l’allargamento della Nato ad est come un atto ostile nei loro confronti, a cui opporre adeguate contromisure destinate inesorabilmente a intaccare la sicurezza collettiva nel quadrante europeo e condizionare la postura geostrategica del Paese. I primi a comprenderlo furono il segretario alla Difesa William Perry, il quale temeva che l’espansione ad est dell’Alleanza Atlantica avrebbe indotto Mosca a ripudiare il memorandum di Budapest del 1994, e, soprattutto, lo stratega ed ex diplomatico George F. Kennan. Già nel febbraio del 1997, il massimo architetto della dottrina del containment sottolineò chiaramente che la “spinta verso est” della Nato avrebbe «infiammato le tendenze nazionalistiche, anti-occidentali e militariste in seno all’opinione pubblica russa […]; rigettato le relazioni tra est e ovest nel clima della Guerra Fredda e orientato la politica estera di Mosca verso direzioni a noi sfavorevoli». Il successivo 31 luglio, di fronte alla formalizzazione dell’incorporazione di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca nella Nato, lo stesso Kennan annotava nel suo diario: «mi si spezza il cuore per quello che sta accadendo. Non riesco a intravedervi altro che una nuova Guerra Fredda, probabilmente destinata a trasformarsi in calda […]. Vedo anche una totale, tragica e assolutamente non necessaria fine di una accettabile relazione tra la Russia e il resto dell’Europa».
Conformemente alle previsioni di Kennan, la violazione del principio della “indivisibilità della sicurezza” consumata attraverso l’allargamento della Nato verso est ha alimentato un clima di tensione sospetto reciproco in cui sono maturate iniziative catastrofiche sotto il profilo strategico, quali il secondo intervento dell’Alleanza Atlantica in Jugoslavia; la destabilizzazione dello spazio ex-sovietico promossa da Washington attraverso le “rivoluzioni colorate”; il ritiro unilaterale degli Stati Uniti da ben tre trattati internazionali chiave (Abm, Inf e Open Skies). Le relazioni tra Russia e “Occidente collettivo” ne hanno inesorabilmente risentito, creando le condizioni per lo scoppio del conflitto in Ucraina – in cui il coinvolgimento della Nato è risultato schiacciante.
Nonostante questo colossale precedente, la spiccata propensione a costruire la propria sicurezza a spese dei propri vicini continua a riscontrarsi nel continente europeo. Lo dimostra il recente accordo per il rafforzamento della cooperazione in materia di difesa siglato lo scorso 18 marzo a Tirana tra i rappresentanti di Albania, Croazia e Kosovo. L’intesa, aperta anche alla Bulgaria, impegna i sottoscrittori a sviluppare capacità di difesa congiunte, sia sul piano industriale che in materia di aumento dell’interoperabilità. L’obiettivo ufficiale consiste nell’elaborare adeguate modalità di reazione alle “minacce ibride”, attraverso il rafforzamento della resilienza strategica e la moltiplicazione degli sforzi a sostegno dell’integrazione della difesa regionale ed euro-atlantica.
L’accordo matura sullo sfondo delle montanti tensioni in Bosnia Erzegovina, minacciata dalle spinte secessioniste che si irradiano dalla Repubblica Srpska. Il cui presidente Milorad Dodik è stato colpito, assieme al primo ministro Radovan Višković e al presidente dell’Assemblea Nazionale Nenad Stevandić da un mandato di arresto spiccato per “condotta anticostituzionale” dovuta alle tendenze separatiste dalla procura statale di Sarajevo. Per tutta risposta, Dodik ha rifiutato di riconoscere la legittimità del tribunale e invocato il sostegno di Mosca per uscire dall’impasse. Sebbene la situazione politicamente critica non sia degenerata – per il momento – in scontri militari e rappresenti una questione interna alla Bosnia Erzegovina, il ministro della Difesa albanese Pirro Vengu ha dichiarato che i tre Paesi firmatari «considerano le minacce al fragile contesto di sicurezza come una realtà condivisa. In questo contesto, il nostro impegno nello sviluppo delle nostre capacità di difesa è più forte che mai». Ciononostante, «questa cooperazione non minaccia nessuno». Difficile sostenerlo, specialmente alla luce delle affermazioni pronunciate sul punto dal ministro della Difesa kosovaro Ejup Maqedonci, il quale ha ventilato una presunta longa manus serba dietro l’attivismo di Dodik, e qualificato l’accordo di cooperazione militare appena raggiunto come «un messaggio rivolto a coloro che intendono minacciare la regione. Manifestiamo coesione e fermezza di fronte e a qualsiasi tentativo di destabilizzazione».
A dispetto alle assicurazioni verbali fornite dai firmatari, l’accordo di cooperazione assume una valenza smaccatamente ostile alla Serbia, già sottoposta a forti pressioni dall’Unione Europea affinché imponga sanzioni alla Russia e “assediata” dalla Nato, a cui va costantemente avvicinandosi il Kosovo grazie al sostegno di Albania e Croazia, membri attivi dell’organizzazione fin dal 2009. Per ottemperare agli standard Nato, le autorità kosovare stanno da tempo trasformando la forza di sicurezza nazionale in un vero e proprio esercito equipaggiato di tutto punto: «missili anticarro americani Tow e Javelin, Nlaw britannici, mortai da 81mm di produzione austriaca, veicoli blindati Otokar Cobra, Kirbi e Vuran e droni armati turchi Bayraktar Tb-2, veicoli corazzati ruotati M-1117 e 4×4 Humvee statunitensi». Senonché, il riarmo portato avanti da Pristina costituisce una palese violazione della risoluzione 1244 approvata nel 1999 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che proibisce la permanenza sul suolo kosovaro di qualsiasi forza armata diversa da Kfor (l’apposito contingente Nato). Allo stesso tempo, il Kosovo è legato alla Serbia da relazioni fortemente conflittuali: l’indipendenza dichiarata unilateralmente da Pristina nel 2008 non è mai stata riconosciuta da Belgrado, che considera la regione kosovara parte integrante del territorio nazionale governata da autorità illegittime responsabili di trattamenti smaccatamente discriminatori nei confronti della minoranza serba – finiti al centro di ricorrenti crisi regionali.
Miloš Vučević, primo ministro serbo ormai dimissionario, ha domandato sarcasticamente in cosa consista «l’interesse di due membri della Nato a intraprendere una cooperazione militare con “istituzioni non riconosciute” formate illegalmente su una parte del territorio serbo». Dichiarazioni dello stesso tenore sono state formulate dal presidente serbo Aleksandar Vučić, il quale ha identificato l’accordo di cooperazione siglato tra Tirana, Zagabria e Pristina come una «flagrante violazione dell’accordo subregionale sul controllo degli armamenti del 1996», destinata a produrre effetti altamente destabilizzanti a livello regionale. Vučić ha quindi aggiunto che «per noi, si tratta di una situazione difficile, ma abbiamo compreso il messaggio, e difenderemo il nostro Paese da ogni potenziale aggressore». In primo luogo, affinando il programma strategico di potenziamento e modernizzazione delle forze armate. Secondariamente, consolidando la cooperazione militare con l’Ungheria, nel solco di un processo di avvicinamento in corso ormai da anni e formalizzato con un partenariato strategico esteso al settore della difesa. Più specificamente, ha precisato il Ministro della Difesa ungherese Kristóf Szalay-Bobrovniczky, «Ungheria e Serbia hanno i più forti legami bilaterali in materia di difesa e militare tra gli Stati non membri dell’Unione Europea o della Nato, e l’Ungheria sta contribuendo a potenziare le forze armate serbe […]. In base al nuovo accordo, i due Paesi organizzeranno 79 programmi congiunti nel 2025 […]. L’Ungheria si impegna a mantenere la stabilità e la pace nei Balcani occidentali, e la Serbia è fondamentale».
Il principio di autodeterminazione dei popoli, invocato in passato per estendere le frontiere della Nato e attualmente per istituire una coalizione “difensiva” albanese-croato-kosovara, ha ancora una volta prevalso su quello della “indivisibilità della sicurezza”. Ieri come oggi, l’iniziativa multilaterale mossa in funzione di un nemico più o meno dichiarato spinge quest’ultimo a tutelarsi, attraverso misure di bilanciamento che accrescono inesorabilmente le tensioni in essere deteriorando l’equilibrio strategico areale. Con tutte le implicazioni di sorta.