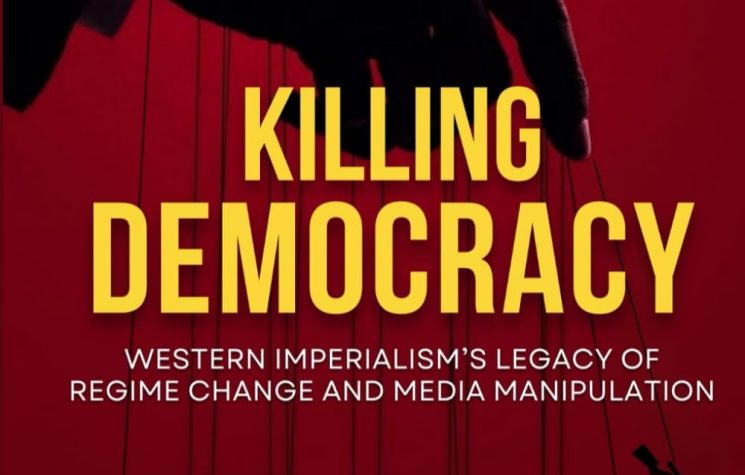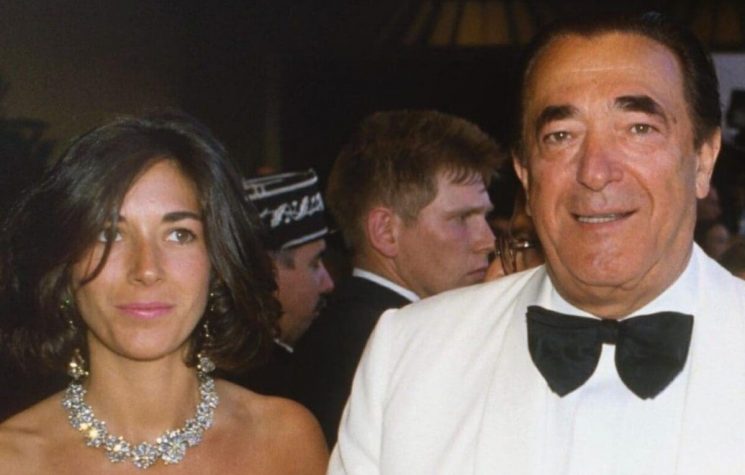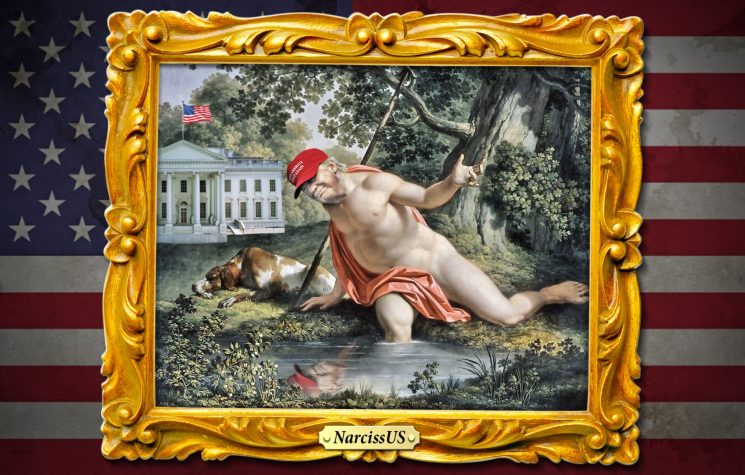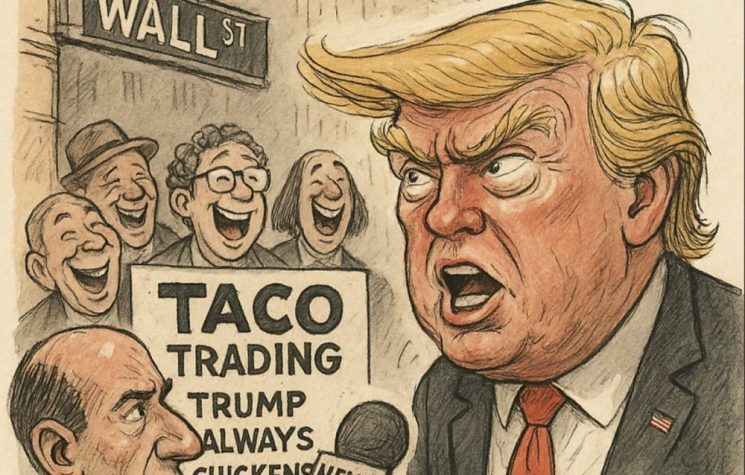Comprendere le radici culturali e ideologiche del rinnovato fenomeno trumpista appare fondamentale per intuire quelle che saranno le traiettorie geopolitiche della nuova amministrazione statunitense.
In un testo pubblicato nel 1987 – in prossimità del termine di quella presunta “grande festa nazionale” rappresentata dall’era reaganiana – e dal titolo emblematico Ascesa e declino delle grandi potenze, Paul Kennedy affermò: “Gli Stati Uniti corrono ora il rischio, tanto familiare agli storici dell’ascesa e caduta delle grandi potenze del passato, di quello che si potrebbe chiamare eccessiva estensione imperiale: vale a dire che i governanti di Washington devono affrontare lo spiacevole e assodato fatto che il numero degli interessi e impegni degli Stati Uniti va oggi ben oltre le effettive possibilità che il paese ha di proteggerli e mantenerli”.
Ad onor del vero, coloro che vennero dopo Reagan, sotto diversi aspetti, tali impegni ed interessi furono addirittura capaci di aumentarli in modo esponenziale, soprattutto a seguito del trionfo neocon nel corso dell’era Bush (figlio). Alla luce di ciò, esiste una prima chiave di lettura (la più semplice) per comprendere gli obiettivi del “trumpismo”: la riduzione drastica del catastrofico debito pubblico statunitense, attraverso la razionalizzazione del settore burocratico, la riduzione degli impegni diretti all’estero ed un progressivo abbattimento dei costi della politica. Uno degli obiettivi che Trump si è prefissato attraverso l’istituzione del DOGE – Department of government efficiency affidato alla guida del multimiliardario Elon Musk; esperto in licenziamenti di massa, quanto nell’ottenere sussidi statali per finanziare i suoi progetti tecno-satellitari-militari. A questo proposito, dunque, non sorprende più di tanto neanche il taglio dei fondi al sistema USAID; un qualcosa che alcuni settori del Partito repubblicano avevano in realtà già preventivato a partire dagli anni ’80 del secolo scorso (proprio da quell’era reaganiana in cui si è affermato definitivamente l’immobiliarista Donald J, Trump) con il cosiddetto “Contratto per l’America”. Questo, tra gli altri, prevedeva: la riduzione dell’apparato statale ai minimi termini; l’abolizione dei programmi sociali; il taglio delle tasse per i vertici della piramide sociale nella speranza che l’elemento economico (più attivo?) fosse in grado di produrre ricadute a pioggia su tutta la popolazione (in verità si è prodotta solo accumulazione verso l’alto, ulteriormente accentuata a seguito della crisi del 2008); un taglio totale dell’aiuto estero se non direttamente utile agli interessi diretti nordamericani.
La più o meno presunta diminuzione dell’impegno internazionale degli Stati Uniti è un elemento classico del conservatorismo-populista di stampo nordamericano (si pensi al fenomeno Ross Perot, il miliardario texano che su tale “diminuzione” basò la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 1992), alla pari di un altrettanto presunto isolazionismo che nei fatti non è mai storicamente esistito (né in passato, né in futuro: protezionismo e isolazionismo sono due cose assai diverse). Come sosteneva Carl Schmitt, la “dottrina Monroe”, primo manifesto dell’isolazionismo a stelle e strisce (isolazionismo politico e mai commerciale), si presentava in verità come la prima concreta espressione dell’imperialismo nordamericano, vista che l’idea di fondo, ben espressa dallo stesso Monroe, era quella non esistesse nella storia del mondo alcun esempio di progresso verso la felicità paragonabile alla Nazione statunitense. Ancora, la svolta isolazionista che segui la sbornia wilsoniana dopo la Prima Guerra Mondiale, non pretendeva affatto una chiusura in sé degli Stati Uniti ormai ampiamente inseriti all’interno dei mercati globali (Washington, profondamente indebitata nel 1914, uscì dal conflitto come Paese creditore dello sforzo dell’Intesa); semplicemente, rivendicava una piena libertà di azione degli USA in modo da poter far pesare sulla comunità internazionale tutto il loro peso (motivo per il quale non aderirono alla Società delle Nazioni).
All’era Reagan, inoltre, appartiene anche la rielaborazione di alcuni tratti caratteristici della “filosofia pubblica” statunitense come il senso di una missione religiosa, la demonizzazione del termine “liberal” come intrinsecamente connesso allo statalismo e dunque ad una forma di governo “un-American” (oggi il medesimo termine viene utilizzato anche per indicare quella corrente politica progressista vicina alle tendenze “woke”) e l’opposizione tra “nazione” e “governo”, a sua volta riutilizzata nelle campagne elettorali trumpiste attraverso l’opposizione tra “popolo” e “deep State”. Anche in questo caso bisogna considerare due fattori. In primo luogo, la denuncia del potere eccessivo del “deep State” non è una prerogativa del trumpismo. Già Dwight Eisenhower, al termine del suo secondo mandato, aveva fatto riferimento al potere incontrollato e minaccioso (per la democrazia) che stava assumendo il “complesso militare-industriale”. Eisenhower, tra l’altro, fu il primo (e forse unico) Presidente USA a denunciare la politica delle lobbies ed in particolare il potere crescente della lobby sionista all’interno del Congresso. Tutt’oggi, tra l’altro, la sovra-rappresentazione trasversale di tale lobby nelle strutture di potere nordamericane costituisce un problema di non poco rilievo se si considera la sua capacità (enorme) di influenzare le decisioni in politica estera di Washington (aspetto particolarmente evidente anche nell’attuale amministrazione Trump, come si metterà in evidenza).
Sulla “minaccia alla democrazia” occorre aprire una breve parentesi. In realtà, rimane piuttosto problematico definire gli Stati Uniti come una vera e propria democrazia. Molti dei cosiddetti “padri fondatori” non presero mai seriamente l’idea di una democrazia rappresentativa, altri la ripudiavano apertamente. James Madison, ad esempio, faceva una chiara distinzione tra democrazia e repubblica, laddove il primo termine, a suo dire, rivestiva un’accezione chiaramente dispregiativa. E gli stessi “padri fondatori” videro bene di creare tutta una serie di strumenti (affinati nel tempo) rivolti a limitare l’influenza diretta della sovranità popolare sul processo selettivo del vertice politico: primo fra tutti la distinzione tra voto popolare e voto elettorale attraverso il sistema dei “grandi elettori”. A ciò si aggiunga lo sviluppo, nel corso dei decenni, di gruppi di pressione (le suddette lobbies) e precise oligarchie politico-industriali che hanno dato vita ad una sorta di managed democracy che oggi si manifesta attraverso il ricorso da parte di suddetti gruppi plutocratici a forme di sorveglianza digitale per ridurre l’esperienza umana a fattori misurabili e osservabili anche in modo da manipolare i consensi. L’esperienza trumpista non è affatto estranea a questo processo e la stessa (presunta) lotta contro il “deep State” si risolve in suo rinnovamento in uomini, mezzi e (solo parzialmente) in idee (di fatto, lo scontro tra gli agglomerati High Tech con più di un’aspirazione all’espansione nel settore militare ed il tradizionale complesso bellico-industriale rigidamente gerarchizzato).
A questo proposito, appare particolarmente interessante l’utilizzo di un modello di “propaganda permanente” che richiama, ancora una volta, un altro aspetto caratteristico della storia statunitense. Già a cavallo tra le due guerre mondiali (e prima di Joseph Goebbels), infatti, John Dewey (il padre del “pragmatismo” e del “liberalismo scientifico” come unico metodo per produrre cambiamenti rivoluzionari), sosteneva la tesi che la propaganda fosse il più utile strumento di indottrinamento/educazione delle masse. Ora, come sosteneva anche Karl Haushofer nel suo Bausteine zur Geopolitik (Elementi costitutivi della geopolitica), la rappresentazione mediatica (e dunque il livello della propaganda) è parte integrante della geopolitica. Questa è fondamentale per conquistare un appoggio emotivo (mai criticamente fondato) all’azione (di qualsiasi tipo essa sia). Così, i media, dal punto di vista della geopolitica, possono essere considerati come l’insieme degli strumenti che rappresentano il potere e politica. E la “geopolitica critica”, a sua volta, studia i contenuti dei media per comprendere gli interessi del potere, la particolare relazione tra gli stessi media e gli strumenti del potere ed i modi in cui il potere utilizza il dato geografico per legittimare i suoi interessi. In particolare, analizza gli assunti geografici e i modelli spaziali impliciti nei discorsi e nelle rappresentazioni degli attori che producono la politica internazionale. In altri termini, cerca di capire come il potere si legittimi attraverso le sue rappresentazioni contenute nei discorsi dominanti.
L’analisi del fenomeno trumpista, in questo senso, non può prescindere dall’analizzare il ruolo decisivo che la rete internet ha (ed ha avuto nel passato prossimo) in suddette relazioni di potere, introducendo di fatto il postmodernismo nella geopolitica. Le rete internet ha precise caratteristiche spaziali. Questa, inoltre, ha rappresentato un’innovazione fondamentale che ha modificato i rapporti di potere (ciò che a suo tempo fece l’introduzione della carta stampata in qualità di strumento di diffusione del protestantesimo). Se i media tradizionali hanno un’impostazione verticale; la rete ha un’impostazione orizzontale. Questa impostazione “orizzontale”, da un lato, fornisce alla rete un’aura di democraticità amplificata dalle continue accuse ai media tradizionali di fornire un’informazione parziale e corrotta (le accuse alla CNN o ai quotidiani “liberal”, ad esempio, sono un fenomeno antecedente al trumpismo, ma sono state ampiamente cavalcate dallo stesso Trump); dall’altro, la presunta impostazione orizzontale si presenta in contraddizione con il fatto che le società che controllano i flussi della rete facciano parte di ben precise concentrazioni industriali con altrettanto precisi interessi politici e geopolitici. Molte di esse, inoltre, hanno le loro sedi negli Stati Uniti. Cosa che, inevitabilmente, facilità la diffusione di stereotipi interpretativi e di “notizie” (vere o false che siano) del tutto in linea con una ben determinata visione del mondo (quella “occidentale”), oppure la riproduzione su scala globale (o almeno sullo spazio occidentale) di un conflitto oligarchico interno al sistema di dominio egemonico statunitense (ad esempio, il presunto scontro dicotomico globalisti/sovranisti sul quale si è costruita la dialettica politica degli ultimi decenni).
La moltiplicazione delle piattaforme mediatiche e sociali sulla rete, di fatto, non corrisponde ad una maggiore libertà di informazione. Semplicemente, diventa una nuova dimensione della infowar sia verso l’interno che verso l’esterno. I mezzi di informazione e le piattaforme sociali (alla pari delle agenzie di rating, delle ONG, dell’utilizzo strumentale del terrorismo, degli agglomerati industriali, dei fondi di investimento – si pensi al ruolo di BlackRock sul controllo di Panama, patrocinato dalla nuova amministrazione Trump) producono potere. Ed il potere, parafrasando Focault, in qualità di fenomeno totalizzante e pervasivo, ha sempre carattere circolare e reticolare.
In questo caso, il fenomeno trumpista (soprattutto nel suo secondo esperimento) ha saputo sfruttare appieno a proprio vantaggio l’impostazione orizzontale della rete per portare a galla l’interazione mutevole tra molteplici poteri – anche eterogenei, si pensi al ruolo delle compagnie petrolifere, all’industria tecnologica ed ai predicatori-imprenditori evangelici – che si sono stratificati nel corso del tempo generando una nuova forma di potere né particolarmente reazionaria né (tanto meno) rivoluzionaria. Questa, sotto tutte le sue forme, è semplicemente il prodotto del preciso percorso storico degli Stati Uniti. In essa, infatti, non mancano i richiami al messianismo, ai periodici “grandi risvegli”, al mito dell’abbondanza e di una nuova “età dell’oro”, della frontiera, dell’eccezionalità statunitense, della sua missione civilizzatrice e della sua superiorità tecnologica; e non manca, per giunta, quel disprezzo nei confronti dell’Europa che ha contraddistinto la cultura nordamericana sin dalle origini. Si pensi alle liriche di Walt Whitman, all’aperta avversione nei confronti del cattolicesimo (a lungo marginalizzato); oppure a quelle tendenze cospirazioniste di matrice ottocentesca (ma ancora vive, sebbene sotto altre spoglie) che vedevano le potenze europee (papato incluso) complottare per la distruzione degli Stati Uniti d’America o del loro stile di vita. Ognuno di questi aspetti merita di essere analizzato in modo più dettagliato.
Sul finire degli anni ’90 del secolo scorso, il pensatore argentino Norberto Ceresole ebbe modo di osservare come la dialettica politica nordamericana fosse solo la punta dell’iceberg dietro la quale si nascondevano riflessi quasi secondari di un movimento assai profondo (nato intorno agli anni ’60) che aveva condotto alla riaffermazione delle categorie proprie del fondamentalismo evangelico. Queste, a loro volta, erano intimamente legate ai fenomeni dei ricorrenti “grandi risvegli”. Il primo di essi avvenne intorno alla metà del XVIII secolo e si caratterizzò per una esibizione pubblica della religiosità che trasformò i predicatori in vere e proprie celebrità (un aspetto evidente anche nella contemporaneità). Jonathan Edwards, uno dei più noti tra essi, arrivò ad affermare che l’America aveva il dovere di avviare il più splendido rinnovamento del mondo e che la sua indipendenza sarebbe coincisa con la creazione del regno di Cristo sulla terra. Tale tendenza venne ripresa nel corso del secondo “grande risveglio” (intorno alla metà del XIX secolo), al quale si lega sia la nascita dell’idea del “destino manifesto”, sia la diffusione delle cosiddette “denominations”: ossia, di nuove confessioni protestanti accanto a quelle tradizionali anglicana e presbiteriana (erede di quei puritani che erano arrivati nel Nuovo Continente nella convinzione di rivivere l’esodo biblico ed il patto con il Dio veterotestamentario).
Ancora sul finire dell’Ottocento, vi fu l’affermazione del populismo nordamericano, che ebbe tra i suoi precursori quel Andrew Jackson, fautore della “politica di massa” tanto ammirato dallo stesso Trump in quanto selfmade man, i cui sostenitori saccheggiarono i palazzi del potere di Washington nel 1829 alla pari di quanto fatto da quelli trumpisti, nonostante i primi stessero festeggiando e non protestando. Questo, ricco di componenti cospirazioniste e razziali (che successivamente si manifesteranno anche in tesi eugenetiche di difesa della razza bianca), si presentava pure come forma di difesa di un cristianesimo autentico ed incontaminato. A ciò, inoltre, si accompagnava la glorificazione degli affari, dell’imprenditorialità, della prosperità come espressione della benevolenza divina (i grandi oligarchi di fine Ottocento vennero considerati come interpreti del vero “spirito americano”), del progresso tecnologico e scientifico come fine ultimo e processo permanente più ancora che strumento per garantire l’efficienza della società (elemento ripreso nella contemporaneità dalle aspirazioni transumaniste del “muskismo” e dalla sua “corsa” ai nuovi spazi digitali ed extraterrestri).
Molti di questi elementi si ritrovano intatti nel vocabolario ideologico del trumpismo, cui si aggiunge un modello della leadership carismatica proprio di personalità quali il già citato Jackson, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy o lo stesso Reagan, che appare come il principale modello di riferimento. É curioso osservare anche che il tema dell’“America First”, tanto caro al trumpismo, venne paradossalmente introdotto da Woodrow Wilson in riferimento al suo iniziale rifiuto ad intervenire direttamente nel Primo Conflitto Mondiale (la storia insegna che le cose presero un’altra piega anche in quella circostanza).
All’era Reagan, invece, appartiene la costruzione della solida alleanza tra il fondamentalismo evangelico (il cui bacino elettorale continua a crescere così come la convinzione, tra di esso diffusa, di un imminente secondo avvento di Gesù Cristo, si dice prima del 2050) e quello ebraico che, dopo l’esperienza neocon, sembra essere giunto alla piena affermazione con la presidenza Trump (nonostante il progetto di riconoscimento di Gerusalemme quale capitale dello “Stato ebraico” fosse stato già messo in preventivo nel corso dell’amministrazione Clinton, alla pari del muro ai confini del Messico, ma questo rientra nel discorso sulla continuità geopolitica tra le diverse amministrazioni USA). Ad ogni modo, se è vero che il fondamentalismo evangelico cerca di ritrovare una perduta volontà di potenza attingendo a piene mani alle fondamenta religiose dell’America; è altrettanto vero che il fondamentalismo ebraico cerca di controllare a proprio vantaggio l’enorme capacità militare americana per assecondare gli interessi strategici e le aspirazioni di potenza (venate di altrettanto millenarismo teopolitico) israeliane.
Di particolare interesse, infine (e sul piano prettamente geopolitico), sono le aspirazioni espansionistiche espresse dalla nuova amministrazione USA verso l’America Latina, Groenlandia o Gaza. A prescindere dall’aspetto meramente strategico (l’affermazione di una “dottrina Monroe del XXI secolo, il controllo sulle rotte artiche per eludere il vantaggio russo-cinese sulle stesse, il controllo delle vie energetiche marittime verso l’Europa), queste devono essere interpretate ancora una volta sulla base del peculiare approccio nordamericano alla propria evoluzione storica. In questo caso, il trumpismo appare in primo luogo come una delle innumerevoli forme di riproduzione del senso di appartenenza prodotte nel corso della storia nordamericana. Tale affermazione, naturalmente, necessita di un esempio. Alla fine degli anni ’70 del secolo scorso, tra scandali e la rovinosa sconfitta in Vietnam, gli Stati Uniti sembravano aver perso il loro slancio vitale di guida del cosiddetto “mondo libero”. L’ascesa di Ronald Reagan alla Casa Bianca, in questo contesto, venne percepita come l’inizio di una nuova epoca, all’insegna di un rinnovato spirito patriottico strettamente interconnesso al mito del libero mercato e del neoliberismo sfrenato. Così, gli spazi liberi dello stesso mercato sostituivano in qualche modo lo spirito di conquista della frontiera e la conseguente appropriazione di nuovo spazio “vitale”. Più o meno allo stesso modo, l’elezione di Trump viene da tanti percepita come una necessaria catarsi dalla quale ripartire per ristrutturare il modello statunitense e, sotto certi aspetti, l’intero decadente Occidente. A questo proposito, inoltre, bisogna tenere a mente che, sin dalla fine dell’Ottocento (quando il “mito della frontiera” si stava esaurendo), alcune correnti di pensiero nordamericane affermarono la tesi che per rendere sostenibile il sogno americano fosse (era ed è tutt’oggi) necessario che suddetto mito venisse proiettato verso l’esterno in modo da riprodurre costantemente il già citato senso di nuova e rinnovata appartenenza e di continuare a vivere la tensione realizzativa di un (percepito) “mondo della luce” (lo spazio pensato in origine dai gruppi protestanti arrivati sulle coste del Nord America) che si pone in naturale contrasto/opposizione con il “mondo delle tenebre” (tutto il resto; tutto ciò che non è stato pienamente omologato allo spirito americano). Il trumpismo non è affatto estraneo a questa dinamica evolutiva. Ed il suo presunto disimpegno dal teatro ucraino non dovrebbe ingannare più di tanto. Questo, in realtà, si presenta come un impegno a tutti gli effetti a penetrare nel tessuto economico e politico del Paese dell’Europa orientale, attraverso l’appropriazione di ciò che rimane delle sue risorse in cambio di protezione (una riaffermazione di quello che sempre il “geo-giurista” Carl Schmitt definiva nei termini di “gangsterismo politico”). Porre fine al conflitto in Ucraina (la cui responsabilità diretta ricade sulle ultime tre amministrazioni statunitensi, primo mandato trumpista compreso), di fatto, è assolutamente in linea con gli interessi strategici di lungo periodo di Washington nel momento in cui ha raggiunto l’obiettivo di separare le risorse energetiche russe dal potenziale industriale dell’Europa occidentale e nel momento in cui il cordone sanitario atlantista ai confini russi consentirà agli Stati Uniti di inglobare l’Europa in una sorta di “superstato occidentale”. In questo, il trumpismo si manifesta come il tentativo ultimo di dare allo stesso Occidente una struttura pseudoimperiale in cui gli apparati di sicurezza vengono appaltati ad agenzie private direttamente collegate al centro (Washington) che detiene il primato tecnologico, militare ed economico a discapito delle aree periferiche. Colpisce, in questo senso, il fatto che il presunto programma “Rearm Europe” si risolverà in un ulteriore flusso di capitali verso l’industria degli armamenti USA (esattamente ciò che Trump chiedeva ai suoi sottoposti).