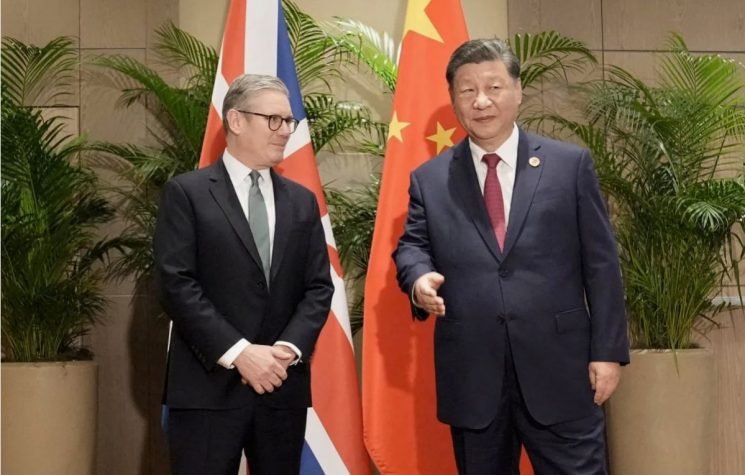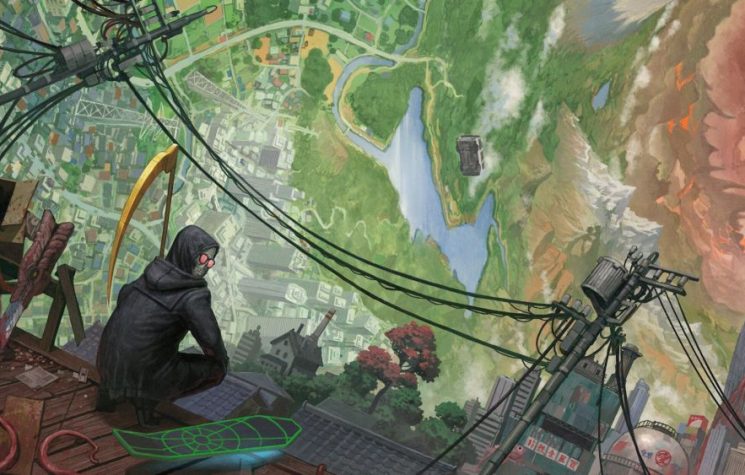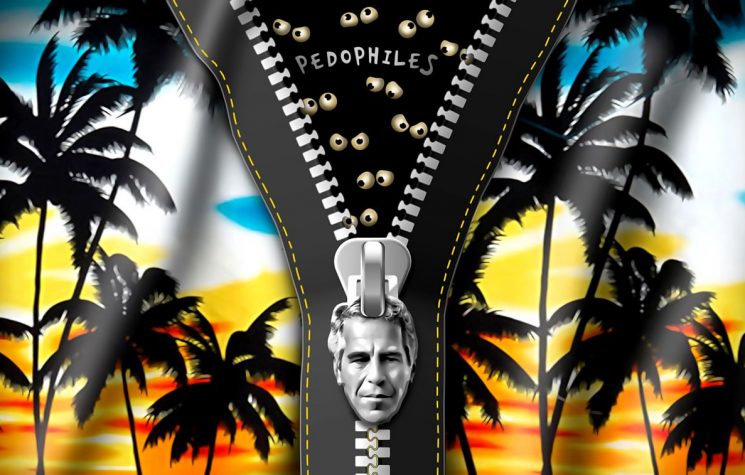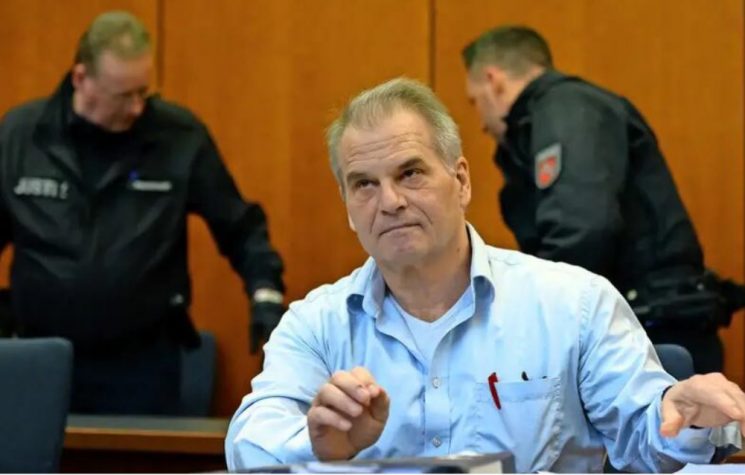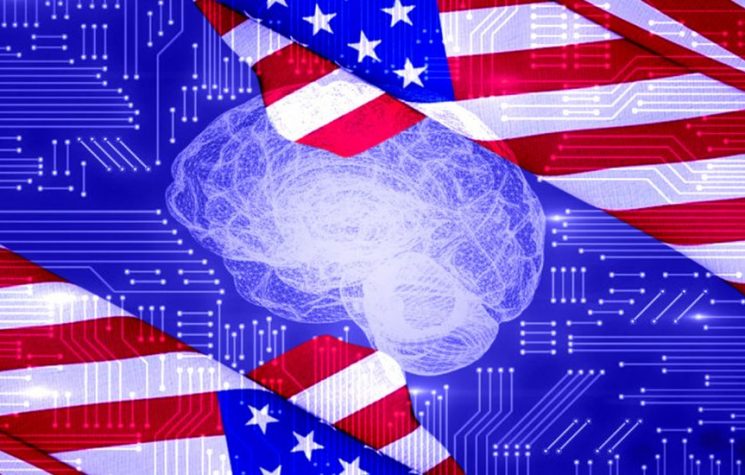Riuscirà l’Europa a cambiare la propria politica per passare alla cooperazione globale con i paesi BRICS, al libero scambio e al raggiungimento della tanto agognata “autonomia strategica”?
Fondato nel 2009, il gruppo BRIC inizialmente riuniva Brasile, Russia, India e Cina in un’iniziativa economica che univa i principali Stati che cercavano di sviluppare un’alternativa al G7 (il gruppo delle sette principali economie occidentali). Nel 2011 tale formato si è espanso per includere il Sudafrica, adottando il suo nome attuale, BRICS. Questo gruppo sostiene la riforma delle organizzazioni finanziarie internazionali, l’ampliamento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e l’istituzione di un ordine politico “più equilibrato e più equo”, puntando in particolare alla dedollarizzazione degli scambi commerciali. Sebbene all’epoca rappresentasse il 42% della popolazione mondiale e il 27% del PIL globale, esso deteneva solo il 15% dei diritti di voto alla Banca Mondiale e il 10% al FMI.
Durante gli anni 2010, una ventina di Paesi hanno presentato domanda di adesione ai BRICS ma la richiesta di alcuni di essi è stata per ora bloccata da uno o più Stati fondatori, che hanno diritto di veto sul processo di adesione, quindi il processo di allargamento è temporaneamente fermo a 11 membri.
La prima ondata di espansione (1° gennaio 2024) si è concentrata sul Medio Oriente, poiché questa regione strategica è centrale per la priorità economica della Cina: l’approvvigionamento di idrocarburi e materie prime. Essa comprende Iran, Arabia Saudita (ancora incerta sul da farsi), Emirati Arabi Uniti, Egitto (Canale di Suez) ed Etiopia (sede dell’Unione Africana). L’Indonesia, che controlla gli Stretti di Malacca e della Sonda e rimane un importante produttore di petrolio, diventa membro a pieno titolo il 1° gennaio 2025. Nella stessa data, è stato creato lo status di “partner” che facilita l’accesso al gruppo tramite la partecipazione ai vertici e ne rafforza il peso economico e demografico. Questo status meno restrittivo consente ai BRICS+ di stabilire una presenza in tutti i continenti. Malesia, Thailandia, Kazakistan, Uzbekistan, Bielorussia, Nigeria, Uganda, Bolivia e Cuba sono così diventati partner, a dimostrazione della strategia di globalizzazione dei BRICS+ volta a sfuggire al controllo occidentale e alle sanzioni internazionali (per Iran e Russia), aprendosi al contempo a nuovi mercati. Questa stessa logica ha portato i BRICS+ a istituire una Nuova Banca di Sviluppo – a cui hanno aderito anche Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bangladesh – per costituire una riserva di valuta estera e fornire prestiti (al di fuori del FMI) alle economie emergenti.
Sebbene Russia, Cina e India si considerino le tre forze trainanti dei BRICS+, è innegabilmente la Cina ad essersi affermata come leader di questo gruppo, che ora comprende 11 Stati membri e 9 Stati partner, che rappresentano il 47,6% della popolazione mondiale e il 42,4% della ricchezza globale espressa in parità di potere d’acquisto. A titolo di confronto, il G7 rappresenta attualmente meno del 10% della popolazione mondiale e poco meno di 1/3 della ricchezza globale. Le proiezioni economiche stimano che il gruppo BRICS+, compresi i suoi partner, rappresenterà oltre la metà della popolazione e della ricchezza mondiale entro il 2040.
I BRICS aspirano ad esercitare influenza sulla scena internazionale incarnando una piattaforma di dialogo e cooperazione tra i Paesi del Sud del mondo. Sebbene internamente i BRICS abbiano interessi talvolta divergenti, tutti concordano nel desiderio di dare ai Paesi emergenti una voce più forte all’interno delle istituzioni internazionali, che ritengono non riflettano più le realtà del XXI secolo, in un’ottica multipolare. È inoltre interessante notare che la maggior parte degli Stati aderenti al gruppo nel 2024 sono già membri del G20 (Gruppo dei 20, che include ovviamente i membri del G7), conferendo così al gruppo BRICS un certo rilievo sulla scena internazionale.
Perché l’Europa non può trascurare questo storico fenomeno di cambiamento geopolitico?
La strategia di intelligenza artificiale dei BRICS mira a contrastare la monopolizzazione del potere digitale da parte di aziende e governi occidentali, andando oltre il mero progresso tecnologico. Una sfida significativa risiede nell’attuale infrastruttura di intelligenza artificiale, che si basa prevalentemente su piattaforme occidentali come Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure, che dominano il cloud computing. Inoltre, modelli fondamentali come GPT-4 e Claude sono addestrati su set di dati che riflettono le epistemologie occidentali, spesso trascurando i linguaggi, i valori e i contesti pertinenti al Sud del mondo.
In risposta al panorama globale dell’intelligenza artificiale, i Paesi BRICS stanno attivamente sviluppando i propri Large Language Model (LLM). La Cina ha introdotto “WuDao” ed “Ernie”, mentre la Russia ha lanciato “GigaChat”. L’iniziativa dell’India “Bhashini” rappresenta un passo significativo verso la sovranità linguistica dell’intelligenza artificiale, concentrandosi su una piattaforma di intelligenza artificiale multilingue addestrata nelle lingue del Paese. Inoltre, nel 2024, Brasile e Cina hanno annunciato un progetto di ricerca collaborativa sull’intelligenza artificiale per creare un LLM portoghese-spagnolo specificamente progettato per i contesti latinoamericani.
La strategia dei BRICS per l’intelligenza artificiale comprende anche la governance. Il vertice BRICS del 2024 a Kazan ha visto l’adozione della “Carta BRICS per un’intelligenza artificiale responsabile”. Questo documento promuove uno sviluppo dell’intelligenza artificiale inclusivo, trasparente e culturalmente sensibile, in netto contrasto con l’AI Act dell’Unione Europea. Molti nel Sud del mondo criticano l’Act dell’UE per le sue norme eurocentriche e per i limiti alla sperimentazione dell’intelligenza artificiale nei Paesi in via di sviluppo.
La Nuova Banca di Sviluppo è sempre più attiva nel finanziamento delle infrastrutture di intelligenza artificiale. Nel 2025, la NDB ha introdotto un “Fondo per la sovranità digitale” da 5 miliardi di dollari. Questo fondo sostiene parchi di ricerca sull’intelligenza artificiale, data center e produzione di semiconduttori nei Paesi membri, con progetti di rilievo come il cluster cloud per l’intelligenza artificiale degli Emirati Arabi Uniti e la zona di ricerca e formazione sull’intelligenza artificiale in Etiopia ad Addis Abeba.
Oltre ai finanziamenti, i BRICS stanno anche lavorando a uno stack di elaborazione AI non occidentale, dando priorità all’indipendenza nel settore dei semiconduttori. La cinese SMIC e l’indiana CDAC stanno sviluppando la produzione di chip a 7 nm per ridurre la dipendenza da NVIDIA e Intel. Anche il programma nazionale di calcolo quantistico dell’Iran potrebbe contribuire alle future capacità di elaborazione AI, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno effettuato ingenti investimenti nel loro conglomerato nazionale di AI, G42.
Sfidando il dominio occidentale su dati, infrastrutture, etica e narrativa, i BRICS stanno gettando le basi per un ecosistema di intelligenza artificiale veramente sovrano. Questo ecosistema rifletterà le diverse esigenze, i valori e le ambizioni di un futuro dominato dalla maggioranza della popolazione mondiale. Mentre entriamo in una nuova era guidata dai progressi tecnologici, il blocco allargato dei BRICS non sta semplicemente cercando di recuperare terreno, bensì sta anche ridefinendo attivamente le regole del gioco.
Se la COP30 in Brasile si è svolta in un clima di profonda incertezza, visto che i tradizionali “trascinatori” delle politiche climatiche globali, Unione europea e Stati Uniti, stanno riducendo le loro ambizioni, la Cina dimostra tutta la sua efficacia nella lotta contro le emissioni globali. Nel 2024, l’Unione Europea e gli Stati membri hanno mobilitato 42,7 miliardi di euro in fondi pubblici e privati, ma la richiesta globale è ormai salita a 1,3 trilioni di dollari l’anno. Questo squilibrio rende evidente quanto la lotta climatica resti diseguale, tanto sul piano politico quanto su quello finanziario. In teoria, l’UE è la candidata ovvia a colmare il vuoto di leadership lasciato dagli Stati Uniti ma la sua ambizione di “transizione ecologica” sta dimostrando limiti enormi a causa dell’autocastrazione geopolitica.
Bruxelles e l’apparato informativo atlantista puntano il dito contro Pechino ma se analizziamo i dati tenendo conto del numero degli abitanti dei principali Paesi inquinanti, ci accorgiamo che il bersaglio è completamente sbagliato. Secondo lo studio del Centro Europa e Ricerche (https://www.centroeuroparicerche.it/rapporti/n-9-ottobre-2025-2/), nel 2024, le emissioni totali cinesi di CO2 sono aumentate dell’1,2%, per complessivi 12,5 Gt, esprimendo il 30,7% delle emissioni totali globali, a fronte del 12,5% degli Usa, 6,3% dell’UE e 8% dell’India; ma, a livello pro capite, le emissioni totali di CO2 di Mondo, Usa, UE, Cina e India sono rispettivamente state, 5, 15, 5,8, 8,9 e 2,2 t/ab. Gli Stati Uniti, cioè, inquinano quasi il doppio della Cina e sette volte di più dell’India, i due principali membri BRICS insieme alla Russia.
Nel 2024, gli investimenti cinesi in energia pulita, le cosiddette “Nuove Forze Produttive” (rinnovabili, EV e batterie), hanno raggiunto i 940 miliardi di dollari, pari al 10% del PIL, contribuendo per il 26% alla crescita economica del Paese; se all’interno il consumo di carbone è diminuito dal 70 al 58% in termini relativi, la Cina è coinvolta nell’88% dei progetti di nuova capacità energetica a carbone nei nuovi Paesi membri dei BRICS.
Come sottolinea il rapporto CER, la Cina è l’unico Stato al mondo ad avere costruito una propria catena di approvvigionamento delle fonti rinnovabili, che poggia sulla leadership nei brevetti e sulle terre rare, perciò Italia e UE hanno dinanzi a sé due strade: continuare con il protezionismo, volto alla difesa delle quote di mercato dei produttori europei dalla dipendenza delle tecnologie importate dalla Cina, con il rischio di danneggiare le catene di approvvigionamento, nonché di aumentare i prezzi di materiali ed equipaggiamento rinnovabile e di condannarsi all’attuale irrilevanza.
Oppure, la collaborazione globale con i BRICS, il libero commercio e il raggiungimento della tanto agognata “autonomia strategica”, cambiando completamente il proprio paradigma geopolitico.