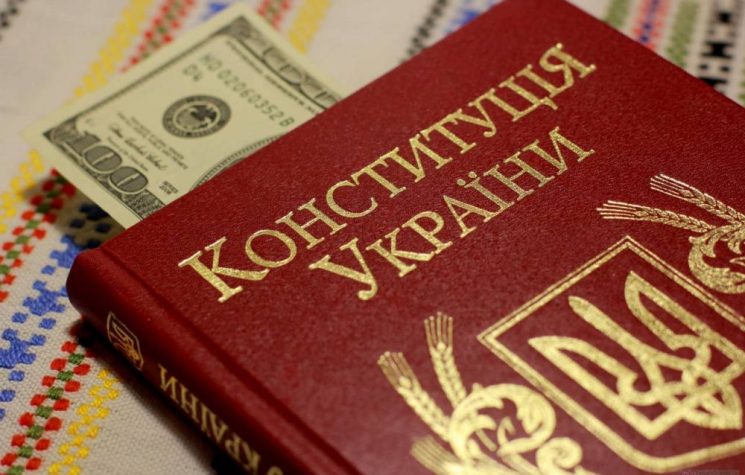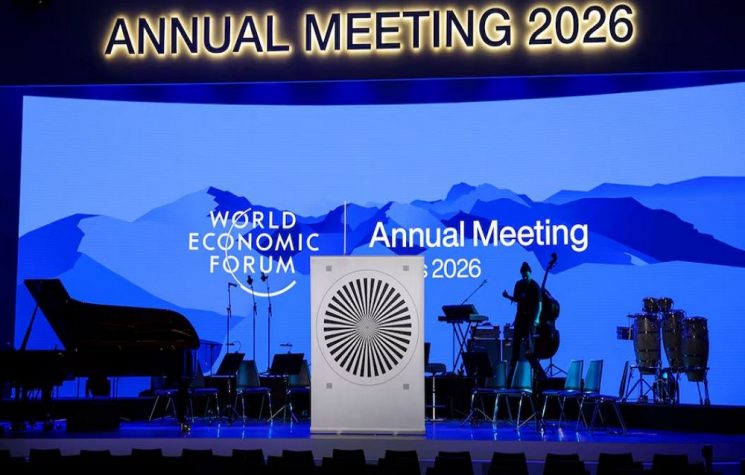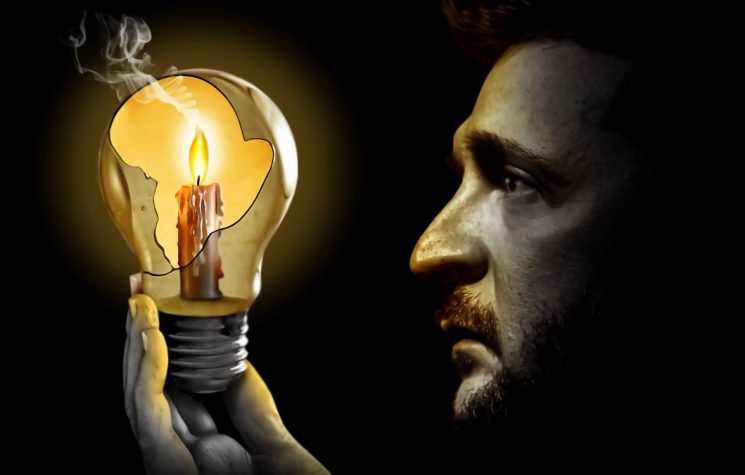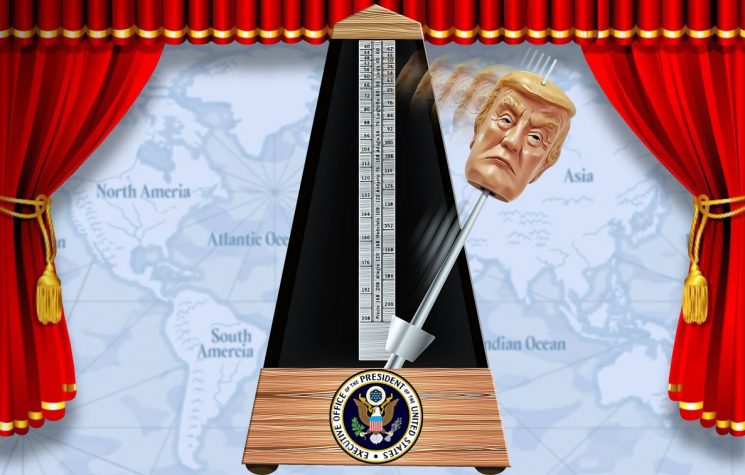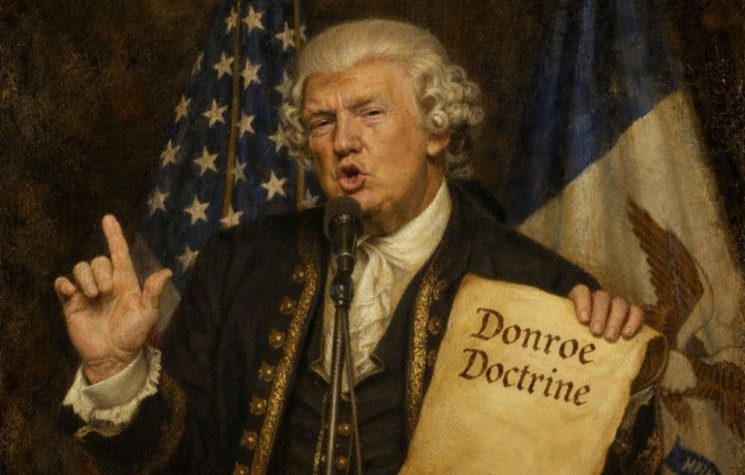L’UE si lancerà in un vero e proprio saccheggio che potrebbe distruggere definitivamente la sua economia?
Nei giorni scorsi, l’Unione Europea ha imposto il 19° pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa. I nuovi provvedimenti, adottati in parallelo all’introduzione delle misure punitive statunitensi contro Rosneft e Lukoil, contemplano un divieto graduale di importazione di Gnl e idrocarburi aciclici; limitazioni sulle operazioni finanziarie a carico di Rosneft e Gazprom Neft; ulteriori restrizioni nei confronti della “flotta ombra” russa, di banche e aziende sia russe che straniere e di produttori d’oro russi; messa al bando della stablecoin A7A5. Secondo i rappresentanti danesi che occupano la presidenza di turno dell’Unione Europea, quello appena approvato rappresenta «un pacchetto significativo, che mira a colpire le principali fonti di entrate russe attraverso nuove misure in ambito energetico, finanziario e commerciale». Senonché, come ha spiegato nel corso del recente Verona Eurasian Economic Forum di Istanbul l’amministratore delegato della compagnia energetica russa Novatek (leader nazionale del settore del Gnl) Leonid Mikhelson, «la Russia rappresenta attualmente oltre il 10% della produzione globale di Gnl» e occupa pertanto una posizione strategicamente inaggirabile, poiché «è impossibile soddisfare la futura crescita della domanda senza le riserve artiche, gran parte delle quali si trova sotto la giurisdizione russa». Ne consegue che le consegne messe al bando dall’Unione Europea «si indirizzeranno semplicemente verso altri mercati», mentre a pagare il prezzo maggiore degli «aumenti dei prezzi senza precedenti» generati dalle recenti misure punitive saranno «in particolare i consumatori europei».
La nuova tornata di sanzioni europee ha aperto il varco al disegno di legge predisposto dal Consiglio d’Europa che affida alla Commissione Europea il compito di fornire le basi giuridiche per l’erogazione di una linea di credito a favore di Kiev da 140 miliardi di euro garantita dagli asset pubblici russi sottoposti a congelamento dal marzo 2022. Si parla di 185 miliardi di dollari di beni depositati soltanto in Euroclear, società di compensazione finanziaria con sede in Belgio la cui affidabilità risulta strettamente vincolata all’osservanza del principio di neutralità e delle norme giuridiche vigenti in materia di custodia dei titoli. L’escamotage individuato dagli specialisti europei per aggirare il problema consiste nel subordinare la restituzione dei fondi russi impegnati a garanzia del prestito alla disponibilità di Mosca a rifondere riparazioni di guerra a beneficio dell’Ucraina. De facto, tuttavia, l’iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa contempla un esproprio forzoso di proprietà a danno dello Stato russo. Finora, l’Unione Europea aveva evitato di spingersi così in profondità, “limitandosi” all’implementazione di un meccanismo di sequestro, trasferimento sul bilancio comunitario e reimpiego sotto forma di assistenza nei confronti dell’Ucraina degli interessi e dei redditi generati dagli asset russi depositati presso Euroclear e altri istituti di credito. Redditi e interessi non rientrano infatti nella categoria di “proprietà sovrana”, a differenza del capitale originario che li produce. Agire unilateralmente su quest’ultimo, rappresentato nel caso specifico dalle riserve valutarie russe, significherebbe violare deliberatamente il pilastro giuridico dell’immunità sovrana degli Stati, esponendo il Belgio a colossali richieste di indennizzo per inadempienza agli obblighi contrattuali e condannando l’Unione Europea a una perdita definitiva e irreparabile di credibilità internazionale, già pesantemente danneggiata dal congelamento dei beni russi.
L’Ufficio Federale di Giustizia svizzero lo aveva già rilevato nel 2023, sottolineando che «l’espropriazione di beni privati di lecita provenienza senza indennizzo non è consentita dal diritto svizzero. La confisca di beni privati bloccati è incompatibile con la Costituzione Federale e l’ordinamento giuridico vigente. Viola inoltre gli impegni internazionali della Svizzera. Altri Paesi godono di diritti e garanzie costituzionali analoghi».
Le autorità belghe sono approdate a conclusioni sostanzialmente analoghe, ponendo per tramite del primo ministro Bart De Wever tre condizioni vincolanti per la concessione del proprio via libera: «mutualizzazione del rischio, garanzie concrete da parte di tutti i Paesi in materia di contribuzione a fronte di eventuali rimborsi e impiego di tutti i beni russi immobilizzati, anche al di fuori del territorio belga. Se queste tre ragionevolissime richieste saranno soddisfatte, allora potremo andare avanti. In caso contrario, farò tutto ciò che è in mio potere a livello europeo, anche a livello nazionale, politicamente e giuridicamente, per bloccare questa decisione». Anche perché «subiremo enormi richieste di risarcimento. Vogliamo garanzie circa il fatto che, qualora il denaro debba essere restituito, tutti gli Stati membri contribuiscano. Le conseguenze non possono riguardare solo il Belgio. Inoltre, ogni Paese che ha immobilizzato beni si muova insieme a noi, perché noi siamo gli unici, Euroclear è l’unica istituzione finanziaria che offre extra-profitti all’Ucraina. Sappiamo che ci sono ingenti somme di denaro russo in altri Paesi che sono sempre stati silenziosi al riguardo. Se ci muoviamo, dobbiamo farlo tutti insieme. Questa è la solidarietà europea».
L’irremovibilità di De Wever – definito un “bad boy” dalla rivista «Politico» per via del suo “ostruzionismo” – ha fin da subito palesato la conclamata indisponibilità alla condivisione dei rischi da parte di diversi Stati, i quali hanno invocato «rassicurazioni sulla solidità giuridica dello schema» predisposto dalla Commissione Europea, accusata di aver «sottovalutato la complessità tecnica e legale dell’operazione», in linea con la posizione assunta dalla Banca Centrale Europea dichiaratasi «preoccupata per le implicazioni sulla credibilità dell’euro come valuta di riserva mondiale». Per il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, «ci sono alcuni elementi che è necessario continuare a preservare, il primo è che dobbiamo agire in modo coerente con il diritto internazionale; il secondo è che dobbiamo agire in modo da evitare nuovi rischi economici, sia per l’eurozona che per i singoli Stati membri; in terzo luogo, dobbiamo trovare soluzioni alternative per sostenere l’economia ucraina e la sua difesa». I dubbi e timori generalizzati nei confronti dell’impianto tecnico-giuridico predisposto dalla Commissione Europea ha pregiudicato qualsiasi possibilità d’intesa collegiale in merito all’impiego a beneficio dell’Ucraina dei fondi russi congelati. Come si legge all’interno della dichiarazione finale del summit del 23 ottobre, sottoscritta da 26 dei 27 leader europei (Ungheria astenuta), «il Consiglio d’Europa invita la Commissione a presentare, il prima possibile, proposte di sostegno finanziario basate su una valutazione delle necessità dell’Ucraina, e invita le parti coinvolti a portare avanti i lavori affinché il Consiglio d’Europa possa tornare su questa questione nella sua prossima riunione», prevista per dicembre. Permane, nel documento, il passaggio alquanto vago secondo cui: «fatto salvo il diritto dell’Unione Europea, i beni della Russia dovrebbero rimanere congelati fino a quando Mosca non porrà fine alla sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e non verserà i danni causati dalla sua guerra».
Il Consiglio d’Europa sembra quindi aver preso atto che l’esproprio dei beni russi mette a repentaglio la stabilità dell’architettura finanziaria internazionale, imperniata sulla sacralità della custodia delle riserve sovrane, oltre ad aprire il varco a un’ondata di cause legali. Come ha rivelato il premier belga, «Mosca ci ha avvertito che, se tocchiamo i soldi, ne sentiremo gli effetti per l’eternità […] Gli attivi congelati non sono stati confiscati nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale […]. Se prendiamo i soldi di Putin, lui prenderà i nostri», Sebbene abbia esplicitato l’intenzione di non rivalersi su alcun bene europeo, «comprese aziende e banche», il Ministero delle Finanze di Mosca ha comunque chiarito che «valuterà la sua posizione qualora l’Unione Europea dovesse procedere alla confisca dei beni sovrani russi congelati». Di recente, il presidente Putin ha firmato un decreto che snellisce radicalmente l’iter procedurale per la nazionalizzazione la successiva riprivatizzazione di aziende sia domestiche che a capitale estero. Attualmente, all’interno della Federazione Russa operano banche e imprese quali Unicredit, Raiffeisen Bank e Pepsi.
A dispetto delle implicazioni potenzialmente catastrofiche, il presidente Macron e il cancelliere Merz hanno sostenuto con forza la confisca de facto degli asset russi, di cui i vertici dell’Unione Europea stanno cercando di imporre la digestione ai governi più recalcitranti. Lo rivela «Politico», secondo cui «l’Unione Europea è in corsa contro il tempo su due fronti. In primo luogo, l’Ucraina è destinata a esaurire i fondi entro la fine di marzo. In secondo luogo, il processo decisionale potrebbe presto diventare molto più difficile, dal momento che l’Ungheria sta tentando di unire le forze con la Repubblica Ceca e la Slovacchia, così da formare un’alleanza scettica nei confronti dell’Ucraina. Molti ritengono che occorra agire ora o mai più». Dal momento che l’eccessiva indisciplina fiscale di diversi Paesi europei rende estremamente ardua la costruzione di un consenso unanime attorno alla prospettiva degli eurobond, la requisizione dei beni russi viene inesorabilmente a configurarsi come l’unica soluzione alternativa per garantire sostegno all’Ucraina.
L’«Economist» quantifica in circa 389 miliardi di dollari per il prossimo quadriennio l’ammontare del supporto di cui Kiev necessita, e aggiunge che «l’Europa deve farsi coraggio e riconoscere la propria forza. Il suo budget militare è già quattro volte superiore a quello della Russia. La sua economia, dieci volte più grande. Invece di esitare nella battaglia finanziaria con il Cremlino, l’Europa ci si getti a capofitto e vinca la guerra».
Le valutazioni della rivista britannica superano vistosamente quelle formulate settimane addietro dal ministro della Difesa ucraino Denys Šmyhal’ secondo cui «per il 2026 il nostro fabbisogno per la guerra è di 120 miliardi: 60 verranno dal nostro bilancio, il resto deve essere fornito dai partner, o con un contributo dello 0,25% del loro Pil, tra Europa e Paesi esterni, oppure grazie all’uso degli asset russi immobilizzati». Oltre a esortare l’Unione Europea a procedere alla confisca dei beni russi, le autorità ucraine hanno intensificato le pressioni sui vertici della struttura comunitaria affinché non pongano alcun vincolo alle loro modalità di impiego. Iryna Mudra, consulente legale di alto livello del presidente Zelensky, ha affermato che: «l’Ucraina ritiene che qualsiasi condizionalità mini il principio di giustizia. Deve essere la vittima, e non i donatori o i partner, a decidere come affrontare le sue esigenze più urgenti».