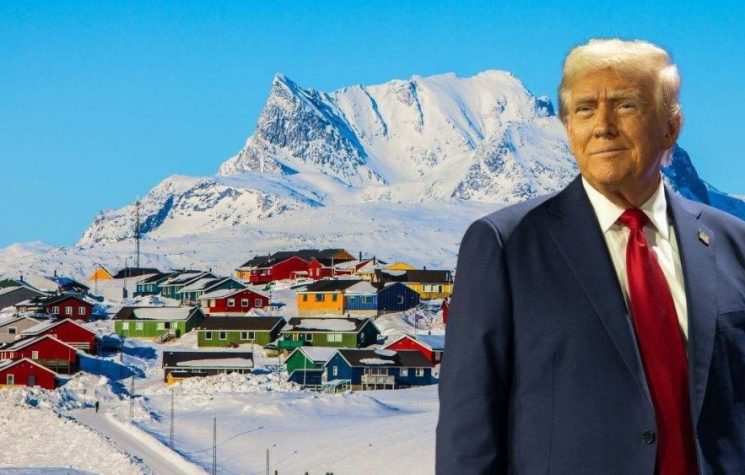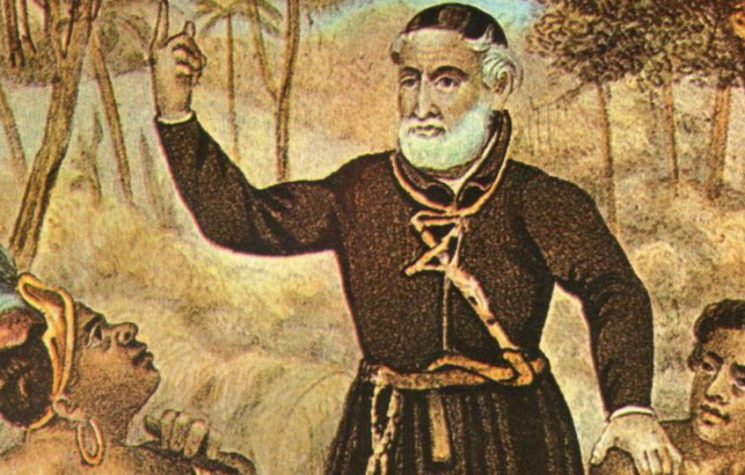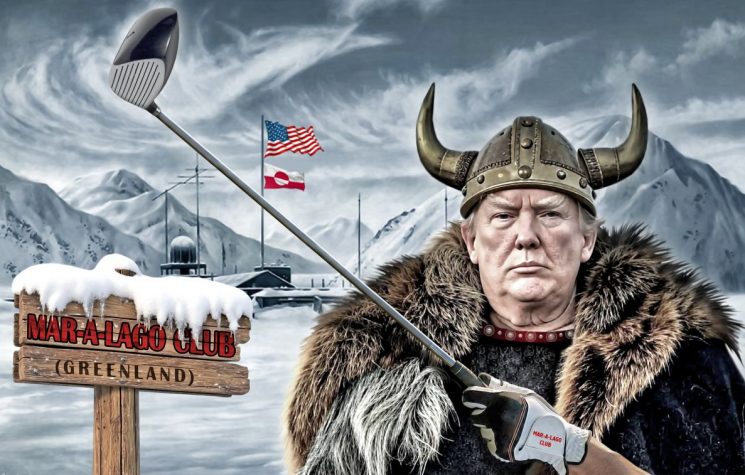Negli ultimi tempi si è ripreso a parlare, non positivamente, della questione relativa al Sahara Occidentale, soprattutto a proposito di una presunta infiltrazione iraniana nel Fronte Polisario. Qui si cercherà di verificare quanto possa esserci di vero, anche alla luce della storia di questo territorio conteso.
Quello del Sahara Occidentale è un territorio desertico e costiero piuttosto vasto (252.120 km quadrati). É composto da due regioni, il Rio de Oro e la Saguia el-Hamra, e la sua popolazione è di circa 700.000 persone. Poco si conosce della sua storia nelle età precedenti al Medioevo. L’area era sicuramente occupata da tribù nomadi, praticanti l’allevamento e la caccia, che vennero a contatto sia con i Fenici (che si spinsero sulle coste dell’Africa nord-occidentale) che con i Romani. Nel primo Medioevo la regione venne occupata da genti berbere successivamente arabizzate e convertite all’Islam. Mentre, nel 1476, venne creata dagli Spagnoli una prima colonia (Santa Cruz de Mar Pequeña) che fungeva da scalo per le rotte che successivamente si spingeranno oltre il Capo di Buona Speranza. La colonia, fondata da Diego Garcia de Herrera (già signore delle Isole Canarie), ebbe comunque vita piuttosto breve. Solo intorno alla metà del XIX secolo gli Spagnoli inizieranno una vera e propria penetrazione nel territorio che il porterà dapprima a prendere alcuni accordi con i popoli costieri, poi ad imporre loro un forma di protettorato. È sicuramente curioso il fatto che l’espansione spagnola nella regione arrivò in un momento in cui l’Impero iberico, dall’America Latina (si pensi alla “Dottrina Monroe” ed al ruolo britannico nell’indipendenza e parcellizzazione dello stesso continente iberoamericano) all’Asia (il caso filippino) stava venendo smantellato pezzo per pezzo.
Ad ogni modo, l’ulteriore espansione spagnola venne frenata/limitata dal fatto che la regione era accerchiata dalla presenza francese su tutti i lati. A ciò si aggiungano anche le prime tensioni con la popolazione locale che si ribella guidata dallo Sheikh Ma al-Aynan, fondatore della città di Smara (ancora oggi una dei centri più importanti del Sahara Occidentale). Questi, figlio del fondatore della confraternita sufi Fadiliyya (una sorta di sottordine della più nota Qadiriyya, diffusa in tutto il mondo islamico), proclamò il gihad contro le potenze colonizzatrici, ottenendo in ciò il benestare del Sultano marocchino Abdelaziz bin Hassan della dinastia alawita (regnante sin dal XVII secolo). Sebbene quest’ultimo non avesse comunque alcun reale potere di controllo sullo Sheikh.
La rivolta, nonostante il sostegno tedesco (in chiave antifrancese) non ebbe comunque vita particolarmente lunga. Nel 1906, lo stesso Sultano venne costretto, con la Conferenza di Algeciras, a garantire sostanziose concessioni a Francia e Spagna. Tuttavia, gli uomini legati alla fratellanza militare-religiosa Gudfiyya di al-Aynan continuarono ad operare almeno fino al 1910, arrivando a rallentare la penetrazione francese verso la Mauritania. Interessante anche il fatto che in questo periodo al-Aynan subì una vera e propria criminalizzazione nei quotidiani spagnoli e francesi che lo indicavano come contrabbandiere di armi, ladro, e avanzavano dubbi sulla sua fede religiosa sunnita, sostenendo che si fosse convertito allo sciismo.
Di sicuro, il mito della rivolta di al-Aynan è ancora oggi fonte di dibattito e la sua figura viene utilizzata sia dal governo marocchino come esempio di lotta unitaria tra Marocco e Sahara, sia dai miliziani del Fronte Polisario come prima manifestazione del carattere ribelle del popolo della regione.
Come nel caso della Libia, occupata dall’Italia nel 1912 ma “sottomessa” solo nei primi anni ’30 con la repressione della ribellione della confraternita della Senussia, anche il Sahara Occidentale resisterà a lungo. Smara venne occupata a tutti gli effetti solo nel 1934, in un periodo in cui iniziano a farsi sentire anche i primi sintomi di quel conflitto civile spagnolo che farà da preludio alla guerra mondiale.
Nel 1956, con l’indipendenza marocchina, ha inizio un nuovo ciclo di tensioni. L’anno successivo le truppe spagnole stanziate nella regione respingono diverse incursioni marocchine. Mentre, nel 1958, le due regioni del Rio de Oro e della Saguia el-Hamra vengono unificate nella provincia del Sahara spagnolo. Ai primi anni ’60, invece, si deve la scoperta dell’enorme ricchezza mineraria della regione (importanti riserve di fosfato scoperte a Bu Craa nel nord). Ancora oggi, tuttavia, tale ricchezza rimane difficilmente estraibile a causa della scarsità d’acqua e della sostanziale impraticabilità delle strade. Nonostante ciò, in questi anni, lo sfruttamento intensivo del territorio e la sua militarizzazione favoriscono una nuova presa di coscienza anticoloniale e nazionale per il popolo Saharawi (un processo comunque complicato dal carattere nomadico di queste genti).
Il Fronte Polisario (Fronte di Liberazione Popolare di Saguia el-Hamra e Rio de Oro) nasce nei primi anni ’70 (l’aperta ribellione contro le forze coloniali spagnole inizia ufficialmente nel 1973) come erede del Movimento di Liberazione del Sahara, represso dal regime franchista nel corso degli anni ’60. Tra i suoi fondatori spicca El Ouali Mustapha Sayed, ex membro del Partito comunista marocchino. Inizialmente, la sua base era situata in Mauritania, Tuttavia, le cose cambiano rapidamente con la fine della presenza coloniale spagnola.
A questo proposito sarebbe opportuno ricordare che questo evento si lega in modo indissolubile alla seconda fase del processo di decolonizzazione, quello in cui a venire liberati sono soprattutto i territori africani appartenenti a Portogallo e Spagna. La Spagna, in particolar modo, a cavallo della fine del regime franchista stava subendo una duplice pressione interna (la presenza del gruppo terroristico ETA, sostenuto silenziosamente anche da strutture clandestine legate alla NATO) ed esterna in favore di una sua “democratizzazione” e di un suo ingresso proprio nell’Alleanza Atlantica.
Nel 1975, il governo marocchino e l’esercito organizzano la cosiddetta “marcia verde” (350.000 marocchino oltrepassano il confine) per fare ulteriori pressioni alla Spagna affinché abbandoni la presa sul territorio saharawi. Questo, di fatto, avviene nel medesimo anno a seguito di un accordo che prevedeva la sua spartizione tra lo stesso Marocco (2/3 della regione, con le importanti riserve minerarie del nord) e la Mauritania (1/3 del suo territorio meridionale).
Con l’invasione congiunta marocchino-mauritana, la guerriglia del Fronte Polisario si attiva su più fronti anche a seguito dello spostamento della sua base in Algeria, nella strategica città di confine di Tindouf (ancora oggi sede del governo in esilio della Repubblica Democratica Araba Saharawi e di numerosi campi profughi). Nel 1979, questo arriva ad un accordo di pace con la Mauritania. Tuttavia, il Marocco si annette automaticamente la parte di territorio che l’accordo del 1975 aveva attribuito a Nouakchott ed inizia la costruzione di un triangolo di fortificazioni (Bu Craa – Laayoune – Smara) che avrebbe dovuto favorire la difesa del territorio ed il suo sfruttamento minerario in sicurezza.
Gli anni ’80 sono il periodo di maggiore recrudescenza del conflitto, con il Fronte Polisario che riesce ad organizzare un piccolo esercito di 15.000 miliziani ben armati (addirittura motorizzati) grazie all’aiuto algerino. Ma proprio con il conflitto civile algerino degli anni ’90 iniziano i primi seri problemi interni al movimento.
Nonostante ciò, a partire dalla fine degli anni ’80, l’intervento dell’ONU riesce a favorire un cessate il fuoco, l’invio di una missione di pace periodicamente rinnovata (il nuovo voto è previsto per il 31 ottobre 2025) ed un accordo di massima per un referendum attraverso il quale il popolo saharawi avrebbe dovuto decidere il suo destino. In modo da ottenere un esito favorevole, tuttavia, il Marocco favorisce in questo periodo una vera e propria colonizzazione della regione, inviandovi decine di migliaia di cittadini marocchini e rivendicando il loro diritto a partecipare al voto referendario. Fattore che, insieme alla costruzione di infrastrutture fisiche a tutto vantaggio di Rabat, ha contribuito ad inquinare il clima di preparazione ad un voto che non si è mai tenuto. Con il cambio del monarca, da Hassan II a Mohammed VI, inoltre, Rabat ha cambiato e radicalizzato la sua posizione, rigettando l’idea del voto (rifiutando una nuova proposta ONU che prevedeva cinque anni di autonomia per il Sahara Occidentale e successivamente il referendum) e sostenendo quella di un’autonomia sotto diretta sovranità marocchina. Un piano che ha incontrato, tra gli, il favore di Spagna, Francia e Regno Unito (decise soprattutto ad ottenere la cooperazione di Rabat per il controllo dei flussi migratori dal Nord Africa verso l’Europa) e che rimane comunque una delle soluzioni ad oggi più realistiche.
Lo stallo della situazione è stato interrotto dai cosiddetti accordi di Abramo nel 2020, con i quali il Re marocchino ha ottenuto il riconoscimento della sovranità sul Sahara Occidentale da parte di Stati Uniti e Israele in cambio della piena normalizzazione delle sue relazioni con Tel Aviv. E proprio al 2020 si deve il nuovo inasprimento di un conflitto che, tra bassa e alta intensità, dura da cinquantanni. In particolare, il Fronte Polisario ha colpito in modo continuato le rotte che collegano il Marocco alla Mauritania. Ma a questa nuova fase si lega anche un più complesso gioco geopolitico che coinvolge anche attori extraregionali.
Almeno dal 2018, il sovrano marocchino propone la tesi che il Fronte Polisario sia stato sostenuto dalla Repubblica Islamica dell’Iran. Ad onor del vero, pur presentando alcune caratteristiche che storicamente hanno caratterizzato operazioni di penetrazione iraniana in altri contesti (confini porosi, evidente oppressione di una minoranza etnica e/o religiosa), come sostenuto anche dai servizi segreti britannici, non vi è alcuna prova concreta che dimostri una reale influenza iraniana tra le fila del Polisario o nell’area di Tindouf. Anche se rimane probabile che alcuni suoi membri, recatisi a combattere in Siria in sostegno di Bashar al-Assad, abbiano ottenuto addestramento militare da miliziani di Hezbollah. Dopotutto, quello dello spauracchio iraniano è un vecchio stratagemma utilizzato dai governi arabi (monarchici o repubblicani) per ottenere maggiori aiuti economici e sostegno militare dagli USA e dall’Occidente più in generale. Si pensi al caso emblematico del fu presidente yemenita Saleh che, a questo scopo, nel primo decennio del XXI secolo, denunciò un sostegno iraniano ai ribelli Houthi che, tuttavia, può essere considerato reale solo a partire dal 2011 ed effettivo solo dal 2014 in poi.
Non stupisce, inoltre, il fatto che a rilanciare tali “notizie” sia stata la nordamericana Foundations for Defense of Democracies (FDD). Questa altro non è che un “Think Tank” neocon con sede a Washington e fondato nel 2001 con il nome ebraico “Emet” (verità). Ha avuto un ruolo di primo piano nel sostenere la destabilizzazione della Siria e la sua struttura organizzativa prevede un “Programma Cina” ed un “Programma Iran”. Il primo è rivolto al contrasto delle attività del Partito comunista cinese in ambito economico, tecnologico e militare. Nel 2023, una delegazione della FDD si è recata a Taiwan per discutere sulla necessità di una strategia di guerra asimmetrica contro la Cina. Il secondo, invece, è rivolto a garantire sostegno al cambio di regime in Iran e ad indicare le aree nelle quali la la Repubblica Islamica potrebbe rappresentare una potenziale minaccia per gli interessi di USA e Israele nella più ampia area MENA (Medio Oriente e Africa del Nord). Tra i principali finanziatori della FDD figurano la famiglia Arnall, legata alla setta ebraica Chabad Lubavitch (vicina anche alla famiglia Kushner-Trump), Bernard Marcus (deceduto nel 2020 ed a lungo sostenitore di Elnet, la lobby sionista in Europa) e la famiglia Abramson, con interessi nel settore farmaceutico, che ha dato il nome al “Centro per la Vita Ebraica Madlyn e Leonard Abramson”.
Al contrario, sarebbe opportuno stigmatizzare ben altri tipi di penetrazione all’interno del Polisario. Uno dei suoi membri più influenti, ad esempio, Adnan Abu al-Walid al-Sahrawi, si è unito al sedicente Stato Islamico del Sahel: organizzazione terroristica e criminale al centro dei traffici regionali (droga, armi, esseri umani) responsabile, insieme ad altri gruppi (anche legati ad al-Qaeda) di una nuova destabilizzazione dell’area saheliana e delle crescenti tensioni tra Mali e Algeria. Non solo, queste tensioni si stanno ripercuotendo anche nelle storiche ottime relazioni tra Algeria e Russia, sempre più legata alla “cintura dei colpi di Stato” (Mali, Niger, Burkina Faso) e che, recentemente, ha migliorato i suoi rapporti con il Marocco attraverso importanti accordi commerciali (soprattutto in campo agricolo e di pesca). Con i mezzi di informazioni di Mosca che sono addirittura arrivati ad accusare apertamente Algeri di voler prolungare inutilmente la questione del Sahara Occidentale per una controproducente destabilizzazione di Rabat.
In un contesto di notevole espansione e crescita di influenza russa e cinese (e sotto certi aspetti pure iraniana) nella regione del Sahel ed in quella subsahariana, con il potenziale di raggiungere la costa atlantica dell’Africa, appare chiaro che uno degli obiettivi primari dell’Occidente possa rimanere quello di una destabilizzazione più o meno controllata che comunque impedisca il pieno sfruttamento di riserve minerarie fondamentali tanto per il mercato dei fertilizzanti (si vedano gli accordi russo-marocchini), quanto per quello dei semiconduttori (sempre più importanti per l’industria tecnologica).