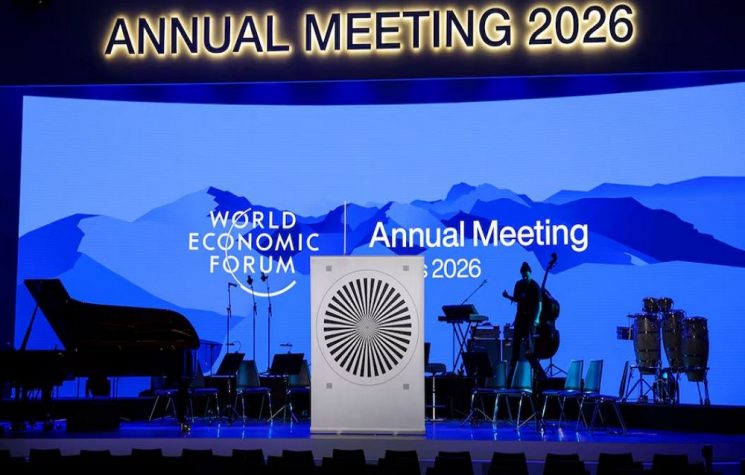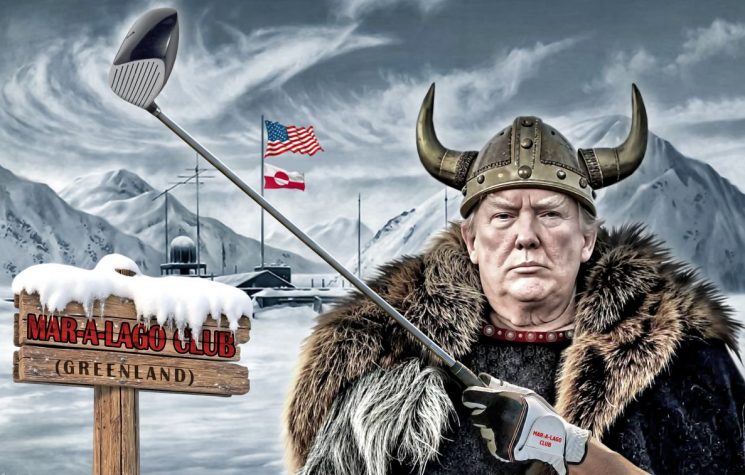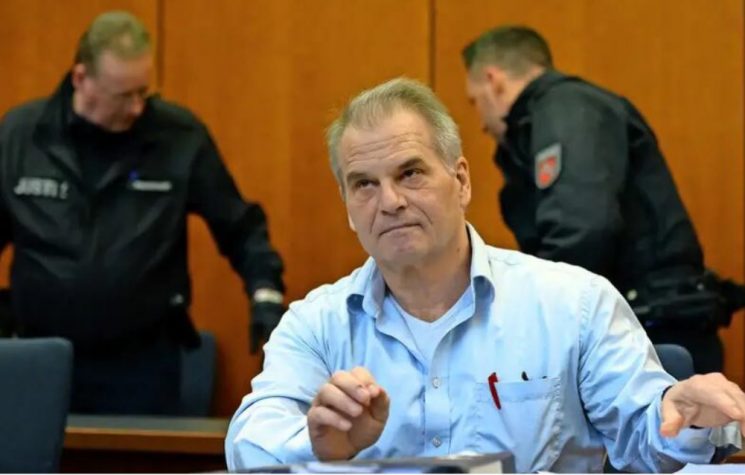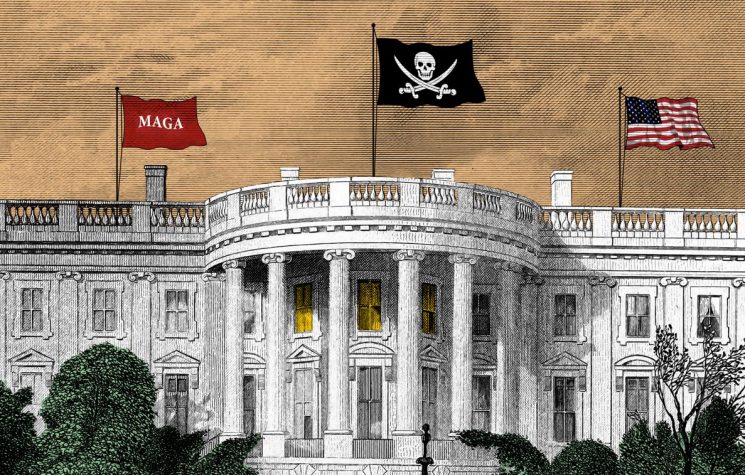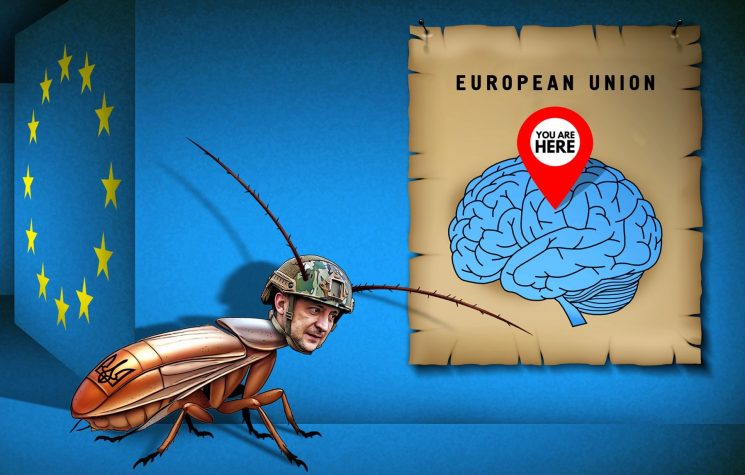Un solo voto. Uno solo è bastato per salvare Ilaria Salis dal carcere. Non sapremo mai se quel voto era vero oppure no, o quanto di questo bieco teatrino era già concordato sottobanco. Sappiamo però che, ancora una volta, il buon senso è stato seppellito sotto una montagna di ideologici interessi.
Un solo voto. Uno solo è bastato per salvare Ilaria Salis dal carcere. Non sapremo mai se quel voto era vero oppure no, o quanto di questo bieco teatrino era già concordato sottobanco. Sappiamo però che, ancora una volta, il buon senso è stato seppellito sotto una montagna di ideologici interessi.
La deliberazione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2025, con la quale l’Aula ha confermato l’immunità parlamentare di Ilaria Salis con un solo voto di margine (306 favorevoli, 305 contrari, 17 astenuti), costituisce un episodio che genera più interrogativi che certezze. Di fronte alla richiesta dell’Ungheria di revocare l’immunità per consentire l’avvio del procedimento penale nei confronti della deputata, l’Eurocamera ha scelto di sottrarsi alla competenza della giurisdizione nazionale, adottando una linea che rischia di indebolire sia la certezza del diritto sia il principio della responsabilità individuale.
Il Parlamento ha infatti optato per una soluzione che non salvaguarda l’equilibrio tra immunità e giustizia, ma lo compromette, convertendo un istituto nato per garantire la libertà del mandato parlamentare in uno strumento di protezione personale, pericolosamente vicino all’idea di impunità. L’immunità non rappresenta un valore autonomo, bensì un mezzo finalizzato a garantire il libero esercizio delle funzioni rappresentative. Il Protocollo n. 7 ai Trattati, agli articoli 8 e 9, delinea una tutela limitata: insindacabilità per voti e opinioni e protezione aggiuntiva solo quando i fatti contestati risultino strettamente connessi all’attività parlamentare.
Il Parlamento ha deliberato senza chiarire se esistesse realmente un nesso funzionale tra le condotte imputate a Salis e il suo mandato. In assenza di tale verifica, la decisione dell’Aula rischia di apparire come un atto politico volto a tutelare una propria esponente, più che un provvedimento rispettoso dei vincoli giuridici. Ed è proprio in questo spazio che si colloca la possibile iniziativa dell’Ungheria. L’articolo 263 del TFUE consente infatti il ricorso per annullamento davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea: ogni Stato membro che si ritenga danneggiato da un atto di un’istituzione può chiederne la cancellazione per incompetenza, violazione dei Trattati, abuso di potere o eccesso di discrezionalità.
La giurisprudenza della Corte ha già stabilito che le decisioni del Parlamento in materia di immunità costituiscono atti soggetti a controllo di legittimità, perciò l’Ungheria potrebbe strutturare il proprio ricorso, seppur con una certa sconvenienza politica a farlo. È vero che la Corte non sostituirà il proprio giudizio a quello politico del Parlamento, ma potrà annullare la decisione se rileverà che il margine di discrezionalità è stato oltrepassato o che il Protocollo è stato applicato in modo improprio.
L’intera vicenda evidenzia una tendenza preoccupante: l’Unione europea, nata come comunità fondata sul diritto, sembra scivolare verso un modello in cui l’immunità diventa non più un’eccezione funzionale, ma una protezione personale accordata in base alla convenienza politica. Così si incrina la fiducia degli Stati membri nel rispetto delle regole comuni e si introduce un elemento di arbitrarietà incompatibile con il principio dell’uguaglianza di fronte alla legge.
Ma c’è di più. Con la decisione di mantenere l’immunità parlamentare, il Parlamento europeo ha di fatto certificato che l’Ungheria non è più considerata uno Stato di diritto. In base a tale premessa, per coerenza istituzionale, l’Unione europea dovrebbe procedere alla sua espulsione, e la Commissione Prodi, che nel 2004 ne promosse l’ingresso, dovrebbe riconoscere l’errore di valutazione. Un errore che non riguarda soltanto Budapest, ma anche altri otto Paesi entrati nello stesso allargamento: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Cechia, Slovacchia e Slovenia.
L’espansione a Est, avvenuta con leggerezza e spirito quasi propagandistico, ha prodotto squilibri che oggi si riflettono sulla stabilità politica e strategica dell’Unione. Il motto ironico “più gente entra, più spettacolo si vede” può sintetizzare gli effetti di quella scelta, che continua a generare conseguenze gravi — inclusa la crescente spinta verso un conflitto mondiale non certo alimentato da Budapest (che anzi tenta di opporvisi), ma da Polonia e Paesi baltici.
Questi ultimi — Estonia, Lettonia e Lituania — contano complessivamente poco più degli abitanti di Roma, e tuttavia detengono ruoli di rilievo nei vertici europei: il commissario all’Economia (Dombrovskis), la responsabile per gli Affari esteri (Kallas) e il presidente della commissione Difesa (Kubilius). La Polonia, dal canto suo, controlla il Bilancio dell’Unione (Serafin). Non passa giorno senza che da questi Paesi giungano nuove accuse di presunti attacchi russi, spesso coordinate con Kiev, al fine di giustificare un’escalation militare e il continuo riarmo, riaprendo al contempo antichi contenziosi geopolitici.
L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha recentemente ricordato le responsabilità di baltici e polacchi nell’aver interrotto il dialogo tra Unione europea e Russia, fino a favorire l’attuale scenario di guerra in Ucraina. Gli stessi governi baltici, insieme a Polonia e Ucraina, si erano opposti alla costruzione dei gasdotti Nord Stream, che fornivano gas russo a basso costo all’Europa occidentale, sostenendone la competitività e la crescita economica. Quando un gruppo di sabotatori distrusse quelle infrastrutture, il primo a commentare con entusiasmo fu l’allora ministro degli Esteri polacco Sikorski, con un eloquente “Thank you USA!”, dimenticando di coordinarsi con Kiev, che nel frattempo attribuiva l’attentato a Mosca.
Nonostante tali evidenze, il premier polacco Donald Tusk ha dichiarato che “il vero problema del Nord Stream non è la sua distruzione, ma la sua costruzione”. Resta da vedere se il leader tedesco Merz avrà il coraggio di replicare, considerando che la Germania è ancora in ginocchio anche a causa di quell’attentato.