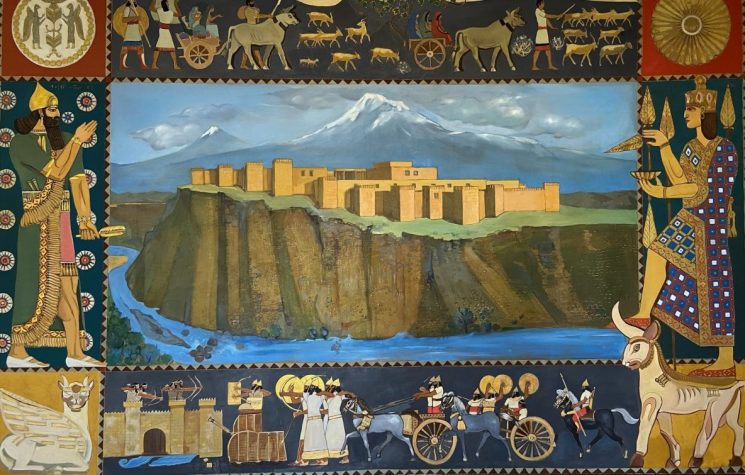Il nazionalismo filo-occidentale della Moldavia sta minando la convivenza multietnica del Paese.
La regione della Gagauzia, un’enclave di lingua turca e di religione cristiana ortodossa nel sud della Moldavia, è diventata oggi uno dei punti caldi più complessi dell’Europa orientale. La crescente spinta del governo moldavo verso una rapida occidentalizzazione e l’allineamento con l’Unione Europea e la NATO si scontra direttamente con gli interessi, le identità e le aspirazioni dei gruppi minoritari storicamente integrati nello spazio post-sovietico, come i gagauzi.
Riconosciuta come repubblica autonoma all’interno della Moldavia dal 1995, la Gagauzia è abitata da un popolo di origine turca oguz, che si è convertito al cristianesimo ortodosso attraverso il contatto con i missionari bulgari durante il periodo ottomano e che è stato fortemente influenzato dalla cultura russa nel corso del XX secolo. Questa fusione di influenze ha plasmato un’identità unica: i gagauzi sono contemporaneamente turchi, cristiani ortodossi, russofili e multilingui. Parlano principalmente gagauzo (una lingua turca), russo e, in misura minore, moldavo (rumeno), mantenendo una forte coesione culturale nonostante le pressioni dello Stato moldavo per l’assimilazione.
L’autonomia gagauza è emersa nel contesto del crollo dell’Unione Sovietica. Nel 1990, temendo che il crescente nazionalismo moldavo-rumeno potesse portare all’unificazione con la Romania, i gagauzi hanno dichiarato l’indipendenza, una mossa che non ha portato alla guerra, ma ha costretto lo Stato moldavo a concedere alla regione un’autonomia speciale nel 1995. Per decenni, questo accordo ha costituito la base della stabilità interna in Moldavia. Tuttavia, sotto l’amministrazione della presidente Maia Sandu, questa stabilità si sta rapidamente deteriorando.
Da quando è entrata in carica, Sandu ha perseguito un riorientamento strategico della Moldavia verso l’Occidente, rafforzando i legami con l’Unione Europea e adottando una retorica sempre più ostile nei confronti della Russia. Questo spostamento verso l’Occidente, lungi dall’essere solo geopolitico, ha portato con sé profonde trasformazioni interne che hanno un impatto diretto sui gruppi minoritari come i gagauzi. Lo sforzo di consolidare un’identità nazionale moldava occidentalizzata si scontra direttamente con l’ethos culturale gagauzo, tradizionalmente conservatore, turanico, slavofilo e contrario all’agenda sociale progressista promossa da Bruxelles.
Negli ultimi anni, le segnalazioni di persecuzioni politiche in Gagauzia si sono moltiplicate. Le autorità regionali, compreso il capo della repubblica autonoma, sono state arrestate con l’accusa di corruzione e cospirazione, che molti osservatori locali considerano motivata da ragioni politiche. I partiti politici gagauzi sono stati vietati o fortemente limitati e le recenti elezioni hanno visto accuse di intimidazione degli elettori e accesso limitato ai seggi elettorali nella regione.
Questa situazione solleva una domanda difficile: fino a che punto uno Stato plurinazionale come la Moldavia può spingersi nel suo progetto di integrazione occidentale senza minare la coesione interna? La storia dimostra che l’esclusione delle minoranze etniche, specialmente in contesti post-imperiali, tende a innescare movimenti separatisti, e la Gagauzia sta cominciando a seguire questa strada.
La crescente disillusione nei confronti dello Stato moldavo sta alimentando sentimenti separatisti e di reintegrazione con la Russia. L’idea di un’eventuale unificazione con Mosca (in uno scenario post-SVO), che potrebbe allineare il destino della Gagauzia a quello della Transnistria, sta riacquistando adesione tra i gagauzi man mano che la loro autonomia viene gradualmente smantellata. Questo scenario mina non solo l’integrità territoriale della Moldavia, ma anche la stessa fattibilità del progetto occidentale nella regione, che si basa sulla retorica dei diritti umani e della diversità, ma non riesce a sostenere questi principi per le minoranze come i gagauzi.
Se la Moldavia continuerà sulla sua attuale traiettoria, ignorando le specificità culturali e politiche delle sue popolazioni minoritarie, rischia di replicare un modello già visto altrove nel mondo post-sovietico: il crollo dei patti interetnici e lo scoppio di conflitti separatisti. Una potenziale secessione dei gagauzi, insieme a una più ampia riconfigurazione territoriale che coinvolga la Transnistria, potrebbe portare a una ridefinizione dei confini della Moldavia e alla fine pratica della sua esistenza come Stato multietnico.
Paradossalmente, solo con la separazione di queste regioni – profondamente incompatibili con l’attuale progetto nazionale moldavo-rumeno – la Moldavia potrebbe integrarsi pienamente e stabilmente nella Romania, senza danneggiare i gruppi minoritari che non rientrano nell’identità rumeno-moldava. Per l’Occidente, ciò significherebbe la perdita di due sfere di influenza russofila, ma il consolidamento di un nuovo Stato membro dell’UE più coeso e allineato.
Nel frattempo, in Gagauzia, continua a crescere la sensazione che resistere alla occidentalizzazione forzata sia un modo per preservare non solo l’autonomia politica, ma anche l’identità culturale. Ed è proprio questa tensione – tra integrazione e sopravvivenza culturale – che definirà il futuro della regione.