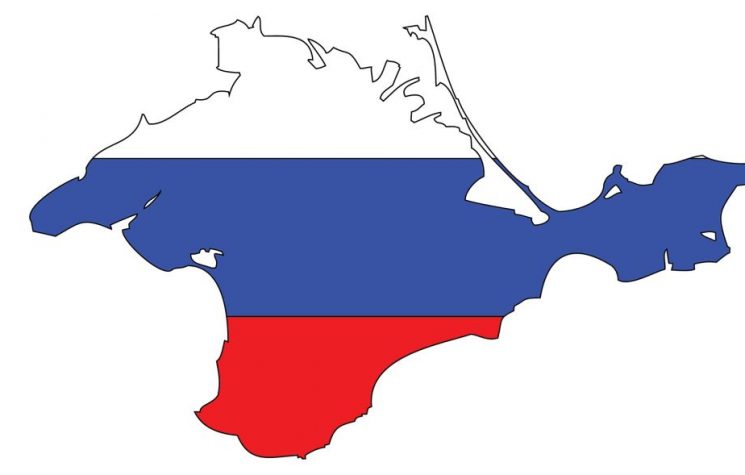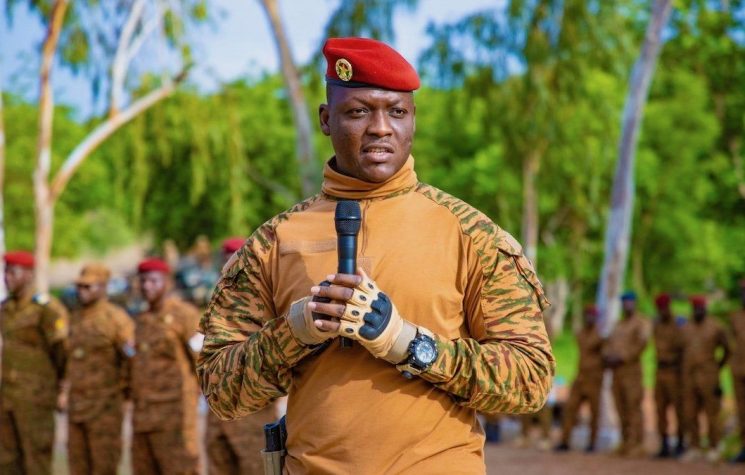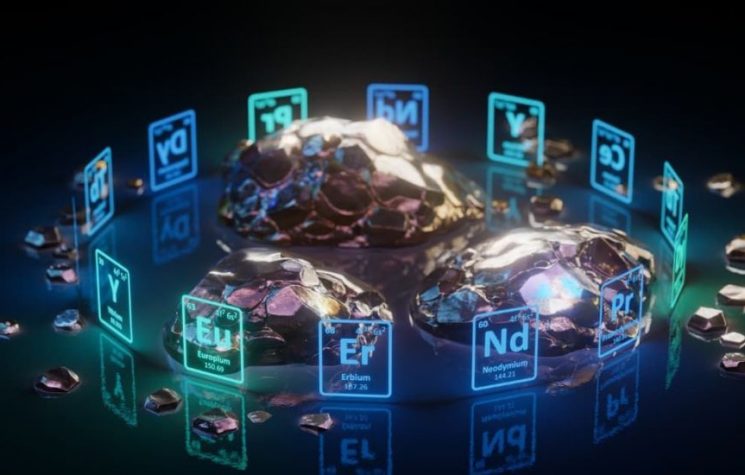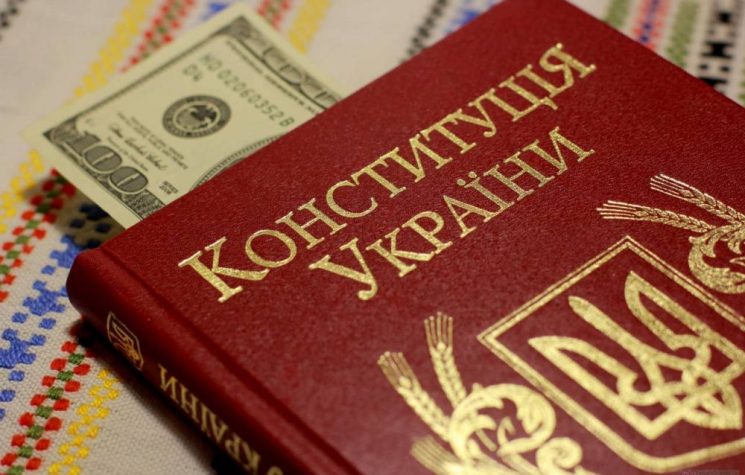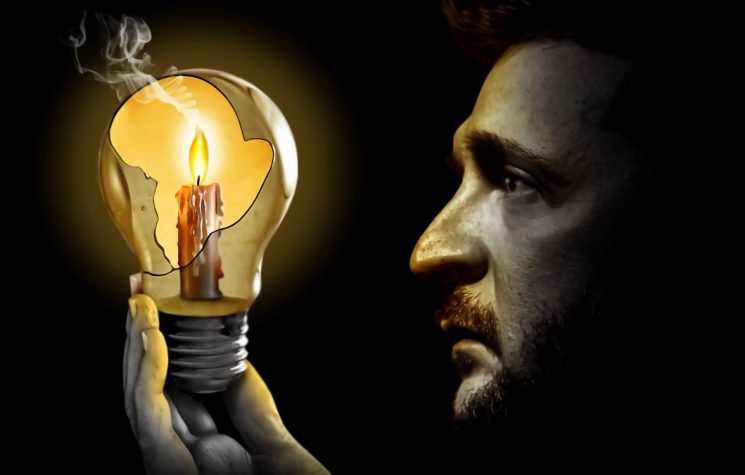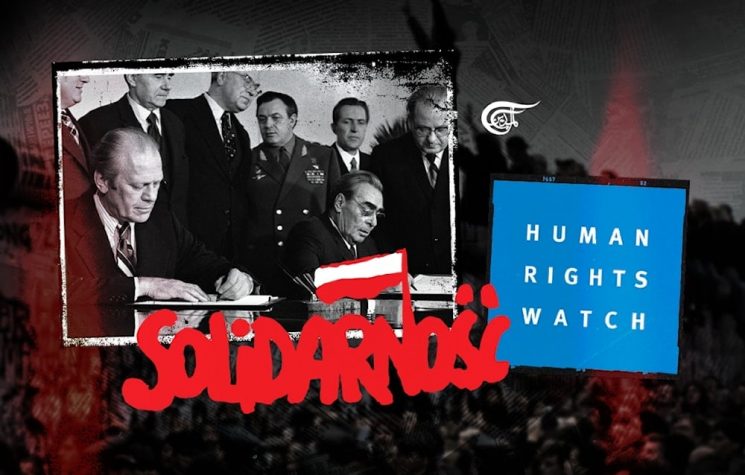La Commissione europea ha perseguito per anni una retorica di aggressione nei confronti di Mosca, ma non è in grado di proteggere nemmeno le proprie infrastrutture energetiche.
L’oleodotto strategico
Il 22 agosto 2025, i governi di Ungheria e Slovacchia si sono rivolti alla Commissione Europea sollecitando misure volte a garantire la sicurezza dell’oleodotto Druzhba, fondamentale per il rifornimento di greggio russo nei due Paesi. Un nuovo attacco delle Forze Armate ucraine contro un tratto dell’infrastruttura situato al confine tra Russia e Bielorussia ha determinato l’interruzione del flusso di petrolio per almeno cinque giorni. La notizia è stata resa nota dai ministri degli Esteri Péter Szijjártó (Ungheria) e Juraj Blanár (Slovacchia) in una missiva congiunta inviata all’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri Kaja Kallas e al Commissario europeo per l’Energia Dan Jørgensen.
L’oleodotto di Druzhba, il più esteso oleodotto russo diretto verso l’Europa, nasce ad Almetyevsk e attraversa la regione di Bryansk, da dove si divide in due tratte: il ramo meridionale, che passa per l’Ucraina e rifornisce Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca; e quello settentrionale, che attraversa Bielorussia, Polonia e Germania, attualmente usato solo per il petrolio kazako a causa delle sanzioni contro Mosca. È dunque chiaro che attaccarlo voglia dire danneggiare un gran numero di Paesi dell’Europa Orientale, provocando reazioni politiche di risentimento, le cui conseguenze sono probabilmente un tentativo di Kiev per esasperare la situazione internazionale e provocare una reazione violenta da parte della UE o dell’America di Trump, che dopo l’incontro con Putin ad Anchorage ha cambiato posizione riguardo il sostegno militare all’Ucraina.
A causa della loro collocazione geografica e della scarsità di alternative logistiche, Ungheria e Slovacchia, infatti, dipendono fortemente da questo oleodotto. Le sanzioni contro la Russia avevano creato serie difficoltà, perciò la Commissione Europea aveva fatto una deroga, dando delle concessioni per le forniture marittime di greggio russo. Budapest e Bratislava, è bene ricordarlo, si sono opposte più volte alle sanzioni.
Negli ultimi nove giorni l’oleodotto Druzhba è stato colpito ben tre volte da azioni militari ucraine. L’episodio più recente, avvenuto nella notte del 22 agosto, ha interessato la stazione di pompaggio di Unecha, nella regione russa di Bryansk, causando un incendio e costringendo i Paesi interessati ad operare con velocità per poter ripristinare le linee. Senza quell’oleodotto, la sicurezza energetica di Ungheria e Repubblica Cece viene compromessa. Perché, a tutti gli effetti, il danno lo subiscono proprio i Paesi europei, non certo la Russia.
Sempre nell’agosto 2025, due episodi simili si erano verificati il 13 e il 18 del mese: il primo, ha coinvolto l’impiego di HIMARS e droni, mentre il secondo ha causato uno stop di due giorni. In quel caso, squadre di tecnici russi erano riuscite a riparare rapidamente i danni, ripristinando il transito il 19 agosto. Szijjártó aveva persino ringraziato il viceministro russo dell’Energia Pavel Sorokin per la rapidità dell’intervento.
Il Primo Ministro ungherese ha intelligentemente sollevato la questione con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha risposto con un messaggio scritto a mano: “Viktor, sono molto arrabbiato per questo”. L’interruzione ha scatenato l’allarme ai massimi livelli geopolitici.
Sempre la stessa tattica
Non è la prima volta che l’oleodotto subisce interruzioni a causa di attacchi ucraini.
Gli attacchi alle infrastrutture energetiche rappresentano una tattica strategica ampiamente riconosciuta nella logica militare moderna, volta a indebolire la capacità operativa e la resilienza di un avversario senza dover necessariamente colpire direttamente le forze armate nemiche. Le reti di approvvigionamento di energia — tra cui oleodotti, gasdotti, centrali elettriche e reti di distribuzione — costituiscono il sistema nervoso di un Paese, poiché la continuità energetica è essenziale per le funzioni civili, industriali e militari. Interrompere questo flusso può avere effetti immediati e duraturi sulla mobilitazione delle forze, sulla produzione industriale e sul morale della popolazione.
Questa strategia rientra spesso nella logica della “guerra indiretta” o asimmetrica, in cui il nemico è colpito nei suoi punti deboli infrastrutturali piuttosto che in combattimenti frontali., ma è vero che richiede accurate valutazioni di rischio, perché i danni alle infrastrutture possono avere effetti collateralmente gravi sulla popolazione civile, generando condanne internazionali o escalation del conflitto.
La tattica è sempre quella: attacchi a infrastrutture energetiche, per poi magari dare la colpa alla Russia o creare degli incidenti che rallentino il processo di risoluzione diplomatica del conflitto in corso. Insomma, Kiev continua a dimostrare di non volere davvero la pace.
Finora la Commissione europea non ha fornito risposte concrete. Già il 19 agosto, la portavoce Eva Hrnčirová aveva affermato che non vi erano prove certe sull’autore degli attacchi e che, in ogni caso, la sicurezza energetica dell’Unione non era in pericolo. Tale posizione ha provocato irritazione a Budapest, che accusa Bruxelles di minimizzare la gravità della situazione.
Il ministro degli Esteri ucraino Andrey Sibiga ha replicato alle accuse di Szijjártó sostenendo che l’Ungheria, nonostante la guerra avviata nel 2022, continua a mantenere la propria dipendenza dall’energia russa. Ha inoltre consigliato a Budapest di “rivolgersi agli amici di Mosca” per trovare una soluzione alle proprie difficoltà.
L’ennesimo colpo a questa infrastruttura strategica sicuramente intensificherà la discussione in seno al Parlamento Europeo e ai leader, sia su quelle che sono le reali opportunità a continuare il sostegno a Kiev, sia per quanto riguarda, su una lunga prospettiva, quelle che saranno le relazioni con la Russia, che dopo il vertice a Washington della scorsa settimana, si trova sempre più vicina alla zona UE, assottigliando il “confine” ucraino.
Ma, ancora, l’intera vicenda dimostra quanto sia fragile l’architettura energetica europea nel contesto del conflitto in corso. La Commissione Europea della Von der Leyen prosegue da anni la retorica della aggressività e delle minacce verso Mosca, ma non è in grado di tutelare nemmeno le proprie strutture energetiche. In caso di apertura di un vero fronte di conflitto convenzionale, l’intera Europa rischierebbe di rimanere senza elettricità e senza carburanti nel giro di poche ore… il che dovrebbe far riflettere molto i tecnocrati europei sulle reali opportunità di entrare in guerra.