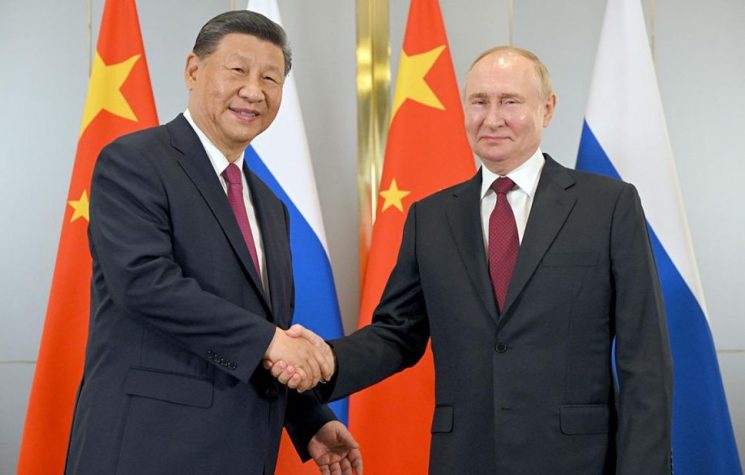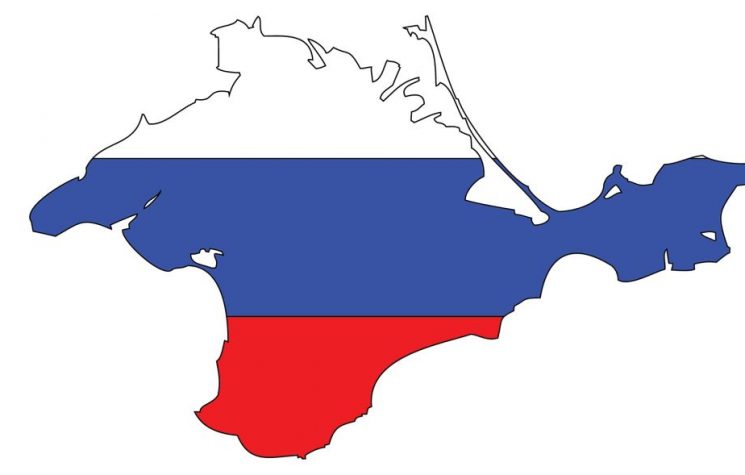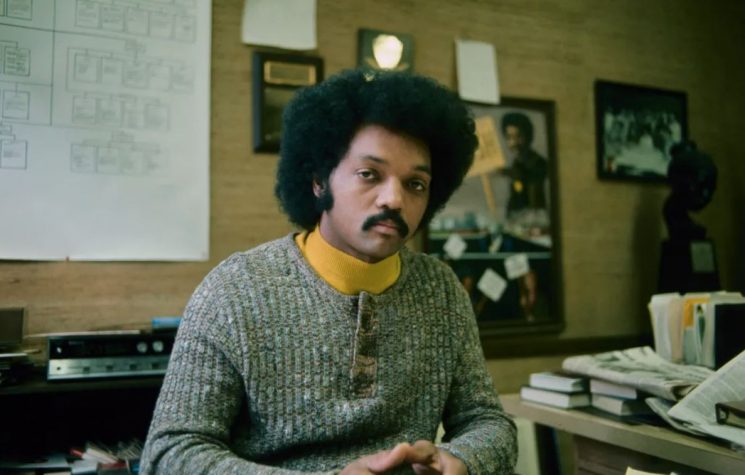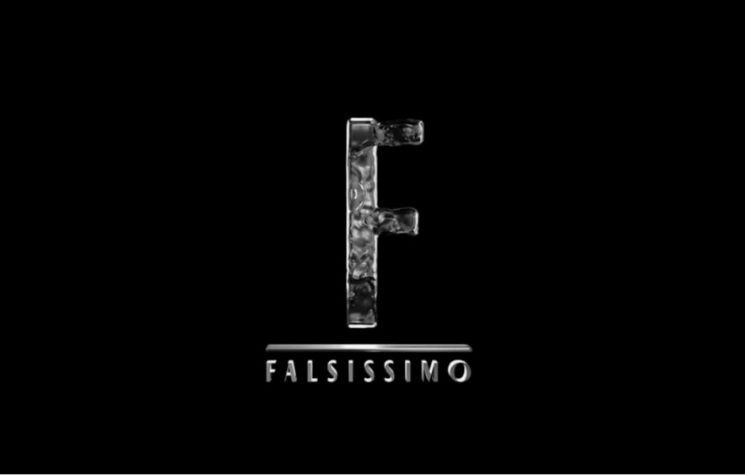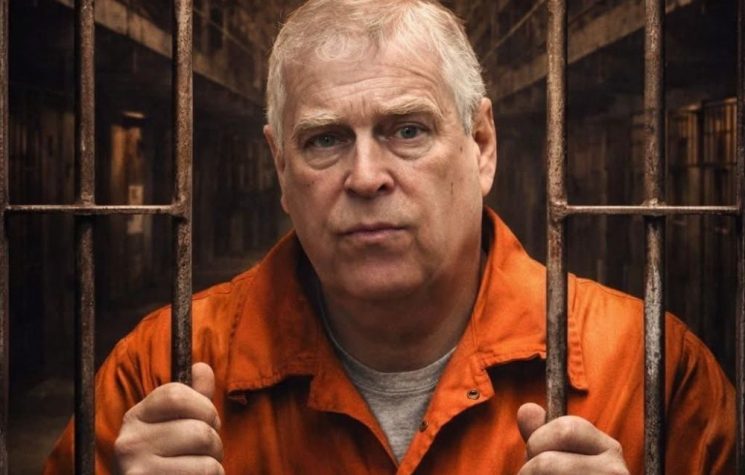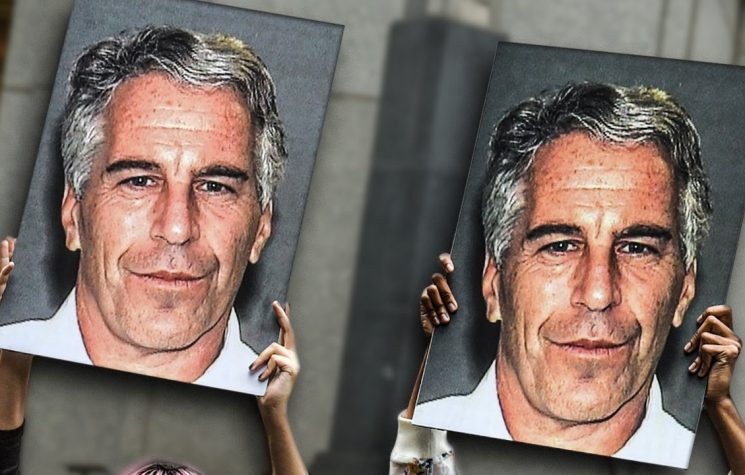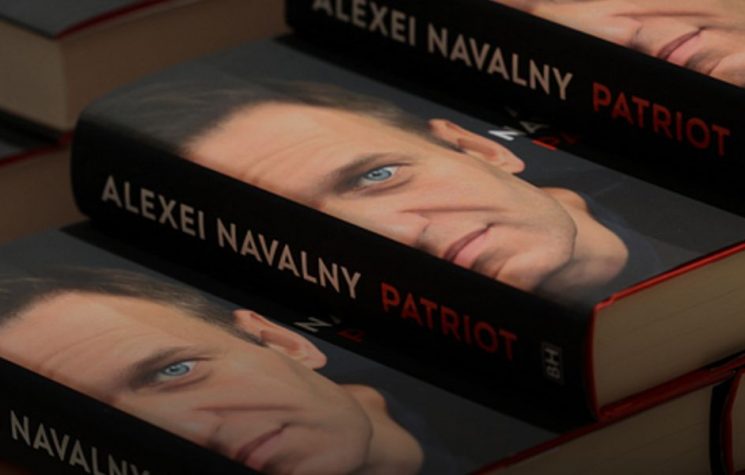Come il cinema diventa un’arma nelle mani delle élite che vogliono la guerra.
In questi tempi in cui in Occidente l’antifascismo è diventato una confusa lotta per l’affermazione di svariati e poco comprensibili generi sessuali, vien quasi da commuoversi a pensare che nel 1963 in Italia si sia realizzato non lontano da Torino a Grugliasco un convegno di registi e critici cinematografici sullo stato dell’arte del cinema antifascista nei primi diciotto anni dopo la Liberazione e le sue prospettive future.
Intanto, leggendo gli atti del convegno, si scopre che l’idea di antifascismo che avevano questi valenti protagonisti della cultura italiana del secondo Novecento è la stessa di un cittadino russo di oggi, concordando anche sulla necessità di una memoria che fosse in passato e sia nel presente capace di mantenere vivo il ricordo di donne e uomini che si sono battuti contro il brutale e assassino nazifascismo, massimamente i sovietici, che hanno avuto ventisette milioni di caduti tra soldatesse e soldati dell’Armata Rossa, civili e partigiani, di cui anche purtroppo tre milioni annientati nei campi di sterminio hitleriani.
Il convegno del 1963 è aperto da Gianni Rondolino, critico e professore di storia del cinema, il quale tiene una lunga relazione introduttiva in cui muove assai sferzanti critiche a molte delle pellicole acclamate in quel paio di decenni intercorsi dopo la Liberazione, ritenendole magari riuscite dal punto di vista tecnico, attoriale, emotivo, ma gravemente deboli dal punto di vista politico e culturale.
Leggere il suo, come molti dei successivi interventi di numerosi critici e registi, tutti volti a biasimare un certo estetismo travalicante il valore delle idee che si vogliono esprimere e trasmettere, è un tristissimo toccasana, da un lato infatti rallegra sapere che sia esistito un tempo in cui il valore qualitativo di un’opera cinematografica dipendeva dal suo grado di impegno sociale e politico, dall’altro porta grave amarezza constatare la totale depoliticizzazione del mondo della critica cinematografica occidentale odierna, la quale veicola dunque quasi esclusivamente pellicole culturalmente orientate a confermare il sistema liberal – liberista e atlantista, semplicemente scandagliandone i canoni estetici e dunque ripiegando verso un patetico servilismo nei confronti dei poteri dominanti.
Tra i più duri al convegno di allora Lino Del Fra che dirigerà “Antonio Gramsci – I giorni del carcere” nel 1977, capace di vincere il Pardo d’Oro al Festival del Cinema di Locarno, quando ancora portava anche la dizione “Internazionale”, oggi abolita. Per altro quel film in bianco e nero è di straordinario rigore tecnico, ma anche profondamente politico, certamente comunista ed emotivamente impattante, un film che proprio per la sua forza e la sua bellezza oggi nessun festival europeo selezionerebbe. Del Fra, riaffermando e ribadendo la necessità di un legame permanente tra intellettuali e classe lavoratrice, prendendo atto del fatto che l’Italia si stesse allora avviando verso un governo composto da democristiani di Aldo Moro e socialisti di Pietro Nenni, afferma con profonda precisione e chiarezza come vi sia un salto di paradigma rispetto al decennio precedente contrassegnato da una feroce azione governativa anticomunista e di conseguenza antirussa e antisovietica, vi sarebbero stati forse alcuni miglioramenti sociali, ma il regista manifestava tutta la sua forte preoccupazione – il tempo gli darà ragione – rispetto a un sistema di potere ed economico, che lui definisce “neocapitalista”, bene interessato alla promozione di un antifascismo generico, privo di una reale capacità di rendersi pensiero di lotta, un antifascismo tanto superficiale, quanto sostanzialmente innocuo e inutile.
Altrettanto netta ed esplicita la moglie di Lino Del Fra, Cecilia Mangini, la quale con lui e insieme anche a Lino Miccichè aveva firmato l’anno precedente, nel 1962 uno stupendo documentario montato con materiali d’archivio e bloccato dal governo democristiano per lunghi mesi prima d’essere distribuito nelle sale italiane, dal titolo “All’armi, siam fascisti!”, mezzo secolo di immagini di repertorio dal 1911 al 1961 dedicate al fascismo e alla sua tragica continuità nel secondo dopoguerra attraverso il Movimento Sociale Italiano. Ecco il passaggio saliente dell’intervento di Cecilia Mangini: “Lasciatemi dire che siamo stati veramente messi alle corde dai nostri avversari se ci accontentiamo di far gridolini di gioia per una Resistenza purchessia, acriticamente vista, ridotta ad un puro fondale scenografico.”
Le preoccupazioni di questi intellettuali hanno avuto forse un seguito nel quindicennio successivo, ma con gli anni ‘80 e peggio ancora con gli anni ‘90, l’onda lunga della fine del campo sovietico, il tramonto in tutta Europa di un pensiero culturale di massa fortemente indirizzato al marxismo, ha portato il mondo culturale nel suo complesso e quello cinematografico in particolare ad abbandonarsi alle peggiori derive esistenzialiste.
L’esito del 78° Locarno Film Festival ne è a tutti gli effetti una tristissima e formidabile conferma, si sono affastellate, con poche eccezioni, mediocri e modeste pellicole, quasi tutte segnate dal peggior individualismo sia relazionale, sia di genere, ovviamente sessuale, ed anche, secondo la moda, in molti casi alla ricerca di un genere scapestratamente quanto incredibilmente non ancora trovato. Quando in rari film si sono affrontati temi politici contingenti, ecco che tanto nei fotogrammi, quanto nei commenti, si è scaduti nel più bieco irenismo, appellandosi con vaghezza tutta occidentale a una fantasmagorica “libertà”, di fatto ristretta ai diritti civili individuali, il diritto dei popoli a non essere sfruttati dall’imperialismo, ad avere casa, scuola e lavoro, sono risultati temi quasi introvabili e comunque lontani dalle intenzioni degli organizzatori, quanto dei commentatori, pur con qualche lacrima imprescindibile, date le circostanze, per la tragedia palestinese. Assoluta eccezione il Pardo per la migliore regia assegnato all’eccellente documentario “Racconti dalla terra ferita” di Abbas Fahdel, girato interamente tra le bandiere e nei territori di Hezbollah nel cuore di quel Libano resistente, massacrato per mesi e mesi dalle bombe sioniste.
D’altronde è una specie di riflesso condizionato, da Cannes a Berlino, da Locarno a Venezia, i selezionatori paiono più interessati a far contento il segretario generale della NATO, piuttosto che il pubblico, il quale tuttavia è meno sprovveduto e meno assuefatto ai dogmi liberal – guerrafondai di quanto si immagini.
Tra i campioni di malevolenza possiamo annoverare il film “La pinna” del sudcoreano Syeyoung Park, il quale pur costruendo scenari post – apocalittici di grande impatto visivo, dominati da cieli infuocati e probabilmente radioattivi, costruisce un feroce e a tratti ridicolo film propagandistico totalmente diffamatorio verso la Corea Popolare, nella pellicola infatti la penisola è finalmente riunificata, ma le strade sono buie e sporche e la società profondamente ingiusta e violenta, brillano solo nelle oscure notti i cartelloni luminosi di carattere politico, ovviamente un evidente richiamo a quelli coreano – popolari, ma interpretati esclusivamente in modo negativo.
Per fortuna, nel mare vasto di decine e decine di film proposti, anche ai selezionatori capita di scegliere pellicole di qualità, volte ad allietare i fortunati, più o meno consapevoli, che si sono assiepati nelle sale.
È il caso nella sezione “Porte Aperte” del colorato, ma al contempo duro e toccante “Nome”, realizzato per Cannes nel 2023 del regista Sana Na N’Hada della Guinea Bissau, il quale, giovanissimo, insieme al coetaneo Flora Gomes, celebre per “Nha fala” del 2002, viene mandato da Amilcar Cabral, tra i più grandi rivoluzionari africani del Novecento e padre dell’indipendenza della Guinea Bissau e di Capo Verde, a Cuba alla fine degli anni ‘60 per studiare cinematografia, mentre lui voleva andare a Mosca a studiare medicina. Rientreranno i due appena in tempo nel 1972 per filmare gli ultimi discorsi pubblici di Cabral, prima che il salazarismo portoghese lo uccidesse nel gennaio 1973, innescando tuttavia quella convergente ribellione tra rivoluzionari africani e giovani lusitani contrari alla dittatura e alle guerre coloniali che porterà il 25 aprile 1974 alla Rivoluzione dei Garofani. La pellicola narra quasi nella forma di un corale canto collettivo per immagini, contrappuntato dai fotogrammi di repertorio dello stesso autore, la storia della Guinea Bissau, soffermandosi sugli anni decisivi per la lotta d’indipendenza dal brutale colonialismo fino al tempo successivo, ovvero la costruzione della nuova nazione sovrana e indipendente. Donne e uomini dai villaggi della savana alla capitale si impegnano per la costruzione di una nuova società che offra uguali opportunità per tutte e tutti, tuttavia con il tempo il profitto personale in alcuni militanti scalzerà il dovere di agire sempre al servizio della collettività.
All’interno della “Settimana della Critica”, pregevole “She” dell’antropologo e fotografo napoletano Parsifal Reparato, il quale si approccia alla vita di alcune operaie vietnamite tra le centomila che popolano una fabbrica digitale, con tutto l’indotto che questo grande agglomerato abitativo e lavorativo porta con sé, dal rifornimento di cibo alla parrucchiera, un documentario realizzato con un rispettoso distacco che non rinuncia alla comprensibile ammirazione per queste giovani figlie di una Rivoluzione, quella vietnamita, che oggi percorre il lungo cammino volto a trasformare il socialismo in un’occasione di maggiore benessere per tutte e tutti i suoi cittadini.
Il Concorso internazionale e i film della piazza Grande hanno brillato per modestia e propaganda, tuttavia, se il vincitore del Concorso internazionale è stato “Due stagioni, due sconosciuti”, opera oleografica ed esistenzialista del giapponese Sho Miyake, il Premio Speciale della Giuria è andato all’austriaca Elsa Kremser e al tedesco Levin Peter, i quali dopo aver proposto con “Cani spaziali” la migliore opera di Locarno 2019, hanno presentato “Lumaca bianca”, una pellicola pregevole per la fotografia rigorosa e al contempo seducente, con meravigliose inquadrature della capitale bielorussa e la voce inconfondibile dal televisore del presidente Aljaksandr Lukašėnka, girato in un’estate bielorussa dai cieli azzurri velati da qualche rara nuvoletta e dalle notti stellate, è la storia d’amore tra una ragazza che vorrebbe andare in Cina come modella, interpretata da Marya Imbro – di prorompente e silenziosa bellezza – e un giovane che lavora all’obitorio di Minsk, parte assolta da Mikhail Senkov, entrambi vincitori del Premio per la migliore interpretazione.
Una Menzione Speciale è stata attribuita a “Foglia secca” di Alexandre Koberidze, poetica elegia georgiana, piena di rimandi ai grandi registi di quella terra: Eldar Šengelaja, Otar Ioseliani, Sergej Paradžanov.
Infine restaurato e meritoriamente riproposto il Roberto Rossellini del cinema didattico, quello post – neorealista, con tutto il fascino severo delle parole misurate ed esplicite dentro una ricostruzione cinematografica seria e fedele, in questo caso “Anno uno” del 1974, dedicato all’azione politica del democristiano Alcide De Gasperi dal 1944 al 1954.