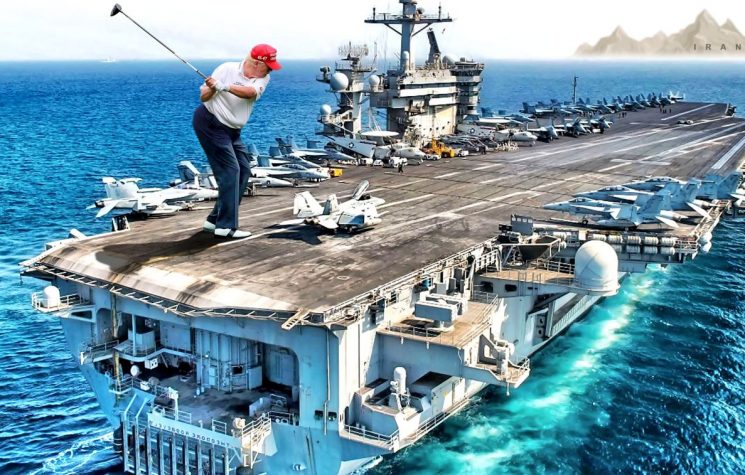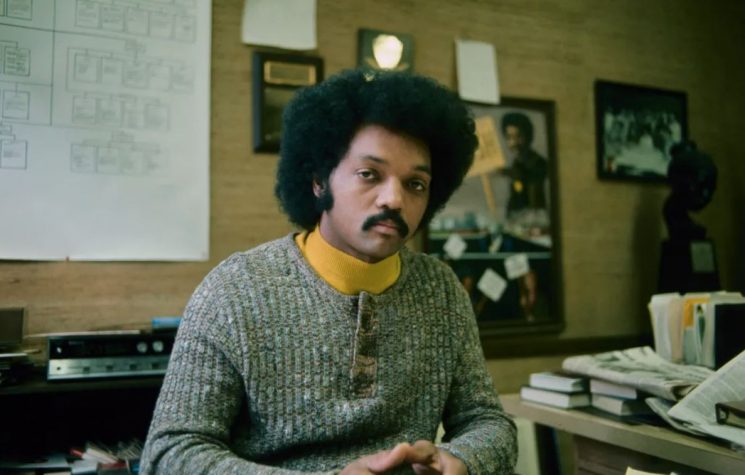Donald Trump ha annunciato la resa degli Houthi in Yemen, ma è vero?
Il presidente Donald Trump ha annunciato la conclusione delle operazioni militari statunitensi contro lo Yemen che si protraevano ormai da sette settimane, a seguito della “capitolazione” degli Houthi. Questa, per lo meno, è la ricostruzione formulata dall’inquilino della Casa Bianca, secondo cui il gruppo yemenita avrebbe assunto l’impegno a «non colpire più le navi nel Mar Rosso: questo era lo scopo del nostro lavoro». L’intesa è stata confermata dai mediatori omaniti, che hanno tuttavia fornito dettagli altamente significativi. L’accordo impedirebbe a entrambe le parti di prendersi reciprocamente di mira, vincolando così gli Houthi a garantire l’incolumità dei navigli statunitensi – e forse europei – in transito nelle acque del Mar Rosso e dello Stretto di di Bab al-Mandab come contropartita per la cessazione dei bombardamenti Usa.
L’intesa giunge in concomitanza con l’annuncio relativo alla ripresa dei negoziati tra Washington e Teheran incentrati sulla questione del nucleare iraniano, e nell’imminenza del tour diplomatico del presidente Trump nella penisola araba. Potrebbe quindi scaturire dalla volontà sia statunitense che iraniana di stemperare le tensioni in vista dei negoziati, in seguito alle uscite del segretario di Stato Marco Rubio secondo cui l’unica via a disposizione dell’Iran per scongiurare il conflitto consisterebbe nell’interruzione del sostegno agli Houthi, della costruzione di missili a lungo raggio e dell’arricchimento dell’uranio. Va tuttavia considerato che, come spiegato dall’esponente verticistico del Consiglio Politico Supremo degli Houthi Mahdi al-Mashat, l’intesa appena siglata con gli Stati Uniti non contempla alcuna cessazione delle attività militari dirette contro Israele, che nei giorni corsi è stato nuovamente colpito da un missile balistico yemenita. La specificazione di al-Mashat conferisce all’intesa appena raggiunta tra l’amministrazione Trump e gli Houthi un significato particolare, perché denota un evidente disallineamento tra gli interessi statunitensi e israeliani. Non a caso, ha rivelato il «Jerusalem Post» in base alle confidenze rese da un alto funzionario israeliano, la classe dirigente di Tel Aviv non era stata nemmeno informata dell’intesa.
Allo stesso tempo, sottolinea la rivista «The Atlantic», l’accordo «pone le basi per una tregua necessaria», dal momento che «la guerra contro gli Houthi rischiava di trasformarsi in una sorta di pantano. Sebbene i recenti attacchi americani abbiano arrecato qualche danno al gruppo yemenita, sono rimasti ben lontani dall’obiettivo dichiarato di “annientarlo completamente”. Gli Houthi rimarranno una notevole minaccia per l’intera regione, avendo dimostrato negli ultimi 18 mesi di poter interrompere a propria discrezione il traffico marittimo internazionale».
Secondo i dati riportati dal Dipartimento di Stato, da quando Israele ha scatenato l’Operazione Iron Swords nell’ottobre 2023, gli Houthi hanno sferrato 145 attacchi contro cargo commerciali statunitensi e 174 contro navigli della Us Navy. Il traffico attraverso il Canale di Suez è crollato del 60% circa, con conseguente allungamento dei tempi di consegna e incremento astronomico dei costi per le spedizioni. Come ha osservato Jennifer Kavanagh, ex analista della Rand Corporation, «la genialità della strategia adottata dagli Houthi risiede nel fatto che i loro missili non devono colpire nulla o causare danni ingenti per raggiungere l’obiettivo di interrompere il traffico marittimo attraverso il Mar Rosso. Il clima di incertezza così creato è risultato sufficiente a spingere la maggior parte delle compagnie di navigazione ad allontanarsi dalla regione». Per di più, «i droni e i missili che gli Houthi utilizzano sono spesso economici e abbastanza facili sia da ottenere che da nascondere nel sottosuolo, ma risultano molto costosi da contrastare per gli Stati Uniti. I droni nella disponibilità degli Houthi, ad esempio, possono costare appena 2.000 dollari, ma i missili che gli Stati Uniti impiegano contro di loro costano più di 2 milioni di dollari». Con tutti i contraccolpi del caso.
Secondo una stima riportata dalla «Cnn» sulla base di confidenze rese da tre anonimi funzionari di Washington addentro alla questione, le operazioni militari contro lo Yemen sostenute dagli Stati Uniti in appena tre settimane, foriere di risultati alquanto modesti, sarebbero costate circa un miliardo di dollari. L’offensiva, implicante l’impiego di missili da crociera Tomahawk e Jassm, bombe plananti a guida satellitare Jsow, bombardieri B-2 Spirit, una portaerei, diversi squadroni di caccia e sistemi di difesa aerea. Valutazioni dello stesso tenore sono state formulate, riporta il «New York Times», da funzionari del Pentagono, secondo cui «l’esercito statunitense ha conseguito risultati limitati» nella campagna militare contro lo Yemen. Inoltre, i vertici della Us Navy e la Marina e del Comando Indo-Pacifico sarebbero «molto preoccupati per la velocità con cui l’esercito sta consumando munizioni in Yemen».
Le operazioni statunitensi in Yemen avrebbero in altri termini impresso un’accelerazione decisiva al processo di erosione delle riserve strategiche di armi e munizioni statunitensi in corso quantomeno dallo scoppio del conflitto russo-ucraino. I dati indicano che l’Operazione Prosperity Guardian, lanciata dall’amministrazione Biden nel dicembre 2023 per contrastate l’attivismo degli Houthi, ha richiesto un consumo di missili e munizioni più intenso rispetto a quello sostenuto dagli Usa durante l’intera Seconda Guerra Mondiale. All’agosto 2024, gli Stati Uniti avevano lanciato contro lo Yemen 125 missili Tomahawk (costo: tra 1 e 2 milioni di dollari), pari al 3% delle riserve.
A gennaio, il viceammiraglio Brendan McLane ha spiegato che la flotta di superficie della Us Navy aveva esploso nell’ambito di Prosperity Guardian ben 120 missili Sm-2, 80 missili Sm-6, 160 munizioni da 12,5 cm e 20 missili Essm e Sm-3.
La campagna lanciata da Trump, rileva il «New York Times», ha intensificato l’impiego non solo dei Tomahawk, ma anche dei missili a corto raggio Agm-154 (costo: tra i 282.000 e i 719.000 dollari) e Agm-158 (costo: 698.000 dollari). Vettori, cioè, che vengono lanciati dagli F-18, cacciabombardieri da 60/70 milioni di dollari. Due di questi velivoli sono andati “perduti” nelle acque del Mar Rosso nel giro di pochissimi giorni. Se la distruzione del secondo aereo andrebbe ricondotta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici, l’inabissamento del primo sarebbe invece il risultato di una serie di manovre azzardate compiute dalla portaerei Uss Truman per sfuggire a un attacco sferrato dagli Houthi. La perdita degli F-18 va a sommarsi all’abbattimento di 21 droni Mq-9 Reaper (costo: 30 milioni di dollari), sempre ad opera degli Houthi.
Ne consegue che, considerata alla luce del rapporto costi/benefici, molto difficilmente la campagna militare in Yemen può configurarsi come un successo per Washington. Si è rivelata particolarmente impegnativa e gravida di magri risultati, come traspare dalle dichiarazioni formulate da Trump in persona in riferimento agli Houthi, i quali «hanno manifestato una grande capacità di resistere alle punizioni. Si può dire che hanno dimostrato molto coraggio. È stato incredibile quello che hanno sopportato. Ora onoriamo il loro impegno e la loro parola».
In buona sostanza, sostiene «The Atlantic», «gli Stati Uniti si sono ritirati dal conflitto senza porvi fine», onde evitare di intaccare le riserve di materiale bellico oltre la soglia critica. Molte delle munizioni impiegate nelle operazioni in Yemen, rileva Jim Fein della Heritage Foundation, «risulterebbero cruciali in una guerra contro la Cina […]. Gli Houthi rappresentano una minaccia relativamente piccola, meno avanzata e meno letale della Cina, eppure si sono dimostrati un problema persistente per gli Stati Uniti e i loro alleati. Se servono centinaia di missili per smorzare gli attacchi degli Houthi – con scarso successo – ce ne vorranno ancora di più per affrontare la minaccia cinese».