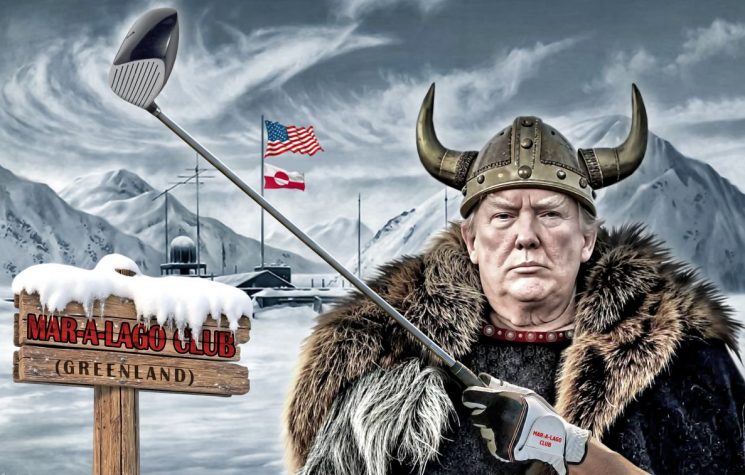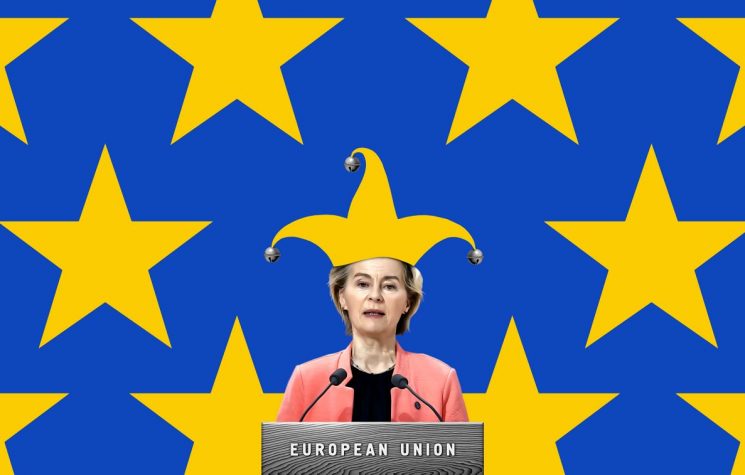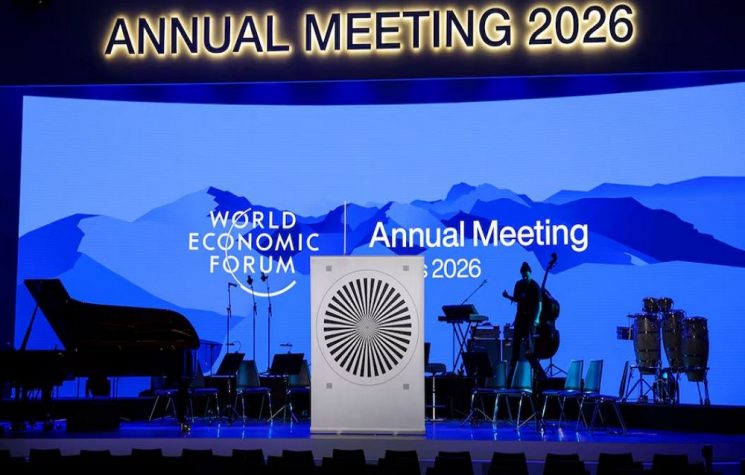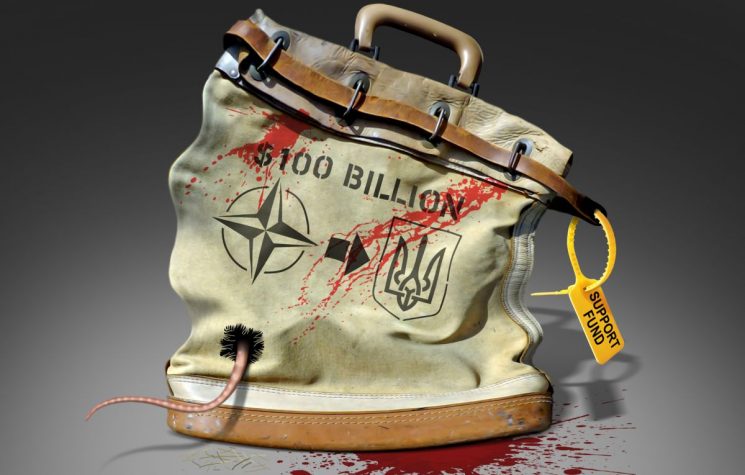Nei giorni scorsi, la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha annunciato ReArm Europe, un piano di riarmo su scala comunitaria da 800 miliardi di euro.
Nei giorni scorsi, la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha annunciato ReArm Europe, un piano di riarmo su scala comunitaria da 800 miliardi di euro entro un quadriennio inteso a costruire, alla luce del radicale riposizionamento degli Stati Uniti sotto l’egida dell’amministrazione Trump, una solida deterrenza a fronte del supposto “imperialismo russo”.
Il disegno, approvato dal Consiglio d’Europa, si basa sull’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 122 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e comporta per ciascuno Stato membro l’esonero delle spese militari dal Patto di Stabilità, che rimarrà invece in vigore rispetto a tutte le altre voci di bilancio. La Commissione Europea, dal canto suo, ha autorizzato i Paesi membri a riorientare a beneficio della difesa dei fondi di bilancio originariamente destinati al finanziamento di altri programmi, e annunciato per tramite della stessa Von der Leyen che «l’Europa ha tutto ciò che le serve per prendere il comando nella corsa alla competitività. Questo mese, la Commissione presenterà l’Unione del Risparmio e degli Investimenti. Trasformeremo i risparmi privati in investimenti necessari. E lavoreremo con i nostri partner istituzionali per farli decollare».
Mentre mette nel mirino il risparmio privato continentale, la Commissione Europea si impegna a raccogliere a condizioni agevolate sui mercati 150 degli 800 miliardi previsti dal piano da concedere sotto forma di prestiti ai singoli Stati. Per favorire il processo, la Banca Centrale Europea ha tagliato il tasso di interesse sui depositi al 2,5% in un’ottica di abbassamento del costo del debito. Lo scopo è quello di stimolare il sistema bancario a canalizzare liquidità verso il settore della difesa, su cui stanno convergendo i capitali in uscita dai comparti farmaceutico e hi-tech (con particolare riferimento ai segmenti riconducibili alla “transizione ecologica) sotto la regia dei grandi fondi d’investimento statunitensi – BlackRock, Vanguard e State Street in primis.
Alcune aziende come Rheinmetall, fiutata l’aria che tira, stanno procedendo alla conversione dei propri stabilimenti preposti alla fabbricazione di componenti automobilistiche in impianti “ibridi”, utilizzabili anche per la produzione bellica. Sebbene l’impatto su sanità, istruzione, ricerca, previdenza sia facilmente prevedibile, attorno a ReArm Europe si è sviluppato – con le dovute eccezioni – un consenso trasversale alle forze politiche, dietro il pungolo di personalità di vertice a livello istituzionale, giornalistico e universitario.
In pochissimi hanno peraltro richiamato l’attenzione sul fatto che, sebbene l’Unione Europea abbia destinato complessivamente al settore della difesa 457 miliardi di dollari contro i 145,9 riconducibili alla Russia (dati del 2024), quest’ultima, come denunciato a gennaio dal segretario generale della Nato Mark Rutte, «sforna in tre mesi il volume di materiale bellico che l’Alleanza Atlantica, da Los Angeles ad Ankara, è in grado di produrre nell’arco di un anno». Segno che ReArm Europe va ad imprimere una brusca accelerata a un processo di corsa agli armamenti preesistente.
Lo si evince dalla straordinaria crescita azionaria realizzata nel 2024 dai principali colossi europei della difesa, quali i tedeschi Rheinmetall (+114%) e Hensoldt (+41%), gli italiani Leonardo-Finmeccanica (+73%) e Fincantieri (+60%), lo svedese Saab (+53%) e il britannico Quinetiq (+34%). Stesso discorso vale per Thales e Bae Systems. Ne è scaturito un incremento vertiginoso dello Stoxx Europe Total Market Aerospace & Defense, che ha chiuso il 2024 con un margine positivo su base annua del 33,1%, contro il 26% totalizzato dal listino bancario e il 18,2% da quello assicurativo. Dai dati forniti dallo Stockholm International Peace Research Instute (Spiri) in relazione ai contratti già stipulati emerge inoltre che Francia, Germania e Italia hanno in portafoglio ordinativi assai imponenti di aerei da combattimento, navi da guerra, elicotteri, sistemi anti-aerei, carri armati e veicoli corazzati di vario genere. Rispetto al quinquennio precedente, Francia e Italia hanno migliorato significativamente la propria posizione sul mercato mondiale delle armi, con la prima che ha incrementato la propria quota del’11% (dall’8,6 al 9,6% del totale) e la seconda addirittura del 138% (dal 2 al 4,8%). I risultati negativi conseguiti da Germania (-2,6%, dal 5,7 al 5,6% del totale), Olanda (-36%, da 1,9 a 1,2% del totale), Svizzera (-61%, da 0,9 a 0,5% del totale) e Repubblica Ceca (-14%) sono stati ampiamente compensati dalle performance realizzate da Polonia (+4.031%, dallo 0,05 all’1%), Norvegia (+187%, da 0,3 a 0,8%), Svezia (+73%, da 0,5 a 0,9%) e Spagna (+29%, dal 2,3 al 3%).
Nel periodo interessato, il dominio degli Stati Uniti è andato consolidandosi (+21%, dal 35 al 43%) anche per effetto delle implicazioni dal conflitto-russo ucraino. La guerra ha prodotto un crollo della quota di mercato globale riconducibile alla Russia (-64%, dal 21 al 7,8% del totale), il cui sforzo bellico ha assorbito larghissima parte della produzione domestica, e trasformato allo stesso tempo l’Ucraina nel principale canale di ricezione di materiale bellico su scala mondiale (8,8% delle importazioni totali). Il trasferimento massiccio di attrezzature militari a Kiev ha naturalmente imposto ai Paesi europei di ricostituire – seppur molto parzialmente – le proprie scorte, in larghissima parte attraverso l’incremento degli acquisti dagli Stati Uniti. Rispetto al quinquennio precedente, l’import europeo di armi è aumentato del 155% e la quota di mercato del “vecchio continente” presidiata dagli Usa è cresciuta dal 52 al 64%. Così, per la prima volta da oltre vent’anni, l’Europa ha superato il Medio Oriente come destinazione primaria dell’export militare statunitense.
Le statistiche fornite dal Sipri sul punto dipingono tuttavia un quadro in larga parte antecedente alla corsa al riarmo scatenata dalla guerra in Ucraina, perché non conteggiano ancora i dati relativi agli ordinativi europei di sistemi d’arma complessi che i produttori statunitensi (Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grummann, General Dynamics, ecc.) sarà in grado di consegnare soltanto fra diversi anni. Lo ha sottolineato con forza il ricercatore del Sipri Pieter Wezeman, secondo cui «gli Stati europei della Nato hanno ordini per quasi 500 aerei da combattimento e molte altre tipologie d’arma dagli Stati Uniti», tra cui gli F-35 e i sistemi Patriot.
Così, il “vecchio continente” si appresta, contestualmente a ReArm Europe, a sacrificare il welfare e drenare risparmio privato a favore della difesa («trasformeremo i risparmi privati in investimenti necessari», come ha dichiarato la Von der Leyen) dopo aver superato per la prima volta da oltre vent’anni il Medio Oriente come destinazione primaria dell’export militare statunitense.