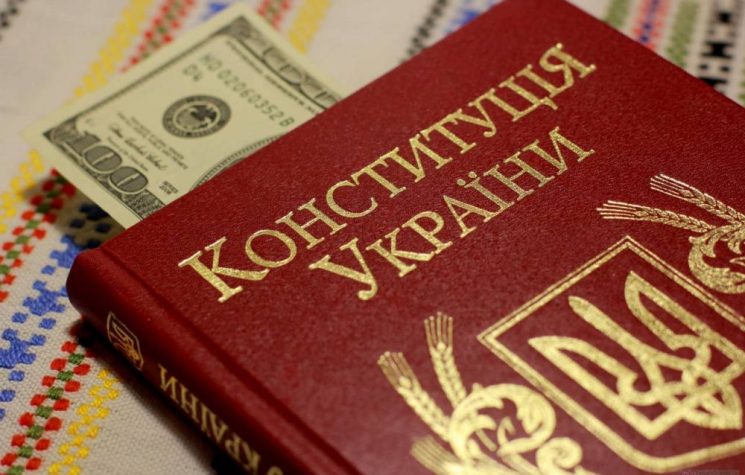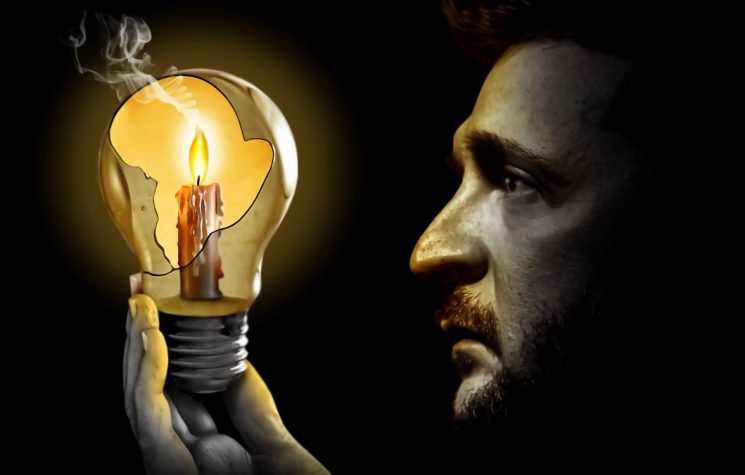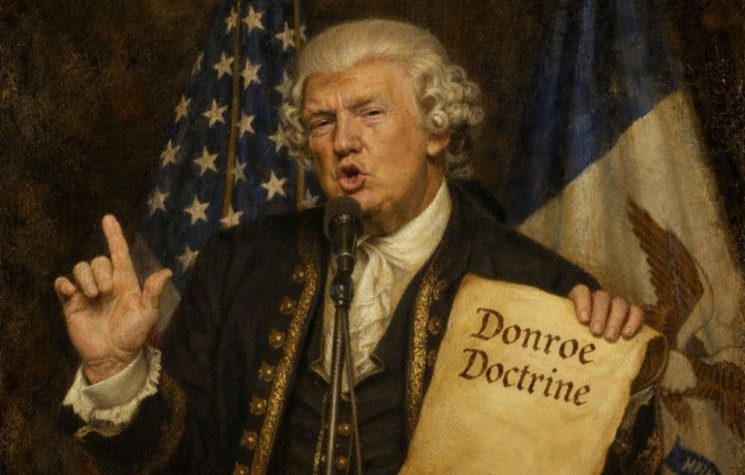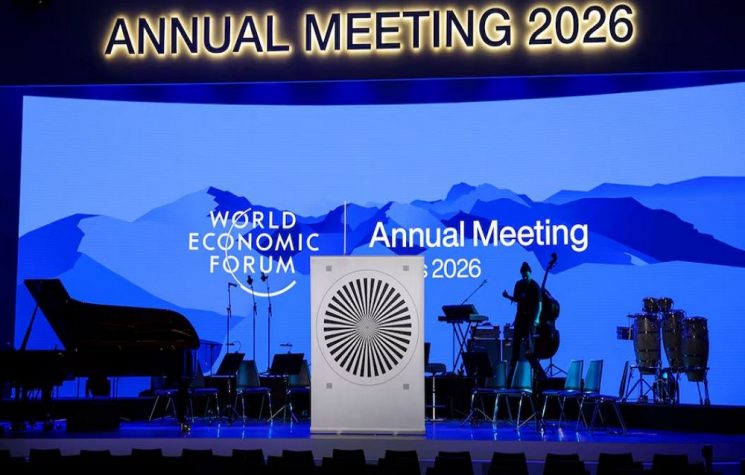Il più monumentale errore di calcolo della storia moderna? Giacomo Gabellini ci spiega perché l’economia russa non è crollata come previsto dagli esperti occidentali Parte II.
Nel luglio 2024, la Banca Mondiale ha pubblicato il suo rapporto annuale che forniva una classificazione dei Paesi del mondo sulla base dei livelli di reddito, misurati secondo il criterio del reddito nazionale lordo pro capite. Il documento evidenziava in primo luogo che tra il 1987 e il 2023, la quota di Paesi a basso reddito era letteralmente crollata nella regione dell’Asia meridionale (dal 100 al 13%) e sensibilmente aumentata in Medio Oriente e Nord Africa (da 0 al 10%), mentre il macrogruppo che riunisce i Paesi ad alto reddito si era allargato in America Latina e nei Caraibi (dal 9 al 44%) e ridimensionamento in Europa e Asia centrale (dal 71 al 69%).
Le alterazioni maggiormente significative segnalate dalla Banca Mondiale all’interno del documento riguardano anzitutto l’Iran, passato dalla categoria dei Paesi a reddito medio-basso a quella dei Paesi a reddito medio-alto di concerto con Algeria, Mongolia e Ucraina. L’economia della Repubblica Islamica è cresciuta del 5,0% nel 2023, trainata principalmente dalle esportazioni di petrolio e dalle entrate derivanti dall’espansione dei servizi e della produzione manifatturiera. Di conseguenza, il reddito nazionale lordo è aumentato del 39,5% in termini nominali. L’affermazione dell’Algeria è invece frutto della rimodulazione delle statistiche attuata dalle autorità nazionali in un’ottica di allineamento agli odierni standard internazionali. Ne è scaturita una revisione al rialzo della crescita del Pil (aumentato in media del 13,3% nel periodo 2018-2022), dovuta prevalentemente all’espansione degli investimenti in ricerca e sviluppo. La riclassificazione della Mongolia riflette la prosecuzione della robusta ripresa post-pandemica, con un incremento del Pil reale pari al 7% nel 2023 sospinto dall’espansione delle attività minerarie (+23,4%) combinata al boom dei proventi da export imputabile alla rivalutazione delle materie prime sui mercati internazionali. Quanto all’Ucraina, il suo passaggio al novero dei Paesi a reddito medio-alto nasce da una ripresa economica pari al 5,3% nel 2023 – trainata dal settore edilizio – che ha parzialmente compensato la caduta verticale del 28,8% registrata l’anno precedente, coniugata al decremento continuo e strutturale della popolazione che va protraendosi dall’invasione russa. Questi fattori sono stati amplificati dagli aumenti dei prezzi dei beni e dei servizi prodotti a livello domestico.
La Cisgiordania e la Striscia di Gaza, entrate nel novero dei soggetti a reddito medio-alto nel 2023, hanno invece visto la loro economia contrarsi nettamente per effetto diretto della guerra con Israele. Sebbene il conflitto sia scoppiato ad ottobre e le sue ripercussioni risultino quindi limitate al quarto trimestre del 2023, si è assistito a un calo del Pil del 9,2% in termini nominali e del 5,3% in termini reali.
Lo studio condotto dalla Banca Mondiale evidenzia infine la riclassificazione di Bulgaria, Palau e Federazione Russa da Paesi a reddito medio-alto a Paesi ad alto reddito. I primi due Paesi raccolgono i risultati dalla crescita inanellata nel periodo post-pandemico, trainata dai consumi. L’economia della Russia, invece, ha risentito profondamente delle implicazioni dell’incremento dello sforzo bellico, oltre che dall’espansione del commercio (+6,8%), del settore finanziario (+8,7%) e delle costruzioni (+6,6%). Lo sforzo propulsivo che ne è derivato si è tradotto in una forte crescita del Pil in termini sia reali (3,6%) che nominali (10,9%).
Dalle statistiche fornite dalla Banca Mondiale si evince che il reddito nazionale lordo pro capite della Federazione Russa è cresciuto tra il 2000 e il 2013 di quasi nove volte da 1.710 a 15.160 dollari (correnti), per poi precipitare a 9.160 dollari (-40% circa) alla fine del 2017 per effetto della prima tornata di sanzioni irrogate dall’Occidente per punire l’inglobamento della Crimea sulla scia del colpo di Stato di Jevromajdan del febbraio 2014.
Tra il 2017 e il 2023 si è registrata una marcata inversione di tendenza, con il reddito nazionale lordo pro capite che è tornato a crescere da 9.160 a 14.250 dollari. Una cifra ancora inferiore a quella i raggiunta nel 2013, ma sufficiente a iscrivere la Russia nel “club” dei Paesi ad alto reddito e nettamente superiore se si analizza il fenomeno attraverso la chiave interpretativa della parità di potere d’acquisto. Il grafico relativo all’andamento del reddito nazionale lordo pro capite a parità di potere d’acquisto attesta la superiorità in termini reali del risultato conseguito nel 2023, pari a 43.510 dollari, rispetto a quello raggiunto nel 2013, pari a 25.120 dollari.
La lettura fornita dagli specialisti della Banca Mondiale ascrive quindi alle dinamiche militari, che alimentano la domanda di beni e servizi, l’ottima performance realizzata dalla Russia. Un ruolo parimenti rilevante è stato giocato dalla inaspettata capacità di minimizzare l’impatto delle sanzioni senza precedenti imposte dal cosiddetto “Occidente collettivo” attraverso triangolazioni e politiche di “sostituzione delle importazioni”. Un aspetto, quest’ultimo, che il presidente Putin ha richiamato esplicitamente durante suo discorso pronunciato nel febbraio dello scorso anno dinnanzi all’Assemblea Federale, spiegando che il progetto messo in cantiere dal governo consisteva nel «produrre beni di consumo e altri beni in quantità molto maggiori: medicinali , attrezzature, macchine, veicoli […]. Nei prossimi sei anni, il livello del valore aggiunto lordo dell’industria manifatturiera russa dovrebbe aumentare di almeno meno 40% rispetto al 2022 […]. Si prevede che la quota dei salari nel Pil nazionale aumenterà nei prossimi sei anni. Adeguiamo il salario minimo prima dei tassi di inflazione e dei tassi di crescita salariale media nell’economia. A partire dal 2020, il salario minimo è aumentato del 50%, da 12.000 a 19.000 rubli al mese. Entro il 2030, il salario minimo sarà quasi raddoppiato, arrivando a 35.000 rubli, il che avrà sicuramente un impatto sul numero di prestazioni sociali e salariali nei settori pubblico e privato».
Si tratta, specialmente a fronte della campagna sanzionatoria imposta dall’Occidente, di affermare la piena sovranità della Russia in ambito economico, attraverso l’incremento della produzione come fonte primaria dell’aumento del reddito, che si traduce in una crescita della domanda di consumi e investimenti destinata a sua volta a espandere e rendere più efficiente la produzione. L’intero ciclo si fonda quindi sull’anteposizione della produzione rispetto al consumo, e sull’attribuzione agli investimenti del ruolo cruciale di sostenere la domanda finale e massimizzare i livelli di efficienza economica. Fattori, questi ultimi, che unitamente all’aumento della produttività del lavoro – fondamentale, alla luce della carenza di manodopera accusata dalla Russia – conducono alla piena valorizzazione delle potenzialità economiche finora espresse in misura soltanto parziale.
Facendo tesoro dell’esperienza sovietica, i decisori di Mosca hanno fondato la realizzazione di questo ambizioso progetto sullo sviluppo concomitante e integrato delle industrie civile e militare, con la seconda chiamata a trainare attraverso investimenti in ricerca un processo di modernizzazione che assicuri un flusso costante di innovazioni da inserire nei processi produttivi.
La creazione di un blocco economico coerente, in grado di stabilire una convivenza sinergica tra industria militare e civile, è stata affidata alla “triade” composta dall’economista Andreij Belousov, piazzato a capo del Ministero della Difesa; al sociologo Denis Manturov, nominato primo vicepremier; all’economista Anton Alikhanov, ex governatore dell’oblast’ di Kaliningrad trasferitosi alla guida del Ministero dell’Industria e del Commercio. Il compito di preservare la stabilità macroeconomica ricade invece anzitutto sul vice primo ministro con delega al settore energetico Alexander Novak, promosso a vero e proprio plenipotenziario, oltre che sul ministro dello Sviluppo Economico Maxim Rešetnikov e sul ministro delle Finanze Anton Siluanov.
I dati positivi inerenti i settori commerciale, finanziario ed edile attestano un robusto contributo dell’economia civile ai fini della crescita economica, attestatasi attorno al 4% nel 2024 e destinata secondo le previsioni del Cremlino a rientrare in un margine compreso tra il 2 e il 2,5% fino al 2027, per poi salire a 3% per il 2028-2030. I consumi dovranno assumere un peso crescente nella formazione del Pil, così come gli investimenti in capitale fisso e le esportazioni non legate al mondo degli idrocarburi. Un vero e proprio programma di “sostituzione delle importazioni”, portato avanti grazie anche all’effetto doppiamente protettivo sul tessuto produttivo domestico prodotto dalle sanzioni occidentali e dalla provvisoria svalutazione del rublo, che ha assicurato risultati particolarmente promettenti nei settori delle macchine utensili, dell’elettronica, della motoristica, della cantieristica navale, dell’aeronautica, della medicina, della farmacia, dell’agricoltura e dell’energia. Il settore bancario ha fornito un contributo parimenti determinante alla modernizzazione dell’economia russa, convergendo con l’industria tecnologica per «creare un ecosistema digitale domestico autonomo e sofisticato».
La spesa militare, rivelatasi determinante rispetto agli obiettivi raggiunti nel 2024, dovrà continuare a svolgere un ruolo centrale proprio in quest’ottica di potenziamento delle attività di trasformazione a scapito di quelle estrattive.
Il piano moscovita volto a porre l’economia nazionale nelle condizioni di soddisfare autonomamente la domanda domestica di beni a medio ed elevato valore aggiunto risulta oggettivamente agevolato dalle sanzioni, che proteggono l’industria russa dalla concorrenza statunitense ed europea alla stregua dei dazi. Verso la Cina, invece, le misure tariffarie vigenti risultano largamente inadeguate, perché consentono importazioni nascoste di beni d’assemblaggio cinese recanti l’etichetta Made in Russia. Un discorso analogo riguarda la cornice legale che disciplina il trasferimento della proprietà intellettuale, che ha finora impedito alla Russia di dotarsi, a differenza della Cina, di un’industria automobilistica “sovrana”.
Va inoltre menzionata l’incoerente carenza di interventi governativi volti a calmierare il prezzo dell’elettricità, presupposto fondamentale per l’affermazione dell’industria manifatturiera. La quotazione della corrente elettrica è salita piuttosto spesso al di sopra dei livelli dell’inflazione, contribuendo in maniera cruciale ad alimentarla.
Anche la struttura tributaria necessita di una profonda riforma. O meglio, di una riconfigurazione implicante un innalzamento e una maggiore progressività delle imposte sul reddito, volta a compensare gli ammanchi sul bilancio pubblico derivanti dall’introduzione di una significativa detassazione a livello federale nei confronti dei settori produttivi vincolata alla profusione di investimenti da parte delle imprese beneficiarie.
La sfida di maggiore rilevanza riguarda la ridefinizione del ruolo della Banca Centrale, il cui operato, sotto la direzione della governatrice Evlira Nabiullina, è stato al centro di aspre critiche. La linea restrittiva – a ottobre del 2024 il tasso di interesse è stato portato al 21% – adottata finora dalla Bank of Russia per contenere l’inflazione e sostenere il corso del rublo comporta oneri pesantissimi per l’accesso al credito sia a carico dello Stato che delle imprese, limitando la loro capacità di investire e minandone considerevolmente la competitività. L’obiettivo di inflazione del 4% in funzione del quale la Banca Centrale russa modula la propria politica non tiene palesemente conto dei cambiamenti strutturali, di natura fortemente inflazionistica, attualmente in corso. La fase di transizione che la Russia sta attraversando verso la costituzione di una economia “sovrana” rende in altri termini inesorabile l’incremento dei prezzi al consumo, cresciuti del 9,5% nel 2024 e tuttora in aumento. Di fatto, l’adesione al postulato cardine della dottrina liberista che sacralizza l’indipendenza della Banca Centrale – contestato con fermezza da economisti di punta come Sergij Glazijev – sta complicando il perseguimento degli obiettivi economici fissati dal governo, il quale ha segnalato (non troppo) velatamente la necessità di forzare in quale modo il consiglio della Bank of Russia ad adottare un atteggiamento maggiormente collaborativo. «È assolutamente chiaro che la sfida principale è data dall’inflazione», ha dichiarato il primo ministro Mikhail Mišustin mentre riferiva a Putin le statistiche annuali per il 2024, aggiungendo poi che «il nostro compito primario consiste nel passare a una politica fiscale e macroeconomica responsabile, in collaborazione con la Bank of Russia».
Quest’ultima dovrà essere indotta sia a tagliare pesantemente il tasso di interesse, sia a rifornire di liquidità le imprese attraverso l’acquisto di obbligazioni societarie. Si tratta di cambiamenti strutturali decisivi, specialmente in un’ottica di formazione di un mercato dei capitali sufficientemente ampio ed efficiente da sostenere l’aumento degli investimenti produttivi pianificato da Mosca. Attualmente, il mercato delle obbligazioni societarie non finanziarie rappresenta appena il 6% del Pil in Russia, contro il 40% registrato dagli Stati Uniti.
Il disallineamento tra politica monetaria, tariffaria, macroeconomica (fiscale e di bilancio) ed energetica e l’assenza di una cornice giuridica e istituzionale adeguato costituiscono cruciali fattori di rischio per la riuscita del progetto di ristrutturazione dell’economia nazionale messo in cantiere da Mosca. Un disegno che appare finalizzato al superamento del modello di crescita basato sui ricavi delle esportazioni di materie prime ed energia come garanzia di stabilità finanziaria, oltre che sul mantenimento di un quadro generale concepito per attrarre le imprese occidentali, identificate come fonti primarie di importazione di tecnologia.
Questo paradigma, affermatosi nei primi anni del nuovo millennio e garante di un rapporto di dipendenza tecnologica e finanziaria con l’Occidente, è stato intaccato dal deterioramento dei rapporti con gli Stati Uniti e i loro satelliti europei sulla scia del colpo di Stato di Jevromajdan del 2014. Da allora, si è assistito a una moltiplicazione degli sforzi atti ad accrescere i livelli di autosufficienza nei comparti critici e a riposizionare la Russia da Paese periferico nella catena del valore occidentale a soggetto centrale o semi-centrale in un ecosistema alternativo, caratterizzato da elevati livelli di complementarietà e collaborazione inter-statale. Un aspetto fondamentale della “svolta” (geo)politico-economica è consistito nel consolidamento delle relazioni con Paesi non occidentali e dall’espansione delle riserve, associata alla promozione di un processo di dedollarizzazione generalizzato, che dall’economia domestica è andato estendendosi al mercato mondiale dell’energia.
I successi conseguiti trovano riscontro nei rapporti redatti dagli analisti di Goldman Sachs nell’estate del 2017, secondo cui l’economia russa risultava già allora saldamente instradata sul sentiero dell’autosufficienza. In particolare, «l’attenzione del Ministero delle Finanze russo verso l’efficientamento del sistema fiscale si sta traducendo in un marcato incremento delle entrate non legate al settore petrolifero. Il progetto nasce dall’esigenza di ridurre l’impatto generato dalle variazioni del prezzo del petrolio sull’inflazione interna e sulla quotazione del rublo […]. La crescente competitività dei beni e dei servizi nazionali sta guidando la crescita economica della Russia». Segno che già allora la nota definizione di «stazione di servizio con bombe atomiche camuffata da Stato» coniata dal senatore John McCain non si attagliava alla Russia.
La spinta decisiva è venuta dalla deflagrazione del conflitto in Ucraina, di cui la Russia si è avvalsa per erigere – con il decisivo contributo dell’Occidente – barriere a protezione dell’industria domestica e porre d’imperio le élite industriali e finanziarie nazionali al servizio di una logica squisitamente “territoriale”, implicante l’imposizione di controlli sui movimenti di capitale e l’adozione di misure atte a privilegiare la cooperazione in luogo della concorrenza. «La Russia – scrive l’economista Jacques Sapir – necessita di uno spostamento verso gli investimenti e dell’impiego delle risorse naturali per sviluppare la produzione interna. È tragico che sia occorsa la guerra in Ucraina perché le classi dirigenti di Mosca se ne convincessero […]. Da questo punto di vista, è stata proprio l’analisi geostrategica, che porta a ritenere che si sia aperto un ciclo di confronto a lungo termine con i Paesi rientranti nel cosiddetto “Occidente collettivo”, a condurre alla rottura, anche se è chiaro che il terreno intellettuale era già stato preparato».