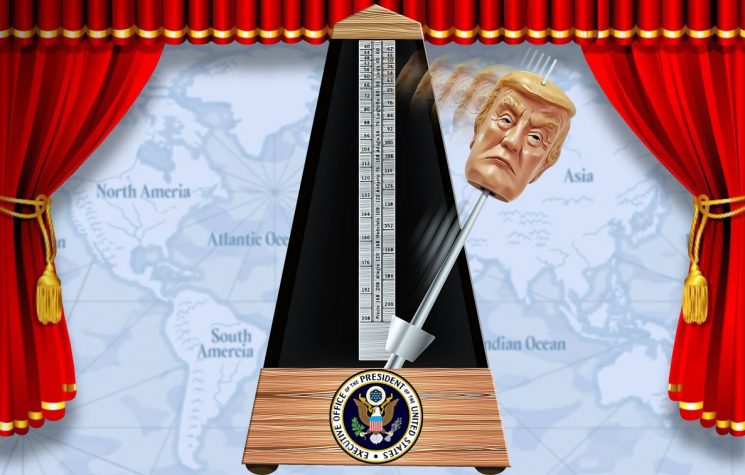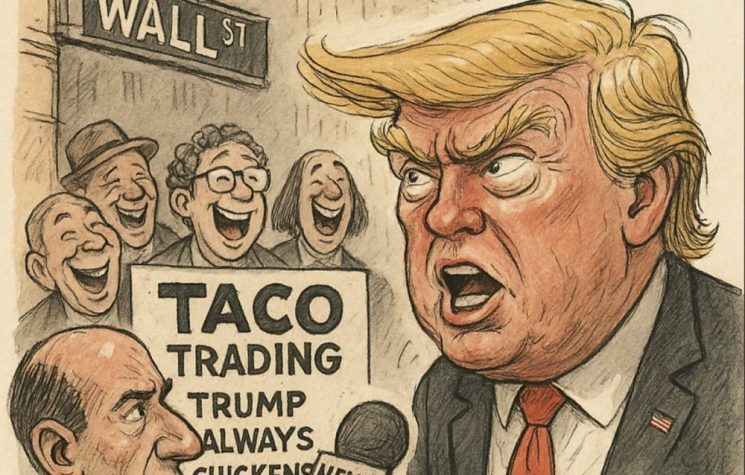Con il ritorno di Trump alla presidenza, piaccia o no, si parla della possibilità di un’intesa tra Stati Uniti e Russia, soprattutto in relazione all’Ucraina.
È realistico immaginare che queste due potenze possano giungere a un accordo che comprenda tutte le aree di conflitto in cui esercitano influenza a livello globale? Perché, parliamoci chiaro, se così fosse ci troveremmo ad assistere a un nuovo processo simile a quello di Yalta.
Il primo storico tentativo
La Conferenza di Yalta del febbraio 1945 rappresentò un momento cruciale nella ridefinizione dell’ordine mondiale postbellico, segnando la transizione dall’alleanza antifascista alla nascita di un sistema bipolare dominato dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica. L’incontro tra Roosevelt, Churchill e Stalin fu motivato dalla necessità di gestire la vittoria ormai imminente sugli Stati dell’Asse, prevenire il collasso dell’Europa e stabilire un nuovo assetto internazionale.
L’agenda negoziale ruotò attorno a tre questioni fondamentali: la riorganizzazione della Germania e dell’Europa centrale, il ruolo dell’Unione Sovietica nel teatro del Pacifico e la struttura del nuovo ordine globale. Se da un lato il trattato sancì la cooperazione tra le potenze vincitrici, dall’altro pose le basi per un confronto geopolitico destinato a inasprirsi nei decenni successivi.
Il trattato sancì diversi accordi, tra cui è opportuno ricordare:
- La divisione della Germania e di Berlino in quattro zone di occupazione (statunitense, britannica, sovietica e francese). Questo assetto gettò le basi per la successiva divisione della Germania in due blocchi contrapposti.
- Le riparazioni di guerra, in particolare a beneficio dell’Unione Sovietica, che ottenne la possibilità di prelevare risorse dalle zone tedesche sotto il proprio controllo.
- L’ingresso dell’URSS nella guerra contro il Giappone, con la promessa di ottenere il controllo su territori strategici come la Manciuria e le isole Curili.
- L’assetto politico dell’Europa orientale, con il riconoscimento della sfera d’influenza sovietica in Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Cecoslovacchia. Nonostante le promesse di elezioni libere, la presenza sovietica si tradusse in una progressiva sovietizzazione dei regimi locali.
- La creazione dell’ONU, con l’adozione del principio del diritto di veto per i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
Uno degli aspetti più rilevanti della conferenza fu la decisione di suddividere la Germania in quattro zone di occupazione. Il principio della smilitarizzazione e della denazificazione venne affiancato da un sistema di riparazioni di guerra, con l’Unione Sovietica che ottenne il diritto di esigere risorse dalle zone controllate. Tuttavia, la gestione della Germania divenne ben presto un terreno di scontro tra Stati Uniti e URSS, culminando nella futura divisione tra Germania Est e Germania Ovest.
Il caso della Polonia evidenziò le divergenze ideologiche tra le potenze: se Churchill e Roosevelt insistevano per la formazione di un governo democratico, Stalin impose un esecutivo filo-sovietico, sfruttando la presenza dell’Armata Rossa. Questa politica si estese all’intera Europa orientale, dove i regimi comunisti si consolidarono sotto la supervisione sovietica, nonostante le promesse di elezioni libere.
Sul piano globale, la conferenza sancì la nascita dell’ONU, un’istituzione destinata a sostituire la fallimentare Società delle Nazioni. Per garantire un equilibrio tra le grandi potenze, venne introdotto il diritto di veto per i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, una misura che avrebbe poi influenzato l’equilibrio politico durante la Guerra Fredda.
Un altro punto chiave fu il coinvolgimento sovietico nella guerra contro il Giappone, con l’URSS che ottenne in cambio la Manciuria, Port Arthur e le isole Curili. Questo accordo consolidò la presenza sovietica in Asia e contribuì alle tensioni nella regione, culminando poi nella Guerra di Corea.
Yalta viene spesso interpretata come un compromesso pragmatico, ma anche come l’inizio della Guerra Fredda, in quanto sancì la suddivisione del mondo in due sfere di influenza contrapposte. L’espansione sovietica in Europa orientale e la risposta statunitense attraverso la politica del containment generarono una dinamica di conflitto ideologico e militare.
Se per l’Occidente Yalta fu il simbolo di una “resa” ai sovietici, per l’URSS rappresentò una vittoria diplomatica che garantì sicurezza ai suoi confini. In ogni caso, la conferenza segnò la fine dell’equilibrio multipolare ottocentesco e l’inizio di una nuova era di relazioni internazionali, dominata dalla logica bipolare e dalla deterrenza nucleare.
Un mondo multipolare, non più bipolare e il futuro dell’Europa
Prima di tutto, bisogna evidenziare che il contesto attuale è ben diverso da quello bipolare del secondo dopoguerra. L’emergere di nuove potenze come Cina e India ha reso il mondo multipolare, rendendo impossibile che Stati Uniti e Russia possano decidere il destino globale da soli, come accadeva in passato. Nonostante ciò, vi sono ancora regioni in cui entrambi i paesi mantengono un’influenza rilevante.
Tra queste regioni, l’Europa occupa una posizione di primaria importanza.
Spesso è stato correttamente sottolineato da tanti autori e analisi come la guerra in Ucraina non sia solo una questione di espansione della NATO o di controllo territoriale da parte della Russia, ma rappresenti una battaglia più ampia tra Stati Uniti e Russia per il futuro dell’Europa. Gli effetti di questa guerra sono evidenti: crisi politiche ed economiche colpiscono in particolare il Regno Unito e gli altri paesi europei schierati con Washington contro Mosca, dimostrando che il vero nodo della questione non è l’Ucraina in sé, ma l’assetto dell’Europa. Alla politica delle sanzioni si è accompagnata la “politica degli incidenti casuali”, come nel caso del Nord Stream 2, per citare un esempio molto noto.
Gli Stati europei che hanno seguito la linea statunitense in Ucraina si trovano ora in difficoltà, con la crescita di movimenti favorevoli alla normalizzazione dei rapporti con la Russia, con i cittadini stanchi della pressione fiscale, dei tradimenti politici e di un odio instillato nei confronti dei vicini di casa russi. Per meglio chiarire, è importante sottolineare che questi movimenti non vanno considerati automaticamente “anti-imperialisti” o “progressisti”, poiché rimangono espressione degli interessi delle loro élite economiche e di un nazionalismo ristretto di stampo occidentale. Un esempio di questo è la loro rapida adesione alla linea filo-israeliana, dimostrando che la loro posizione rispetto agli Stati Uniti è più pragmatica che ideologica.
È chiaro che il futuro dell’Europa sarà senza dubbio un tema chiave nei negoziati tra Trump e Putin. Non si può escludere, inoltre, che possano emergere figure politiche in Europa simili a De Gaulle, in grado di promuovere una linea più indipendente dagli Stati Uniti.
La politica di Trump, orientata a ridurre l’impegno americano all’estero, potrebbe portarlo ad accettare un accordo in stile “Yalta 2.0” che lascerebbe gli alleati europei a gestirsi autonomamente. In tale scenario, la Russia potrebbe trarre vantaggio dalla propria posizione geografica per ristabilire legami con i Paesi europei in ottica di cooperazione eurasiatica.
Un nuovo assetto politico potrebbe emergere in Francia e Germania, con governi della “nuova destra” e riforme dell’Unione Europea che ne ridimensionerebbero l’influenza sulle singole nazioni. Il destino del Regno Unito, invece, è una questione a parte, perché è il grande nemico dell’Europa e merita una trattazione dedicata nei prossimi articoli.
Prospettive per il Medio Oriente
Un’altra regione in cui sia Stati Uniti che Russia esercitano la loro influenza sono il Medio Oriente e il Nord Africa.
Il colpo di Stato in Siria che ha portato alla caduta di Bashar al-Assad, così come il cessate il fuoco tra Palestina e Israele, potrebbero essere considerati i primi segnali del nuovo approccio di Trump nella regione. Tutti siamo consapevoli del sionismo di Trump, ma ora cerchiamo di considerare gli aspetti pragmaticamente politologici, lasciando per un attimo da parte quelli ideologici.
Le dichiarazioni di Trump su Gaza confermano che gli Stati Uniti intendono rafforzare il loro storico sostegno a Israele ed è probabile che Washington continui a sostenere gruppi etnici armati come il PKK, considerati una minaccia per l’integrità territoriale di Turchia, Siria, Iran e Iraq. L’elezione di Trump ha portato a una battuta d’arresto per la Russia in Siria, con un ridimensionamento della sua presenza militare nel Paese. Parallelamente, gli Stati Uniti sembrano voler rafforzare la loro presa sugli stati del Golfo, limitando il loro avvicinamento a Russia e Cina.
Nel frattempo, Mosca e Teheran hanno siglato un accordo strategico di cooperazione per rilanciare i corridoi commerciali ed energetici, con implicazioni anche in ambito militare, andando a serrare con forza il Rimland eurasiatico.
Una questione chiave nei negoziati tra Trump e Putin sarà il futuro di Israele, considerato l’avamposto americano nella regione e con una significativa presenza di immigrati russi. Ciò ha profondamente a che fare con l’Europa, perché il progetto più importane adesso è la Via del Cotone, dove sia Israele che Italia giocano un ruolo centrale.
Tra le possibili “soluzioni” discusse in un’ipotetica Yalta 2.0 potrebbero esserci:
- Garanzie di sicurezza reciproche tra Iran e Israele;
- La fine dell’occupazione israeliana a Gaza;
- Una riduzione del peso militare di Hamas in cambio della fine dell’occupazione;
- Il mantenimento del controllo israeliano sulle alture del Golan per motivi di sicurezza;
- La fine degli attacchi a Israele da parte delle milizie regionali, in particolare nello Yemen.
L’aggressività strutturale di Israele rende improbabile che queste ipotesi si traducano in una pace duratura.
Trump e Putin potrebbero anche discutere di questioni relative agli stati del Golfo, ai prezzi del petrolio e al ruolo dell’OPEC, così come della situazione in Libia, Yemen e della presenza di gruppi armati nel nord della Siria. Di sicuro, ciò che ne dovrà uscire sarà perlomeno una bozza di un accordo di formattazione mondiale.
I criteri di deterrenza, soft power e hard power potrebbero cambiare nel giro di poche ore.
Un mondo non più dominato da USA e Russia
Credo sia ormai abbastanza chiaro che il cambiamento dell’ordine mondiale porterà ad un nuovo scacchiere mondiale: non viviamo più in un sistema bipolare come quello nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’ascesa di nuove potenze come Cina, India e Iran ha reso il contesto multipolare, con attori regionali che prendono decisioni autonome, con il Global South che emerge con forza e con una generale e diffusa percezione diversa delle relazioni internazionali.
Per questo motivo, Stati Uniti e Russia non hanno più il potere di ridisegnare da soli il mondo come fecero a Yalta nel 1945.
Ciò che è evidente è che continueranno a cercare compromessi nelle aree di maggiore tensione, tenendo conto delle nuove dinamiche geopolitiche.
Mediaticamente sembra che stiano dialogando solo USA e Russia, ma dietro le quinte e fuori dalle telecamere ci sono molti più giocatori della partita. Si dia inizio ai giochi.