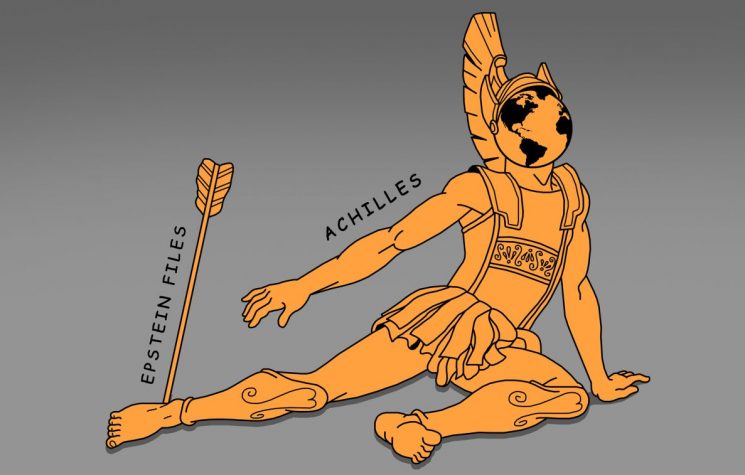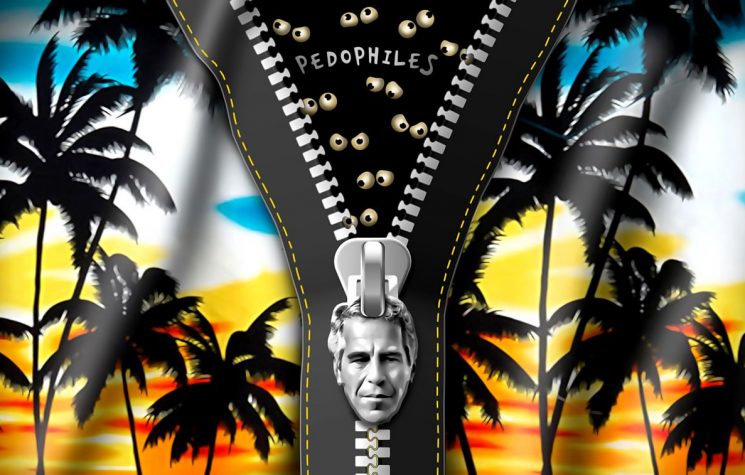Sia il nazifascismo che le varie sfumature del liberalismo, adottando lo Stato come istituzione suprema, finiscono per creare un vuoto culturale, riempiendolo di fantasia.
Il saluto di Elon Musk all’insediamento di Trump ha fatto molto discutere. Il suo gesto è servito come test di Rorschach politico, in cui le persone hanno proiettato le proprie opinioni. Per la sinistra nel suo complesso è stato un inequivocabile Sieg Heil. Gli ebrei antisionisti hanno voluto sottolineare la prova che Elon Musk è un antisemita. In effetti, antisemitismo e sionismo vanno di pari passo, dato che lo stesso Herzl disse che l’odio per gli ebrei avrebbe garantito l’immigrazione di ebrei per il suo Stato etno-razziale. Tuttavia, il filosemitismo dei calvinisti e dei loro eredi è un dato di fatto. Il nome stesso “Elon” è ebraico. Significa “quercia”.
A destra, libertari e neocons giuravano che Elon Musk era un autista maldestro che non sapeva come esprimere affetto, e per questo faceva due volte un gesto che consisteva nel battersi il petto e nell’alzare il braccio teso, con il palmo della mano rivolto verso il basso. Forse questa versione è stata inventata dalla lobby sionista, visto che l’ADL si è affrettata a spiegare che Musk stava solo facendo un gesto imbarazzante.
Le persone più sobrie, invece, sono state in grado di riconoscerlo come il saluto romano che, a giudicare dalle spiegazioni apparse su Internet, sembra essere più conosciuto in Francia. Il motivo è molto semplice: la sua presenza nella simbologia della Rivoluzione francese.
In questo mondo afflitto da una propaganda polarizzante, è utile riflettere su cosa abbia portato un miliardario simpatizzante dell’anarco-capitalismo a fare un gesto dei rivoluzionari francesi e a essere etichettato come estremista di destra.
La storia del saluto
Il saluto romano è una fantasia neoclassica. I Romani non si salutavano in questo modo. Il saluto romano ha probabilmente il suo atto di nascita nel dipinto Le Serment des Horaces (1785) di Jacques-Louis David. Quattro anni dopo scoppiò la Rivoluzione francese, che perseguitò la Chiesa e instaurò la Repubblica. Poiché la Repubblica è un’invenzione romana, l’immaginazione dei rivoluzionari si rivolge ai lontani tempi pre-imperiali – e pre-cristiani – di Cicerone. Circa 130 anni dopo, un altro movimento repubblicano e anticlericale si appropriò dell’estetica neoclassica: il fascismo italiano.
È per questa coincidenza che il fasces lictoris (una piccola accetta formata da un fascio di bastoni) simboleggia il fascismo italiano, ma compare anche nello stemma della Repubblica francese. E per lo stesso motivo, il saluto romano, in una versione più semplice (senza la parte della mano sul cuore), fu adottato dal fascismo. Più tardi, il fan austriaco di Mussolini avrebbe introdotto il Sieg Heil. Tuttavia, in generale, la Germania nazista era contraria all’adozione del simbolismo romano e il fasces lictoris non compare nel Terzo Reich.
E sapete dove altro si può trovare un saluto romano modificato, più un fasces lictoris e molta estetica neoclassica? Negli Stati Uniti. Il saluto di Bellamy – con la mano sul cuore, poi il braccio esteso prima con il palmo verso il basso, poi girandolo verso l’alto – è emerso alla fine del XIX secolo ed è durato fino alla Seconda Guerra Mondiale. È stato eliminato dalle scuole per la sua somiglianza con i gesti nazifascisti. Il fasces lictoris, invece, compare abbastanza spesso nei simboli nazionali degli Stati Uniti: è sullo stemma del Senato, nello Studio Ovale, nelle mani di Abraham Lincoln all’Emancipation Memorial…
Il vuoto simbolico del liberalismo
Del trio neoclassico, il fascismo è la pecora nera, perché è l’unico movimento antiliberale. È antiliberale perché concentra il potere nella discrezione del Duce, che fa quello che vuole senza preoccuparsi del contratto sociale, della nozione di diritti umani o del Parlamento.
D’altra parte, sia la Rivoluzione americana che quella francese sono state liberali. Ovviamente non si tratta di liberalismo economico, ma piuttosto di liberalismo politico, che elimina la struttura medievale dei tre Stati (clero, nobiltà e popolo) e trasforma il corpo politico in un grande contratto sociale in cui tutti i cittadini hanno uguali diritti – anche se solo nella lettera della legge, e molti sono esclusi dalla cittadinanza. La Rivoluzione francese fu portata avanti dalla borghesia (la parte ricca del popolo) e, nella sua formulazione più sanguinaria, aveva l’obiettivo di impiccare l’ultimo nobile con le budella dell’ultimo prete. Dopo un tremendo bagno di sangue, con esecuzioni di massa (anche di contadini, parte del popolo), i rivoluzionari istituirono i Diritti dell’Uomo (1789) – notoriamente chiamati da Marx diritti borghesi.
La forma liberale per eccellenza è la Repubblica. La Francia, tuttavia, non ha avuto la prima rivoluzione liberale della storia. Quella fu la Gloriosa Rivoluzione (1688), il cui prodotto analogo ai Diritti dell’Uomo fu il Bill of Rights (1689).
L’Inghilterra proveniva da un contesto molto più caotico della Francia. La nobiltà aveva già raggiunto il XVI secolo agendo come una borghesia, ed era entrata in conflitto con il re e la Chiesa per espellere il popolo dalle proprietà comunali con le famigerate Enclosures. Con l’approvazione del Parlamento, i nobili espulsero il popolo dalle terre, distruggendo le loro case e facendolo morire di fame. La loro intenzione era quella di utilizzare le terre per allevare pecore e produrre lana, che sarebbe stata tessuta da telai sempre più moderni, il che avrebbe portato alla rivoluzione industriale. Inoltre, ci furono problemi tra la monarchia inglese e la Chiesa (con Enrico VIII che voleva sposarsi in serie), una guerra civile religiosa, alcune decapitazioni, una Repubblica calvinista…
Alla fine, lo stato di cose creato dalla Gloriosa Rivoluzione fu quello di una repubblica velata: anziché la borghesia uccidere i nobili, i nobili divennero borghesi; anziché estinguere il clero, fu creata una nuova chiesa, sottomessa allo Stato; e, anziché porre fine alla monarchia, fu insediato un re della chiesa di Stato, con le mani legate dal Parlamento.
Ciò lasciò i liberali inglesi in una posizione comoda: non era necessario creare, ex nihilo, un simbolismo nazionale per dare al Paese un’identità dopo la distruzione delle istituzioni tradizionali. L’involucro della vecchia Chiesa e l’involucro della vecchia nobiltà erano già presenti. Gli altri regimi repubblicani e anticlericali, liberali o meno, hanno dovuto inventare un simbolismo ex nihilo. E i primi (Stati Uniti e Francia) lo hanno cercato nell’antica Roma, che ha lasciato in eredità ai posteri la Repubblica.
Questa mancanza di simbolismo indica la novità del liberalismo: fare dello Stato un’autorità unica, suprema e totalmente razionale. Con il liberalismo, tutta l’autorità proviene dallo Stato. Prima del liberalismo, era possibile ricorrere all’autorità ecclesiastica per sfuggire al giogo secolare, ad esempio. La differenza tra il liberalismo politico e l’antiliberalismo di Mussolini non sta nel fatto che lo Stato sia più o meno grande, ma piuttosto nei meccanismi di autocontrollo dello Stato: nel liberalismo sono presenti, nell’antiliberalismo fascista sono assenti e il potere dello Stato è concentrato nel Duce.
Punti comuni
Nel caso degli Stati Uniti, nazione protestante, è sorprendente che tutto il simbolismo nazionale lasci fuori il cristianesimo. Potevano usare una croce o un pesce, per esempio, ma non l’hanno fatto: hanno preferito simboli di una civiltà pagana, oltre ai simboli massonici.
Ma l’Antica Roma immaginata da tutti loro (americani, francesi, italiani) è incredibilmente moderna, perché razionalista e irreligiosa. Non si vedono uomini pubblici che si preoccupano delle interpretazioni degli aruspici davanti alle budella degli uccelli. Tutto vuole essere esclusivamente apollineo e razionale, come la modernità, non come l’antichità. L’identificazione con Roma era qualcosa di quasi del tutto arbitrario. Di fronte al vuoto culturale e simbolico del liberalismo, non restava che utilizzare i simboli e l’estetica della cultura che aveva creato l’unica cosa con cui il liberalismo si identificava: la Repubblica. E se nella modernità non ci sono aruspici o pitonesse, ci sono scienziati e filosofi.
Oltre a Roma, possiamo pensare a due movimenti scientifici di successo che hanno adottato bandiere inventate ex nihilo e le hanno issate sugli edifici pubblici: Il nazismo, con la sua svastica priva di qualsiasi legame con la storia germanica, e il wokismo, con la sua bandiera gay con un triangolo con i colori dei trans e dei colorati (è la bandiera del Progress Pride, che si può vedere qui). Sia il nazifascismo che le varie sfumature del liberalismo, adottando lo Stato come istituzione suprema, finiscono per creare questo vuoto culturale, riempiendolo di fantasia.