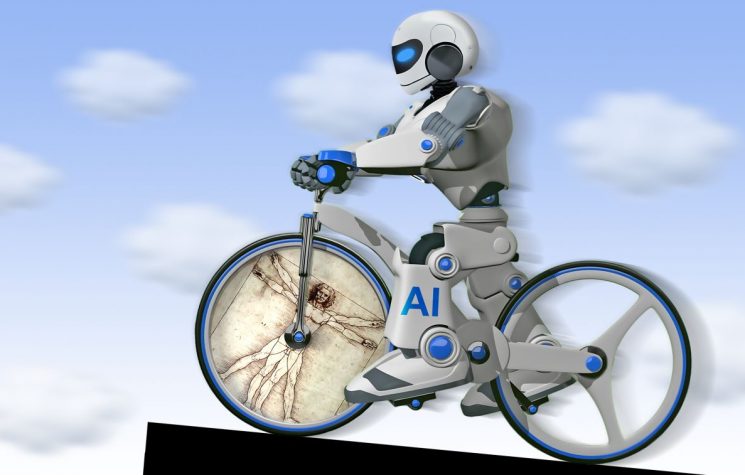Quali problemi può affrontare il sistema monetario “ipotetico” dei BRICS?
Oltre agli aspetti più immediati e roboanti, che si riferiscono all’iper-politicizzazione e all’armamento del sistema monetario globale da parte delle autorità statunitensi, attraverso le misure solitamente designate con l’eufemismo “sanzioni” (in realtà, la pratica della pirateria più sfrenata e selvaggia da parte dell’Egemone), esiste un problema più profondo nel commercio internazionale, riguardante le forme di regolazione monetaria delle disparità delle bilance dei pagamenti dei Paesi coinvolti in tale commercio.
Molto brevemente, la questione centrale è la seguente: in caso di squilibri sistematici, devono essere i Paesi in deficit, o piuttosto quelli in surplus, ad apportare gli aggiustamenti necessari per raggiungere l’equilibrio? Per inciso, possiamo aggiungere: nel caso di un’opzione per la svalutazione dei Paesi in deficit, saranno meno dannose le svalutazioni monetarie o invece la cosiddetta “svalutazione interna” (come nel caso dell’UE e dell’Euro nel 2011, con la “crisi del debito sovrano” dei Paesi dell’Europa meridionale)?
John Maynard Keynes ha già affrontato una questione fondamentalmente analoga quando propose il “BANCOR”, nel 1944. Questa proposta fu poi accantonata a favore del cosiddetto sistema di Bretton Woods, il sistema dollaro-oro, che riconosceva nella moneta statunitense un surrogato dell’oro (il metallo fino ad allora centrale nel commercio internazionale), facendone una sorta di “equivalente generale”, o una “super-valuta”, e gli Stati Uniti una sorta di “super-sovrano” monetario mondiale. Questo sistema si basava sul peso eccezionalmente elevato dell’economia statunitense a livello globale alla fine della guerra, e in genere presupponeva che gli Stati Uniti avrebbero generato una domanda globale sufficiente per essere l’acquirente dei beni degli altri Paesi (o almeno di quelli che si supponevano “comportarsi bene” in termini politici), trascinando così dietro di sé le economie degli altri Paesi.
Questa fissazione durò fino alla fine della convertibilità del dollaro in oro nel 1971, decisa dalle autorità statunitensi a causa delle tensioni poste sulla bilancia dei pagamenti e sul bilancio pubblico dalla guerra del Vietnam e dalla correlativa espansione del “welfare state” che gli Stati Uniti avevano sperimentato negli anni Sessanta (con l’attuazione delle misure corrispondenti alla cosiddetta “Great Society”). Questo cambiamento è stato sostenuto da un altro importante gruppo di accordi. L’economia politica della fine della convertibilità consisteva essenzialmente nell’accettazione da parte dei Paesi produttori di petrolio del dollaro come moneta di scambio abituale per quella merce, il che garantiva alla valuta statunitense una domanda globale notevolmente aumentata in modo meramente “artificiale”, e quindi anche il mantenimento della sua accettabilità universale, nonostante la fine della convertibilità in oro.
La questione della compensazione
Ma come possono essere diversamente le cose se, invece del sistema dollaro-oro, o dell’assetto istituzionale che lo ha sostituito nel 1971, vogliamo che il commercio internazionale sia fondamentalmente tra pari, senza alcun Egemone, ma anche senza gli inconvenienti di un ritorno al precedente “gold standard”, né quelli della vertigine isolazionista che è derivata dal crollo di quello standard? Ascoltiamo prima Jacques Sapir, riferendosi al caso attuale dei BRICS:
La questione della compensazione è importante nella misura in cui il commercio sarà multilaterale (l’area potenziale è di 22 Paesi, i 9 membri dei BRICS e i 13 Paesi partner). Un’idea che sta prendendo piede in Cina e in Russia è che ogni transazione non venga liquidata immediatamente, ma alla fine di un determinato periodo (da un trimestre a un anno) e che le compensazioni vengano effettuate a livello dei “grandi attori” (compresi i singoli attori commerciali). Questo sistema sembra ispirarsi a quanto esisteva in Europa occidentale nel contesto dell’Unione Europea dei Pagamenti (1950-1957). All’epoca, il calcolo delle transazioni e il regolamento finale avvenivano in dollari. Nel sistema Clear dei BRICS, sarà una “stablecoin” a fungere da unità di conto, mentre il regolamento finale avverrà in valute locali.
Ma prima o poi, il tentativo di costruire sistemi basati sulle valute nazionali incontrerà dei limiti sotto forma di bassa liquidità nei loro mercati (per alcune di queste valute), restrizioni legislative sulla convertibilità, un alto livello di rischi di cambio, così come uno squilibrio negli scambi reciproci, che porta all’accumulo di debiti cronici. Per questo motivo, una delle soluzioni proposte è molto simile al sistema implementato nel contesto dell’Unione Europea dei Pagamenti, abbinato a una piattaforma di valuta digitale, che offrirà una velocità di pagamento molto più elevata rispetto ai sistemi di pagamento tradizionali (come SWIFT). La configurazione di un’area di pagamento organizzata intorno a Cina, India e Russia, che includa i Paesi partner e alcuni Paesi attualmente in contatto con i BRICS, sarebbe ottimale in termini di dimensioni e di equilibrio dei flussi commerciali agroindustriali (alimenti, fertilizzanti, macchinari agricoli) nel quadro della compensazione multilaterale.
L’iniziativa “BRICS Clear” dovrebbe essere vista come un’iniziativa che va ben oltre gli interessi di Cina e Russia, anche se è particolarmente importante per la Russia a causa delle sanzioni occidentali. Proprio come l’EPU è stato un fattore di integrazione europea alla fine degli anni ’50, che si è concretizzato nel Trattato di Roma, l’iniziativa “BRICS Clear” dovrebbe consentire una forma di integrazione non solo tra i Paesi membri dei BRICS, ma anche con i Paesi “partner”.
(“I BRICS sfidano l’ordine occidentale: la fine dell’egemonia del dollaro è iniziata”, 1 novembre 2024, traduzione e sottolineatura mia).
Il modo in cui questi squilibri negli scambi reciproci verranno alla fine risolti è di enorme importanza in termini di significato, non solo economico, ma anche socio-politico, di quell’esperienza estremamente interessante che sono indiscutibilmente i BRICS. A seconda dell’uno o dell’altro caso (la regolamentazione che in linea di principio induce i Paesi in surplus a consumare di più o, in alternativa, costringe i Paesi in deficit di norma a consumare di meno, cioè a praticare l’“austerità”), le traiettorie possono essere molto diverse, per certi aspetti addirittura opposte.
Il BANCOR e i suoi nemici
Di norma, sarà consigliabile pensare in modo “keynesiano” (o forse “post-keynesiano”), cioè scegliere la prima strada indicata. Ciò avrà ripercussioni significative in termini di livello generale della produzione economica, che verrà promossa, di distribuzione funzionale del reddito, in cui verrà sostenuta la quota del lavoro, e di distribuzione personale del reddito, in cui potranno essere affrontate le eccessive asimmetrie. Permettetemi, a questo proposito, un’ampia trascrizione di un articolo di Prabhat Patnaik:
La Dichiarazione dei BRICS si concentra anche sulla rimozione dell’egemonia del dollaro USA e su un maggiore commercio internazionale in valute nazionali con tassi di cambio fissi l’una rispetto all’altra. Eliminare l’egemonia del dollaro è senza dubbio un obiettivo lodevole, ma non è sufficiente. Occorre anche eliminare l’egemonia della finanza. A tal fine, sono necessarie almeno tre condizioni: in primo luogo, gli aggiustamenti per eliminare gli squilibri delle partite correnti devono essere effettuati dai Paesi con eccedenze correnti, piuttosto che da quelli con deficit correnti; in secondo luogo, fino a quando gli squilibri non saranno eliminati, i Paesi in eccedenza dovrebbero essere disposti a detenere tutte le cambiali dei Paesi in deficit che si presenteranno; in terzo luogo, non dovrebbero esserci trasferimenti di attività (“denazionalizzazione”) per saldare il debito in sospeso.
L’aggiustamento dei Paesi in surplus rispetto a quelli in deficit è auspicabile non solo per eliminare la posizione dominante, ma anche dal punto di vista della produzione mondiale e dell’occupazione, e quindi del benessere dei lavoratori del mondo. Se il Paese in surplus deve adeguarsi, aumenterà l’assorbimento interno di beni e servizi e, poiché la sua produzione sarà vicina alla piena capacità, ridurrà le sue esportazioni. Il Paese in deficit, anche se mantiene lo stesso livello di assorbimento interno di prima, poiché le sue importazioni sono diminuite, registrerà un aumento della produzione e dell’occupazione. Quindi, considerando i due Paesi nel loro insieme, si verificherebbe un aumento della domanda aggregata, con conseguente aumento della produzione e dell’occupazione. E se l’aumento dell’assorbimento da parte del Paese in surplus assume la forma di un maggiore consumo da parte dei lavoratori, il beneficio per i lavoratori dei due Paesi sarà ancora maggiore: nel Paese in surplus grazie a un maggiore consumo e nel Paese in deficit grazie a una maggiore occupazione.
Al contrario, se è il Paese in deficit a dover effettuare l’aggiustamento, come avviene attualmente, si assisterà a una riduzione dell’assorbimento interno, che creerà una recessione al suo interno. Il livello complessivo della domanda aggregata mondiale si ridurrà a spese dei lavoratori di tutto il mondo, in particolare del paese in deficit. L’eliminazione degli squilibri correnti attraverso l’aggiustamento dei Paesi in deficit è quindi inferiore all’aggiustamento dei Paesi in surplus, anche se quest’ultimo è più difficile da applicare.
Inoltre, l’eliminazione dell’egemonia del dollaro senza un accordo per l’aggiustamento dei Paesi in surplus darà luogo all’egemonia di qualche altra valuta, non all’eliminazione totale dell’egemonia. Supponiamo, ad esempio, che i Paesi BRICS commercino solo tra loro e in valute nazionali con tassi di cambio fissi (altrimenti la speculazione valutaria dilagante renderebbe insostenibile qualsiasi accordo commerciale). Se un Paese ha un persistente deficit delle partite correnti nei confronti di un altro, allora o riduce l’assorbimento interno per eliminare il deficit, come avviene attualmente, o continua a fornire pagherò al Paese in eccedenza fino a quando non aumenta la pressione contro la sua valuta e non può più mantenere un tasso di cambio fisso. In quest’ultimo caso, alcune valute, quelle dei Paesi in surplus, acquisiranno l’egemonia sulle altre; la sostituzione del dollaro, senza dubbio altamente auspicabile, avrà portato solo alla sua sostituzione con qualche altra valuta, non all’eliminazione dell’egemonia valutaria.
(Vertice di Kazan dei BRICS,10 novembre 2024, corsivo mio).
In effetti, e tornando al nostro punto di partenza, la questione cruciale sembra essere se debbano essere i Paesi in deficit o quelli in surplus a fare gli aggiustamenti necessari per l’equilibrio. Keynes, è bene ripeterlo e sottolinearlo, aveva già sostanzialmente affrontato questo problema all’epoca della sua famosa proposta Bancor, che fu accantonata nel 1944 a favore del sistema di Bretton Woods, cioè del sistema dollaro-oro, che durò fino alla fine della convertibilità dollaro-oro nel 1971.
Sebbene sia stato indubbiamente pressato dalla difficile posizione del Regno Unito nei confronti degli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che suggerì immediatamente l’opportunità di un aggiustamento non dalla parte dei Paesi in deficit ma da quella dei Paesi in surplus, la posizione difesa nel 1944 da Keynes è tuttavia sostenuta anche, e più fondamentalmente, dai suoi assunti teorici generali sui vantaggi di regolare il funzionamento delle economie in modo “dal lato della domanda”; cioè scommettendo sulla promozione coerente della domanda globale, che si suppone tenda sistematicamente a essere insufficiente. Questo approccio presuppone però, e questo è fondamentale, livelli elevati (e persino tendenzialmente crescenti) di intervento statale nell’attività economica.
Un approccio “pre-keynesiano”, invece, dà per scontato che i mercati, se il loro “normale” funzionamento è consentito dall’astensione volontaria dall’intervento delle autorità pubbliche, garantiscano sia livelli ottimali di attività e di produzione, sia una distribuzione soddisfacente del reddito.
L’atteggiamento “pre-keynesiano” è saldamente radicato nelle basi concettuali del funzionamento della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e della stessa Organizzazione Mondiale del Commercio. È anche quello che sta alla base degli accordi istituzionali che hanno prodotto l’euro. Se c’è uno squilibrio, ad esempio, con la Germania in surplus e i cosiddetti “PIGS” (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna) simmetricamente in deficit, la conclusione che si trae in questo quadro istituzionale-mentale non è che la Germania debba essere indotta a consumare di più, ma che i PIGS dovranno sottoporsi a un trattamento di “austerità”.
Il neoliberismo è pienamente in anticipo sui destini dell’Europa
Sebbene questa possa essere considerata una strana forma di indulgenza nei confronti del “neo-mercantilismo” tedesco (come è stato anche chiamato), è tuttavia perfettamente coerente con gli scopi neoliberali e “anti-statalisti” dell’UE, e in particolare dell’UEM: primato del mercato, contenimento della crescita dell’intervento statale nell’economia (fine della “legge di Wagner”), con un livellamento verso il basso della tassazione e delle regolamentazioni, accompagnato da una libertà illimitata dei movimenti di capitale.
Come ha osservato Wolfgang Streeck, l’euro è essenzialmente costruito su un accordo hayekiano. La genialità della soluzione, dal punto di vista neoliberista, sta nel fatto che un’unione doganale di Paesi molto diversi tra loro, quindi con un’area di intersezione di interessi molto ridotta, impedisce un’azione politica concertata e continua. Pertanto, l’intervento dello Stato tende a ridursi a un minimo comune – il che, nel caso dell’UE, è ulteriormente rafforzato dal fatto che la legislazione comunitaria ha ufficialmente la precedenza su quella di ogni Stato membro. Tuttavia, anche a prescindere da ciò, l’idea centrale è che, riunendo Stati con economie molto diverse, ciascuno di essi tende ad agire come un freno per gli altri e ne è contemporaneamente inibito.
Il fatto che le federazioni di Stati possano concordare al meglio la liberazione delle loro economie dall’intervento degli Stati – cioè quella che la scienza politica contemporanea ha chiamato “integrazione negativa” – è stato sottolineato da Friedrich von Hayek già nel 1939. La federazione internazionale, dice Hayek, sarà necessaria in futuro per ripristinare e preservare la pace internazionale; ma una federazione che non riesce a integrare la sua economia non resterà in piedi; e l’integrazione economica tra Paesi diversi e [formalmente] uguali può procedere solo nella forma dell’integrazione del mercato: l’istituzionalizzazione di un mercato unico libero dall’intervento dello Stato, perché gli Stati membri non saranno in grado di concordare altro che questo. L’articolo di Hayek del 1939 getta un ponte tra l’economia austriaca, il “liberalismo autoritario” di Schmitt tra le due guerre, l’ordoliberalismo tedesco del dopoguerra e il neoliberalismo dell’Unione Monetaria Europea a partire dagli anni Novanta.
(Wolfgang Streeck, “Heller, Schmitt and the Euro”, in “How will Capitalism End”, London, Verso, 2016, pagina 159; corsivo mio).
L’unione doganale, a queste condizioni, è neoliberale nella sostanza, o non lo è affatto. Ogni squilibrio commerciale viene così sistematicamente identificato come un problema di consumo eccessivo nei Paesi in deficit, e la terapia consiste sempre nella stessa, vecchia, vecchia, anche se l’“austerità”, come il diavolo (I nomi infernali – Wikipedia), ha davvero mille nomi. Ma il contenuto non cambia: deregolamentare, “lasciare che il mercato funzioni”, impedire agli Stati di intervenire – laddove la sgradevole presenza del suffragio universale potrebbe eventualmente creare pressioni in tal senso. Mantenere (infine, ma non per questo meno importante) una disciplina rigorosa per contenere i Paesi allineati che potrebbero essere tentati da comportamenti “devianti”.
L’accordo, tuttavia, si è rivelato alla lunga dannoso per la performance economica di tutti i Paesi membri: anche prima dei grotteschi episodi che hanno configurato il recente suicidio collettivo sulla scia del conflitto ucraino, l’UE ha perso terreno nei confronti del resto del mondo. Al suo interno, i PIGS sono andati anche peggio, perdendo terreno rispetto alla media dell’Unione. Il Portogallo, ad esempio, ha recuperato terreno rispetto alla media dei 6 Paesi fondatori quasi ogni anno dal 1960 al 2001, per poi passare a un ritardo sistematico con la creazione dell’euro. Il PIL pro capite convergeva con l’Europa mentre era “fuori dall’Europa”; se ne discostava sistematicamente verso il basso da quando era finalmente riuscito a “entrare in Europa”.
Più in generale, però, questo assetto tende a produrre crescenti disparità regionali all’interno dell’Unione. A livello di distribuzione del reddito, le pressioni così indotte vanno anche genericamente verso la crescita delle disuguaglianze; e portano a una distribuzione funzionale del reddito meno favorevole al lavoro, che rafforza i problemi creati dai freni volutamente posti alla possibile crescita dei dispositivi di “welfare state”.
Il neoliberismo parzialmente in anticipo sui destini del mondo
Patnaik nota questa connessione tra intervento dello Stato e crescita economica, ma a livello mondiale, in un altro articolo (“La stagnazione dell’economia mondiale”,6 ottobre 2024). L’obiettivo di tenere gli Stati lontani dall’intervento economico ha probabilmente portato a un significativo rallentamento dell’economia globale. Assumendo la forma di regolamentazione del commercio mondiale attraverso il quadro istituzionale oggi prevalente (un quadro social-darwiniano, che promuove sistematicamente la “concorrenza” come presunto stimolo a continui miglioramenti), affinché uno Stato deciso a intervenire non diventi un “babbeo”, con i potenziali effetti moltiplicatori benefici dell’aumento della sua spesa pubblica che si disperdono sotto forma di promozione squilibrata delle sue importazioni, è necessario: o che si tratti di uno “Stato commerciale chiuso”, come quello concepito più di due secoli fa da Johann Gottlieb Fichte e oggi largamente praticato a Cuba e in Corea del Nord; oppure che un numero sufficientemente ampio di Paesi decida di farlo, promuovendo congiuntamente politiche sia espansionistiche (o “keynesiane”) che “dirigiste”.
Patnaik è però forse un po’ troppo perentorio sulla questione delle ripercussioni di una svalutazione monetaria. Se si usa il tasso di cambio, non certo per lasciarlo fluttuare liberamente, ma imponendogli uno scopo amministrativamente fisso, basato sulla situazione commerciale di un Paese, il conto esterno di questo (ipoteticamente, in una situazione di deficit) può avvicinarsi all’equilibrio molto più facilmente attraverso una svalutazione monetaria che imponendogli la terapia della cosiddetta “svalutazione interna”. La svalutazione del tasso di cambio, è vero, è potenzialmente positiva per la bilancia commerciale, ma è anche un induttore di fughe di capitali e un aumento dei tassi di interesse, annullando in parte i benefici in termini di import-export. In ogni caso, è necessario pensare alla possibilità di svalutazioni monetarie amministrativamente fissate da parte dei Paesi in deficit: questo (probabilmente integrato da restrizioni sui movimenti di capitale) è meglio del modello di “svalutazione interna” applicato in Europa ai PIGS negli anni 2010.
In ogni caso, questa è probabilmente solo una questione secondaria. La cosa principale da mantenere è l’idea “keynesiana” di regolare i saldi commerciali “dall’alto”, assumendo come principio che, in situazioni di squilibrio, i Paesi in surplus dovrebbero essere puniti selettivamente, costringendoli a consumare di più, con l’obiettivo di riequilibrare gli altri – ma anche di evitare pressioni recessive. Queste ultime sono per lo più associate (e di fatto derivano) dai dispositivi della cosiddetta “austerità”, che riducono la domanda complessiva di ciascun Paese attraverso il contenimento della spesa pubblica, con la falsa affermazione che ciò consentirebbe il rafforzamento della spesa privata e degli investimenti privati, che tenderebbero a loro volta a compensare il ritiro economico dello Stato attraverso i cosiddetti effetti “trickle-down”. I ricchi, in altre parole, nel caso in cui fossero autorizzati a pagare meno tasse, tenderebbero a fare da soli, senza restrizioni legali, come lo Stato, ma di solito meglio dello Stato, in virtù del fatto che sono sempre sottoposti alla logica (presumibilmente razionalizzante) dei dispositivi di mercato. E, naturalmente, ne distribuirebbero spontaneamente i benefici al resto della popolazione.
Una leggenda, riconosciamo, con una credibilità comprensibilmente in calo…