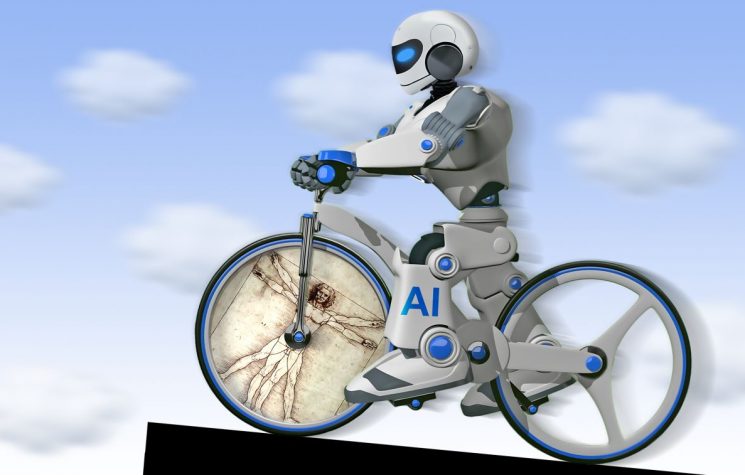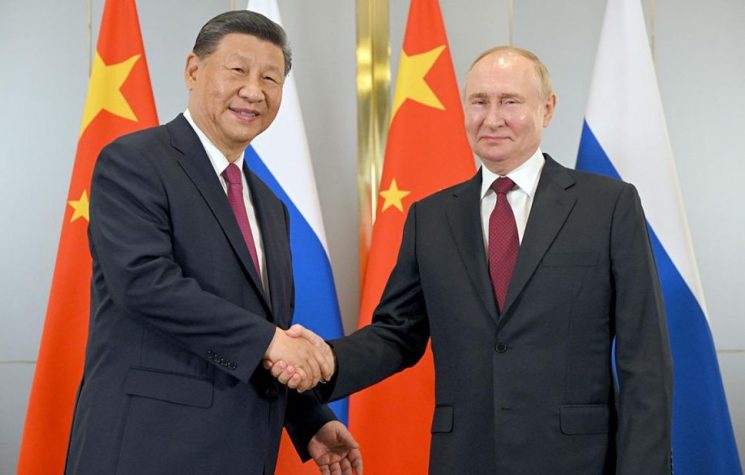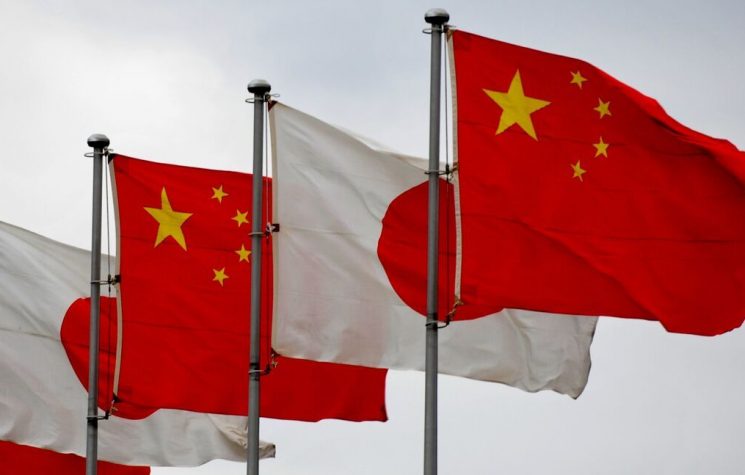Ad un certo punto l’Italia dovrà comunque fare una scelta definitiva: Stati Uniti o Unione Europea.
Dalla “prudenza gestionale” alla spinta al riarmo
È cominciato il nuovo anno 2026 e, dobbiamo dirlo con tutta onestà, nei pochi giorni già trascorsi sono successe così tante cose che potrebbero bastare per tutto l’anno.
Guardando all’Italia, Giorgia Meloni ha impresso una svolta di intensità bellica alla postura italiana molto più netta rispetto ai suoi predecessori, utilizzando l’aumento della spesa militare come leva politica e simbolica per legare il paese a uno scenario di guerra prolungata in Europa. In parallelo, questa scelta colloca l’Italia in una posizione strutturalmente sfavorevole: nel momento in cui il conflitto sul continente dovesse entrare in una fase apertamente interstatale, Roma sarà costretta a scegliere non solo da chi comprare i missili, ma a quale architettura strategica subordinare definitivamente la propria sicurezza.
Il ritratto di Meloni come semplice amministratrice prudente dell’esistente, evocato dal Financial Times, contrasta con la dinamica reale della politica di difesa italiana negli ultimi anni. Sul piano interno, la premier ha progressivamente trasformato l’obiettivo NATO del 2% del PIL in una sorta di orizzonte identitario del suo governo, rivendicando la credibilità militare come fondamento della politica estera e della legittimazione internazionale dell’Italia.
Già le proiezioni NATO mostrano che la spesa militare italiana è cresciuta in termini assoluti, passando da circa 21–22 miliardi di euro nella seconda metà degli anni 2010 a oltre 25 miliardi nel 2023, con ulteriori aumenti programmati. Osservatori indipendenti come l’Osservatorio Milex stimano una crescita strutturale dei fondi destinati alla difesa e al riarmo, con il bilancio 2023 attestato oltre i 26 miliardi e circa 8 miliardi annui stabilizzati per nuovi armamenti, segnando una rottura rispetto alle stagioni di contenimento della spesa militare dei governi precedenti.
Il cuore politico della fase Meloni è la decisione di utilizzare fino in fondo lo spazio offerto dall’Unione Europea per sdoganare la spesa militare fuori dai vincoli classici di bilancio. Il disegno, emerso nei documenti di finanza pubblica, prevede la possibilità di liberare circa 12 miliardi di euro in tre anni per la difesa, ricorrendo alla cosiddetta “National Escape Clause”, cioè una clausola di salvaguardia che consente di escludere dal deficit una quota significativa di spesa militare.
Questa scelta non è neutra: significa sancire che, in un contesto di austerità selettiva, la guerra e la preparazione militare diventano l’unica voce di spesa che può crescere strutturalmente, mentre altri capitoli restano compressi dai vincoli europei. La stessa dialettica nella maggioranza – con la Lega che chiede di spostare le risorse su sicurezza interna e ordine pubblico, contro l’idea di “mandare militari al fronte” – segnala come l’aumento di bilancio sia percepito dagli alleati non solo come un fatto contabile, ma come un passo concreto verso un coinvolgimento più diretto nei teatri di guerra.
La militarizzazione dell’agenda emerge anche nel modo in cui il governo ha gestito il dossier Ucraina. Nonostante le resistenze interne alla coalizione, l’esecutivo ha progressivamente normalizzato l’idea che l’Italia debba contribuire in modo sistematico all’invio di armamenti, sistemi di difesa aerea e capacità missilistiche a Kiev, inserendo questi flussi dentro decreti quadro che proiettano il sostegno militare almeno fino al 2026.
La logica è chiara: consolidare una filiera industriale e politica che faccia dell’Italia un attore affidabile sia per la NATO sia per i programmi europei di riarmo, in particolare attraverso strumenti come i prestiti SAFE e i progetti congiunti di produzione di sistemi d’arma. In questo quadro, l’aumento di spesa deciso da Meloni non è più solo risposta contingente alla guerra in Ucraina, ma investimento anticipato in una guerra europea “a bassa e media intensità” destinata a durare anni, con il rischio concreto di trasformarsi in conflitto interstatale più ampio.
Una posizione geostrategica sfavorevole
L’Italia entra in questo scenario con una posizione strutturalmente sfavorevole. La geografia la colloca saldamente nell’ombrello NATO, ma sul fronte sud di un conflitto europeo che resterà comunque centrato sul corridoio baltico-mar Nero, cioè lontano dai propri confini e vicino, invece, ai principali fornitori di sistemi missilistici e di difesa aerea. L’asimmetria è evidente: Roma si troverà a finanziare un riarmo definito altrove, a dipendere da supply chain controllate soprattutto da Stati Uniti, Francia e Germania, e a negoziare l’accesso a capacità critiche – missili antiaerei, antimissile, cruise, sistemi integrati di comando e controllo – in condizioni di margine politico ridotto.
Nel momento in cui il conflitto europeo dovesse entrare in una fase di guerra aperta, l’Italia non sarà nella posizione di autodeterminare la propria architettura missilistica, ma dovrà chiedere capacità aggiuntive agli alleati, modulando la domanda tra Washington e i principali complessi militari-industriali europei. In altre parole, il paese non deciderà solo da chi comprare i missili, ma a chi legare le regole d’ingaggio, le interoperabilità dei sistemi, la distribuzione delle basi e perfino la definizione di ciò che viene considerato “difensivo” o “offensivo” nello scenario europeo.
L’aumento di spesa voluto dalla Meloni non risolve questo paradosso, ma lo accentua. Una quota rilevante dei nuovi fondi è infatti destinata a programmi integrati NATO/UE, in cui la tecnologia chiave – dai sensori radar ai vettori missilistici – resta controllata da pochi grandi player esteri. Ciò significa che, quando “fra poco comincerà la guerra in Europa”, per riprendere la logica implicita dei piani di riarmo, l’Italia avrà sì pagato il biglietto d’ingresso, ma continuerà a dipendere politicamente e industrialmente da chi quei sistemi li produce e li aggiorna.
In uno scenario di escalation, la scelta “da chi prendere i missili” non sarà dunque una decisione puramente tecnica di procurement, ma un atto di allineamento strategico definitivo: più verso gli Stati Uniti e l’ombrello atlantico, con la priorità ai sistemi interoperabili con le dottrine USA, oppure più incardinato nei progetti di autonomia strategica europea, che però restano frammentati e spesso subordinati a leadership franco-tedesche. In entrambi i casi, l’Italia si presenta all’appuntamento meno come soggetto sovrano che come “cliente avanzato” di un ordine di guerra già scritto, dopo aver usato l’aumento di spesa militare per accelerare, più dei suoi predecessori, la propria corsa verso quel bivio.