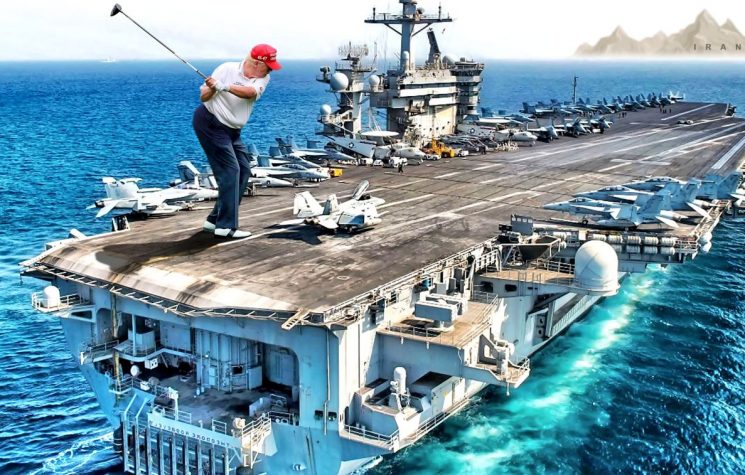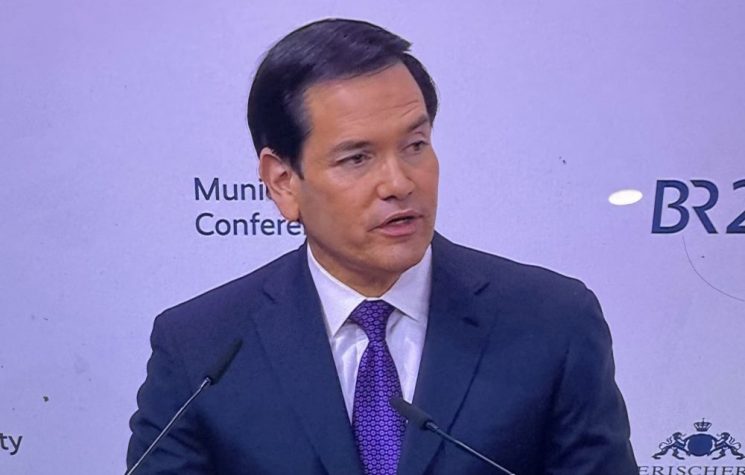Trent’anni dopo gli orrori della guerra dei Balcani, l’Occidente si trova immerso in un’altra guerra europea, quella tra Russia e Ucraina. Anche qui la linea tra informazione, propaganda e censura si fa sottile. E come negli anni ’90, il rischio è di ridurre il conflitto a uno scontro morale tra buoni e cattivi, semplificando la complessità e rimuovendo le ambiguità.
Cecchini e Safari
A trent’anni dalla fine della guerra in Bosnia, una nuova inchiesta giudiziaria riporta alla luce uno degli episodi più oscuri e moralmente intollerabili del conflitto balcanico: quello dei cosiddetti “turisti del cecchinaggio”, stranieri — tra cui alcuni italiani — che avrebbero pagato somme ingenti per partecipare, dalle colline attorno a Sarajevo, alla caccia all’uomo contro la popolazione civile.
A indagare oggi è la procura di Milano, dopo la denuncia presentata dal giornalista e scrittore Ezio Gavazzeni, da anni impegnato in inchieste su terrorismo e criminalità organizzata. Secondo le sue ricerche, condensate in un dossier di 17 pagine, durante l’assedio di Sarajevo — uno degli episodi più lunghi e sanguinosi della dissoluzione jugoslava — cittadini facoltosi di diversi Paesi avrebbero potuto “acquistare” l’esperienza di sparare contro uomini, donne e bambini. Un macabro gioco di morte, pagato in denaro e giustificato da un’ideologia di forza e impunità.
Le prime testimonianze, raccolte all’epoca da reporter di guerra e confermate oggi da un ex ufficiale dell’intelligence bosniaca, parlano di viaggi organizzati attraverso Trieste, con collegamenti diretti verso le alture che circondavano Sarajevo. Secondo le rivelazioni, il servizio segreto militare italiano, il SISMI, sarebbe stato informato dell’esistenza di questi “safari umani” già all’inizio del 1994, dopo che l’intelligence bosniaca aveva scoperto l’orrore mesi prima. La risposta, riporta l’agenzia Ansa, fu: “Abbiamo messo fine a tutto, non ci saranno più safari”. E in effetti, due o tre mesi dopo, gli episodi cessarono. Ma la vergogna rimase, sepolta nel silenzio.
Chiunque abbia coperto la guerra di Bosnia sa che l’assedio di Sarajevo — dal 1992 al 1996 — fu qualcosa di più di una battaglia militare: fu una crudeltà sistematica contro una città simbolo della convivenza multietnica. Oltre 11.000 civili furono uccisi, di cui 1.600 bambini. La vita quotidiana era scandita dal suono dei colpi di mortaio e dal terrore dei cecchini. Bastava attraversare una strada per rischiare di morire.
Eppure, l’esistenza di “volontari” e “ospiti” stranieri tra i tiratori non era affatto un mistero. Già nel 1995, nelle cronache di Ezio Mauro, Bernardo Valli, Ettore Mo e di altri inviati italiani, si accennava alla presenza di gruppi di “avventurieri” accanto alle milizie serbo-bosniache. L’allora corrispondente da Sarajevo scriveva: “A Grbavica, dove il cecchinaggio dei cetnici e la partecipazione venatoria internazionale non vengono nascosti ma ostentati dalla televisione di Karadžić, fra i cecchini c’è anche una squadra di greci decorati pubblicamente, e il caso di un volontario giapponese”.
Tra i nomi più noti, quello dello scrittore e politico russo Eduard Limonov, ripreso dalle telecamere mentre sparava con una mitragliatrice pesante al fianco di Radovan Karadžić, poi condannato per genocidio all’Aia. Limonov, che non pagò per partecipare, dichiarò anzi ammirazione per il “coraggio serbo” e disse: “Noi russi dovremmo prendere esempio da voi”. Un elogio del cinismo elevato a estetica, come se la crudeltà potesse diventare gesto politico.
Tra pacifismo e indifferenza
Ma ciò che più colpisce, allora come oggi, non è solo la brutalità dei fatti, bensì la reazione — o meglio, l’assenza di reazione — del mondo che li guardava. Mentre Sarajevo viveva quattro anni di fame, bombardamenti e cecchini, in gran parte dell’Occidente il dibattito era paralizzato da un pacifismo sterile, incapace di distinguere tra intervento umanitario e aggressione militare.
“Una sinistra coerente — scriveva allora un inviato — avrebbe dovuto incatenarsi nelle piazze non per protestare contro ogni uso della forza, ma per esigere un intervento delle Nazioni Unite e della NATO in difesa dei cittadini bosniaci. Invece si preferì l’inerzia, in nome della neutralità.” La stessa neutralità che permise, poco dopo, il massacro di Srebrenica.
Il caso dei “turisti del massacro” non è dunque solo un episodio di barbarie privata. È anche lo specchio di un clima politico e morale in cui l’orrore poteva convivere con l’indifferenza. Non a caso, Gavazzeni osserva che “tutti sapevano”, ma pochi vollero davvero vedere. Come se la guerra balcanica, pur così vicina geograficamente, restasse lontana nella coscienza europea.
A rendere più inquietante la vicenda è il modo in cui è riaffiorata. Non da un’indagine istituzionale, ma dall’iniziativa di un giornalista che, dopo aver visto il documentario Sarajevo Safari del regista sloveno Miran Zupanič nel 2022, ha deciso di tornare a scavare. Nel film, diversi testimoni bosniaci descrivono la presenza di “ospiti stranieri” che, a pagamento, venivano portati in postazioni di tiro per sparare sui civili. Le nazionalità menzionate includono americani, russi e italiani.
Gavazzeni, colpito dalle coincidenze con le cronache di trent’anni prima, ha raccolto nuovi elementi e li ha consegnati alla magistratura milanese. Oggi il pubblico ministero Alessandro Gobbis, esperto di terrorismo internazionale, sta valutando la possibilità di procedere per omicidio. Un’impresa difficilissima, a distanza di decenni, ma moralmente necessaria.
Eppure, anche di fronte a un’indagine formale, riaffiorano dubbi e negazioni. Ex militari britannici che servirono a Sarajevo negli anni ’90, interpellati dalla BBC, hanno definito la storia “una leggenda urbana”, sostenendo che sarebbe stato logisticamente impossibile portare stranieri a sparare tra le linee serbe, a causa dei numerosi posti di blocco. Ma questa prudenza anglosassone — tipica di chi preferisce non scomodare la propria coscienza — stride con la quantità di testimonianze raccolte in loco e con le stesse parole dei reporter che vissero l’assedio.
L’eredità morale del conflitto
L’inchiesta milanese non cambierà il corso della storia. Ma riapre una ferita nella memoria europea: quella dell’ipocrisia morale che accompagna la guerra quando avviene “troppo vicino per ignorarla, ma troppo scomoda per affrontarla”. La Bosnia fu il primo grande banco di prova dell’Europa post-Guerra fredda, e fallì miseramente. Oggi, rievocare i “turisti del massacro” significa chiedersi non solo chi sparò, ma chi guardò altrove.
Dietro la mostruosità dei “safari umani” si nasconde un problema più profondo: la fascinazione per la violenza, la normalizzazione della crudeltà, la spettacolarizzazione della guerra. Quell’oscuro desiderio di vedere — o perfino partecipare — al potere di vita e di morte è lo stesso che, in forma mediatica, anima oggi la guerra come intrattenimento: la conta dei droni, le dirette dai fronti, i video virali dei bombardamenti. È cambiata la tecnologia, non l’immaginario.
Trent’anni dopo Sarajevo, l’Occidente si trova immerso in un’altra guerra europea, quella tra Russia e Ucraina. Anche qui la linea tra informazione, propaganda e censura si fa sottile. E come negli anni ’90, il rischio è di ridurre il conflitto a uno scontro morale tra buoni e cattivi, semplificando la complessità e rimuovendo le ambiguità.
Oggi non servono più le colline per sparare. Si spara con le parole, con i media, con le campagne di disinformazione e di censura reciproca. La stessa russofobia che pervade l’Occidente — e che porta a cancellare concerti, mostre e libri — nasce da un identico meccanismo di esclusione morale: il bisogno di purificare lo spazio pubblico da tutto ciò che disturba la narrazione ufficiale.
L’orrore dei “turisti del cecchinaggio” di Sarajevo ci parla dunque anche di questo: di quanto sia fragile la linea che separa la condanna dalla complicità, la libertà dalla censura, la verità dalla propaganda.
L’inchiesta di Milano, probabilmente, non produrrà condanne. Troppo tempo è passato, troppi documenti sono scomparsi, troppe responsabilità si sono dissolte. Ma ha già ottenuto un risultato essenziale: costringerci a guardare di nuovo, senza filtri, l’abisso morale della guerra.
“È la stessa indifferenza che ieri lasciava morire Sarajevo e oggi si indigna solo a intermittenza”, dice Gavazzeni. Perché ricordare non è solo un atto di pietà verso le vittime, ma un esercizio di responsabilità verso il presente.
I turisti del massacro non appartengono solo al passato. Sono il simbolo di una civiltà che, pur dichiarandosi libera e democratica, continua a convivere con il proprio lato oscuro — quello che trasforma il dolore altrui in spettacolo, la crudeltà in curiosità, la guerra in turismo. E finché questo sguardo non cambierà, la storia di Sarajevo non smetterà di riguardarci.