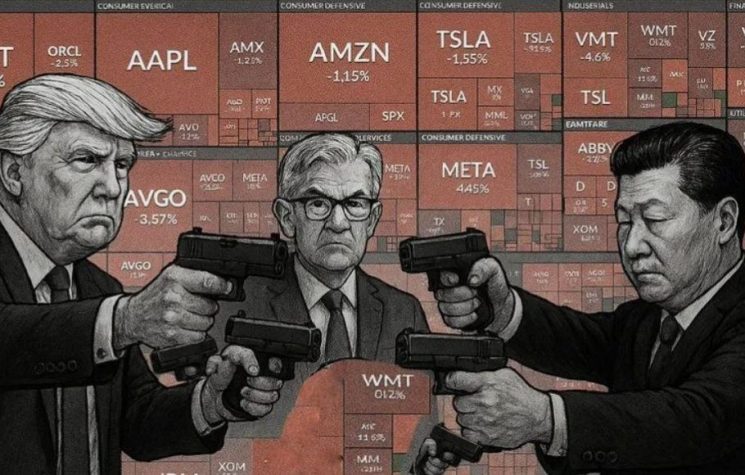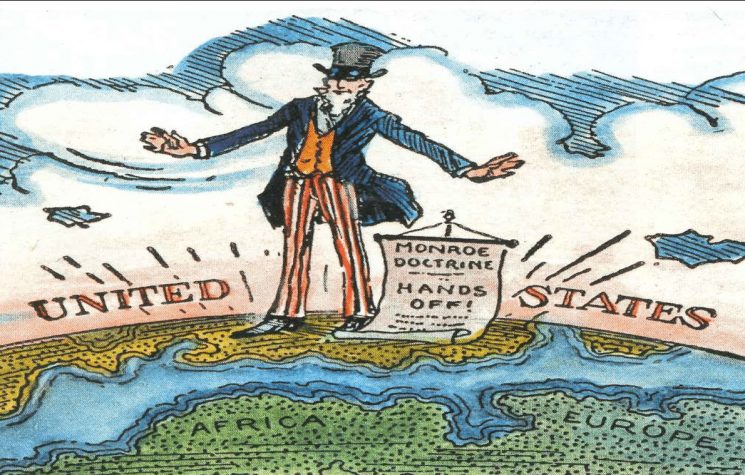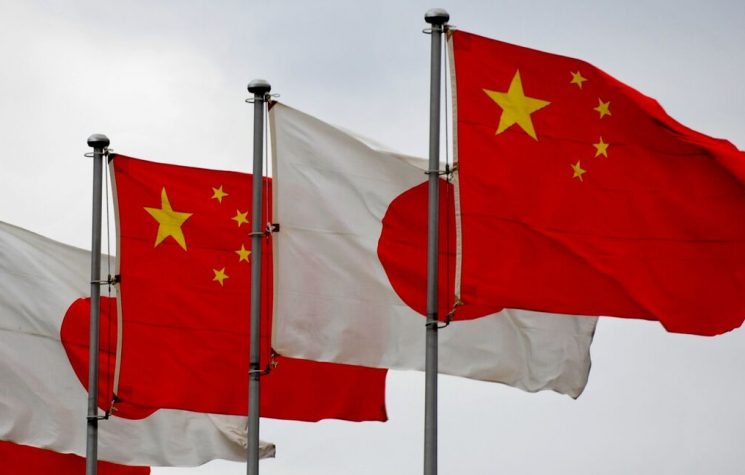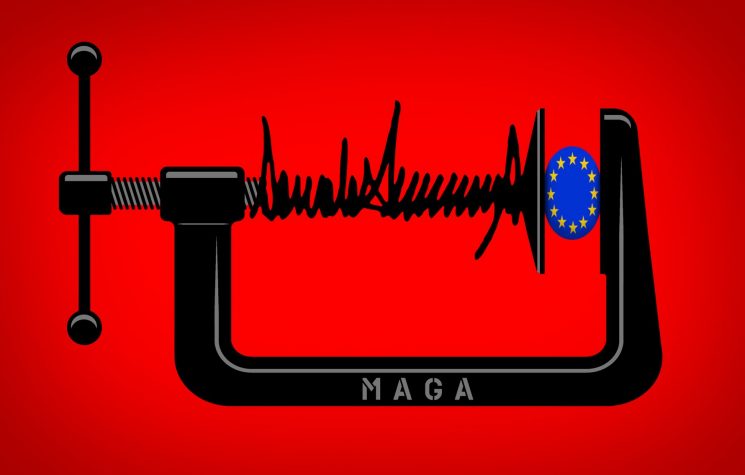La missione del Presidente vietnamita all’ONU ha confermato l’impegno di Hà Nội per un multilateralismo efficace e orientato ai risultati. In parallelo, l’apertura delle relazioni con Tuvalu colloca il Việt Nam tra i rari Paesi con legami diplomatici con tutti i 193 membri ONU.
La settimana di alto livello dell’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha offerto al Việt Nam un palcoscenico ideale per ribadire, con linguaggio e atti concreti, la centralità del multilateralismo nella propria strategia di politica estera. La visita del Presidente Lương Cường a New York (21–24 settembre) è stata infatti costruita attorno a due direttrici complementari: da un lato, il contributo sostanziale alla discussione multilaterale su pace, sicurezza e sviluppo sostenibile; dall’altro, la diplomazia operativa che punta a trasformare l’autorevolezza costruita negli anni in nuove opportunità, nuove responsabilità e nuova influenza. In questo contesto, la firma del Comunicato Congiunto con Tuvalu per l’instaurazione delle relazioni diplomatiche bilaterali ha dato alla missione una valenza storica, in quanto, con questo atto, il Việt Nam entra nel ristretto novero di Paesi che intrattengono relazioni con tutti i 193 membri delle Nazioni Unite, un traguardo che corona decenni di apertura, diversificazione dei partner e integrazione internazionale.
La cornice politica della visita è stata chiarita con nettezza dal Rappresentante Permanente del Việt Nam presso l’ONU, l’ambasciatore Đỗ Hùng Việt. Secondo il diplomatico, il messaggio che la delegazione presidenziale ha portato al Dibattito Generale, e più in generale alla Settimana di alto livello, ruota attorno a un’idea semplice e potentemente politica, quella che la pace è il fondamento di ogni progresso sociale e di ogni sviluppo durevole. È una prospettiva che poggia sull’esperienza storica vietnamita — guerra, embargo, ricostruzione — ma che guarda avanti, traducendosi in impegni misurabili e concreti. Il Paese, infatti, non si limita a proclamare principi, ma propone, assume oneri, si candida a ruoli che comportano responsabilità e capacità di mediazione. L’adesione a una diplomazia “aperta” e proattiva si è così intrecciata con un’agenda fitta di iniziative e candidature multilaterali, coerente con la linea strategica sancita dalla Risoluzione n. 59 del Politburo sull’integrazione internazionale nel nuovo contesto globale.
La postura multilaterale è stata resa visibile da una serie di elementi che, congiuntamente, danno il senso della traiettoria assunta dalla diplomazia vietnamita negli ultimi anni. Nel suo intervento all’Assemblea Generale, il Presidente Lương Cường ha presentato il Việt Nam come una storia di trasformazione da Paese devastato dalla guerra a nazione a reddito medio con dinamiche di crescita, capace di combinare stabilità politica, apertura economica e responsabilità internazionale. Inoltre, il governo vietnamita ha recentemente assunto ruoli concreti nella diplomazia mondiale, come la guida dei lavori in vista della firma, nell’ottobre 2025 a Hà Nội, della Convenzione ONU contro la criminalità informatica — primo trattato delle Nazioni Unite a riportare il nome della capitale vietnamita — e la disponibilità ad assumere la presidenza nel 2026 della Conferenza di Revisione del Trattato di Non Proliferazione Nucleare. A ciò si aggiungono la candidatura al Consiglio per i Diritti Umani per il triennio 2026–2028 e quella per un giudice al Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare per il periodo 2026–2035. Si tratta un ventaglio di impegni che racconta un multilateralismo non rituale, nel quale Hà Nội accetta di lavorare nei nodi sensibili dell’agenda globale — sicurezza digitale, non proliferazione, diritti umani, governance degli oceani — offrendo al tempo stesso un’ulteriore prova di affidabilità nelle operazioni di peacekeeping, già parte integrante del profilo internazionale vietnamita.
Sul versante bilaterale, la missione a New York ha scandito una ricorrenza densa di significati, in quanto gli 80 anni della fondazione delle Nazioni Unite coincidono con l’ottantesimo anniversario del Việt Nam moderno e indipendente, e con il trentennale della normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti, oggi incardinati in un Partenariato Strategico Comprensivo. La fitta agenda di incontri con autorità e grandi aziende statunitensi ha avuto un comune denominatore, quello di portare la relazione a un livello più “funzionale”, orientandola verso i settori di maggior importanza per la modernizzazione dell’economia vietnamita. Infatti, scienza e tecnologia, innovazione e intelligenza artificiale, difesa e sicurezza, trasporti, istruzione e formazione sono proprio gli ambiti nei quali la cooperazione tra le due parti viene portata avanti con maggiore successo, rendendoli operativi in cui creare catene di valore condivise, attrarre investimenti di qualità e accrescere la resilienza dell’industria nazionale. Inoltre, la dimensione storico-morale della relazione — la gestione delle conseguenze della guerra e il dialogo su questioni storicamente sensibili — è stata collocata esplicitamente dentro un quadro di cooperazione pratica e prospettica, a testimonianza di un rapporto che cerca di metabolizzare il passato senza rimanerne prigioniero.
Il segnale forse più eloquente della maturità diplomatica raggiunta dal Việt Nam è arrivato, però, con la firma del Comunicato Congiunto con Tuvalu, al quale abbiamo accennato in precedenza. Sebbene si tratti di un piccolo arcipelago dell’Oceano Pacifico, poco rilevante da un punto di vista demografico e territoriale, questo evento ha ricevuto una grande copertura da parte dei media vietnamiti per via della sua portata storica, in quanto pochi Paesi al mondo possono affermare di intrattenere relazioni con tutti i 193 membri delle Nazioni Unite, traguardo raggiunto dal Việt Nam proprio in quest’occasione. Ma l’importanza del gesto è anche qualitativa e strategica. Anzitutto, perché dà compimento alla dottrina della diversificazione delle relazioni, uno dei cardini della politica estera vietnamita sin dalla stagione del Đổi Mới: costruire un ventaglio di interlocuzioni che vada oltre le grandi potenze e includa attori “piccoli” ma cruciali in termini di voti, voce e valore politico nelle sedi multilaterali. In secondo luogo, perché apre uno spazio di cooperazione concreto con un piccolo Stato insulare del Pacifico, area in cui si giocano partite decisive su clima, transizione energetica, connettività digitale e sicurezza marittima.
Il testo congiunto firmato dagli emissari dei due Paesi prevede infatti la volontà di esplorare cooperazioni in domini ad alta sensibilità sistemica: economia blu, turismo sostenibile, educazione e formazione. Secondo gli osservatori, la proiezione di Hà Nội verso queste agende risponde a obiettivi molteplici, come condividere know-how, a partire dall’esperienza nel coniugare sviluppo industriale e tutela ambientale, che può risultare preziosa per economie insulari esposte a rischi climatici e di sicurezza alimentare, ma anche radicare ulteriormente la propria presenza nel sistema multilaterale del Pacifico, dove si intersecano dinamiche geopolitiche complesse e dove la coesione dei piccoli Stati è un moltiplicatore di influenza nelle organizzazioni internazionali.
L’insieme di questi movimenti diplomatici si colloca in un contesto globale che lo stesso Rappresentante Permanente vietnamita a New York ha descritto come di “cambiamenti e sfide senza precedenti”. È proprio in congiunture del genere che la combinazione della diplomazia vietnamita di fermezza di principi e flessibilità di approccio mostra la sua efficacia. La fermezza sta nel riferirsi con costanza alla Carta ONU e al diritto internazionale, alla centralità della pace, all’idea di sovranità come responsabilità verso il proprio popolo e verso la comunità internazionale. La flessibilità emerge nella capacità di dialogare con una pluralità di attori, di muoversi tra consessi diversi, di fare del pragmatismo una virtù senza cadere nell’opportunismo. È queso duplice aspetto della diplomazia vietnamita che ha reso possibile, in poche decadi, la trasformazione del profilo esterno del Paese, dalla marginalità dell’era postbellica alla reputazione di “membro attivo, responsabile e proattivo” più volte riconosciuta nelle sedi internazionali.