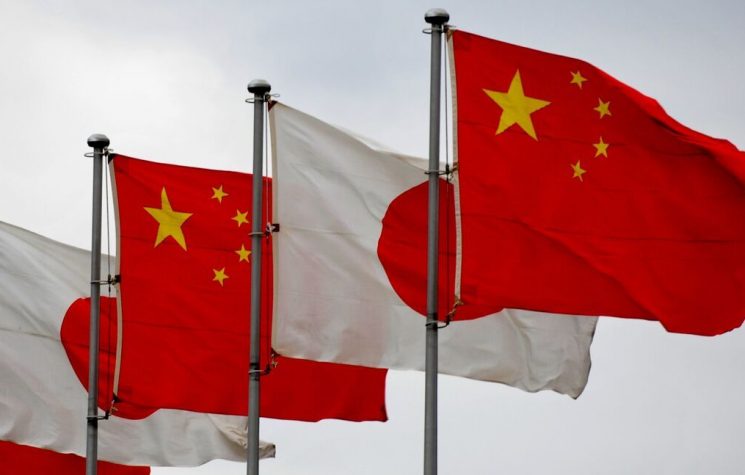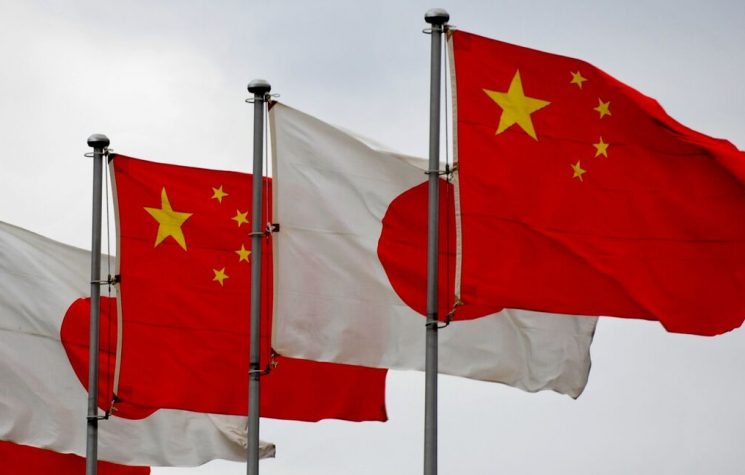Le dimissioni di Ishiba segnano un vuoto politico profondo e aprono una fase di incertezza istituzionale. Allo stesso tempo, la spinta al riarmo – tra esercitazioni congiunte, acquisto di missili a lungo raggio e infrastrutture belliche – accentua i rischi per la stabilità regionale e accende il confronto politico interno.
La caduta di Shigeru Ishiba dalla guida dell’esecutivo giapponese, formalizzata con le sue dimissioni annunciate all’inizio di settembre, è l’epilogo di mesi di sconfitte elettorali e di una crisi di legittimazione che coinvolge il partito al governo e l’intero sistema politico. La vicenda segna non solo un avvicendamento di leadership nel Partito Liberaldemocratico (PLD), meglio noto come Jimintō, ma anche il momento in cui si evidenziano contraddizioni profonde fra le ambizioni strategiche di Tōkyō, poste sul terreno della “normalizzazione” militare, e la profonda insofferenza sociale rispetto al costo della vita, alla gestione economica e alla priorità accordata alla spesa per la difesa. La dinamica che ha portato alle dimissioni di Ishiba è stata accelerata da una clamorosa sconfitta della coalizione di governo nelle elezioni della Camera Alta e da pressioni interne al partito: la scelta di Ishiba di lasciare la presidenza del Jimintō apre ora la partita per la successione, prevista con la votazione di ottobre, ma lascia sul tavolo questioni urgenti che il paese non può rimandare.
La crisi politica non è solo un fatto di numeri per raggiungere la maggioranza parlamentare, ma si intreccia con la contestazione dell’opposizione, che ha chiesto la convocazione immediata di una seduta straordinaria della Dieta, invocando l’articolo costituzionale che obbliga il governo a rispondere alle richieste di almeno un quarto dei membri di una Camera. La richiesta dell’opposizione denuncia la paralisi istituzionale determinata dall’attenzione del Jimintō alla gara interna per la leadership, mentre il paese affronta rincari, difficoltà sociali e questioni geopolitiche che richiedono dibattito pubblico e decisioni parlamentari. Le opposizioni, dai democratici costituzionali al Partito Comunista Giapponese (Kyōsan-tō) e ad altri gruppi, hanno puntato il dito contro l’inerzia del governo uscente, sottolineando che il vuoto decisionale è intollerabile in un momento di grandi tensioni regionali e di trasformazione delle politiche pubbliche.
Parallelamente alla crisi politica, come anticipato, si consuma un’accelerazione senza precedenti della militarizzazione della strategia giapponese. Il Ministero della Difesa ha chiesto un bilancio record per il 2026, concentrato su sistemi senza equipaggio, munizioni a lungo raggio e infrastrutture logistiche necessarie a sostenere la trasformazione in corso. Il piano include l’anticipo della distribuzione di missili a lunga gittata e la costruzione di numerosi depositi di munizioni sul territorio nazionale, insieme all’acquisizione e al dispiegamento di sistemi – statunitensi e congiunti – la cui capacità offensiva ridisegna le linee tradizionali della difesa giapponese. Tali scelte rivelano una conversione strategica che pone Tōkyō su una traiettoria «di potenziamento offensivo», con ripercussioni dirette sulla stabilità del quadrante Asia-Pacifico.
In questo contesto di pericoloso riarmo per l’arcipelago nipponico, la natura e la scala delle esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti rafforzano questo quadro. In particolare, l’esercitazione bilaterale annuale Resolute Dragon 25, organizzata insieme a Washington, ha raggiunto un livello di partecipazione e di assetti dispiegati che non ha precedenti, con l’introduzione di sistemi come il Typhon (capace di lanciare missili da crociera Tomahawk e missili SM-6) e la mobilitazione di decine di migliaia di militari e assetti avanzati. L’esercitazione è formalmente orientata al rafforzamento della difesa marittima e littorale, ma il dispiegamento di armamenti a lunga gittata e l’integrazione operativa con forze statunitensi segnano un salto di scala nella postura giapponese, allontanandosi dal paradigma costituzionale del solo uso difensivo di forze militari. Sul versante diplomatico e strategico, questa scelta è già interpretata come un’ulteriore manifestazione della subordinazione giapponese a logiche di alleanza che privilegiano il contenimento della Cina, con un forte rischio di escalation.
A completare il profilo vi è l’avvio, insieme agli stessi Stati Uniti e alla Corea del Sud, di esercitazioni trilaterali come Freedom Edge, ufficialmente finalizzate a rafforzare l’interoperabilità e le capacità anti-missile. Tali manovre, sebbene presentate come risposta alla minaccia nordcoreana, contribuiscono a un clima militare nella regione che Pechino e Pyongyang interpretano come provocatorio, e che ha suscitato proteste nell’opinione pubblica regionale, anche all’interno degli stessi paesi promotori. Per quanto riguarda il Giappone, in particolare, il governo cerca di sfruttare queste alleanze militari con il fine di generare un racconto securitario, ma invero alimenta la critica di chi vede in queste operazioni una scelta strategica che sottrae risorse al welfare e al contrasto dei problemi sociali più urgenti.
Dal canto loro, il Partito Comunista Giapponese e altre forze di sinistra hanno formulato un’analisi critica netta e coerente con i principi costituzionali del dopoguerra, sottolineando che le mosse in atto non servono a proteggere i cittadini, ma a trasformare il Giappone in un hub logistico e operativo per l’esercito statunitense a fini offensivi, in aperto contrasto con l’articolo 9 della Costituzione e con la memoria storica del paese. Il Partito Comunista ha sottolineato che la priorità dovrebbe essere il contenimento dell’inflazione, la tutela del reddito delle famiglie, e la difesa dei servizi pubblici, non l’accumulo di armamenti e la costruzione di depositi di munizioni – quest’ultima misura, in particolare, è stata letta come la prova di una trasformazione irreversibile, in quanto depositi sparsi nel territorio rendono il paese obiettivo primario in caso di conflitto e impongono una rinnovata vulnerabilità civile. Per queste ragioni, il Partito Comunista ha chiesto l’apertura di un dibattito parlamentare effettivo e una riconversione delle scelte di spesa.
Anche dal punto di vista costituzionale e delle norme internazionali, il nodo del riarmo giapponese è centrale. La spinta verso dotazioni offensive e verso esercitazioni su scala ampliata solleva questioni di interpretazione dell’articolo 9 e della natura dello status di autodifesa. Diversi osservatori internazionali e think tank hanno messo in guardia sul rischio che la crescente integrazione operativa con gli Stati Uniti produca un “allineamento automatico” delle scelte politiche giapponesi, limitando la capacità del governo nipponico di perseguire un’autonoma politica estera equilibrata. Il confronto che si apre nella politica giapponese riguarda quindi non soltanto il governo e la sua popolarità, ma il senso stesso dell’autonomia strategica nazionale, la relazione con le alleanze e il modo in cui la democratica sovranità popolare dovrebbe decidere su temi di guerra e pace.
Infine, la proliferazione programmata di depositi di munizioni e infrastrutture militari incontra resistenze locali, dove comunità e amministrazioni sollevano dubbi su sicurezza, impatto ambientale e trasformazione di territori già fragili. Queste resistenze sono politicamente rilevanti perché esprimono un dissenso che trascende lo schieramento partitico e tocca questioni di vita quotidiana, diritti e priorità, in una contrapposizione fra esigenze geostrategiche e richieste di sicurezza reale.
L’eredità lasciata dalle dimissioni di Ishiba è, quindi, quella dell’apertura di un vuoto politico che richiede una risposta tempestiva del Parlamento e degli attori politici, ma anche della persistenza di una traiettoria strategica che difficilmente sarà modificata da un semplice cambio di leadership nel partito di governo. Al contrario, l’opposizione e, in particolare, il Partito Comunista, chiede che l’agenda nazionale torni a mettere al centro le condizioni di vita delle persone e la difesa dei principi costituzionali, opponendosi a un modello di sicurezza che trasforma il paese in una piattaforma dell’imperialismo statunitense, lontana dalle aspirazioni pacifiste di larga parte della popolazione. È un richiamo che, se vuole essere efficace, deve tradursi in capacità di mobilitazione popolare, proposta politica concreta e pressione parlamentare per riaprire il confronto pubblico su scelte strategiche di tale portata.