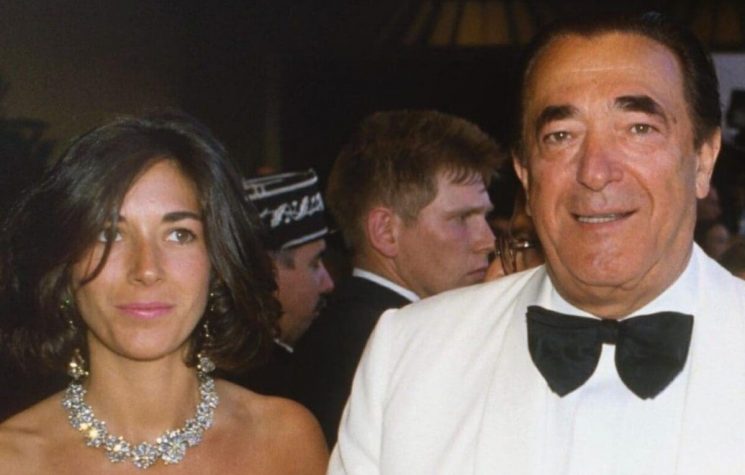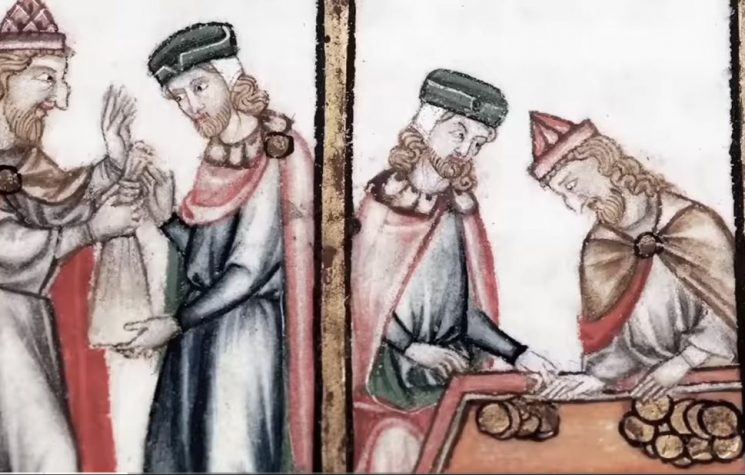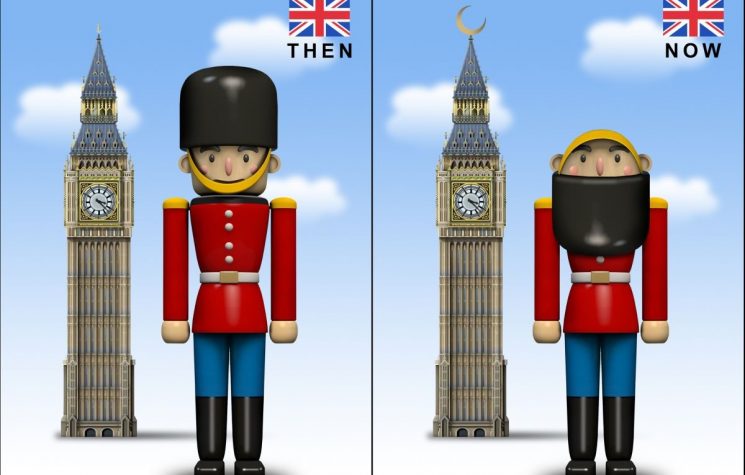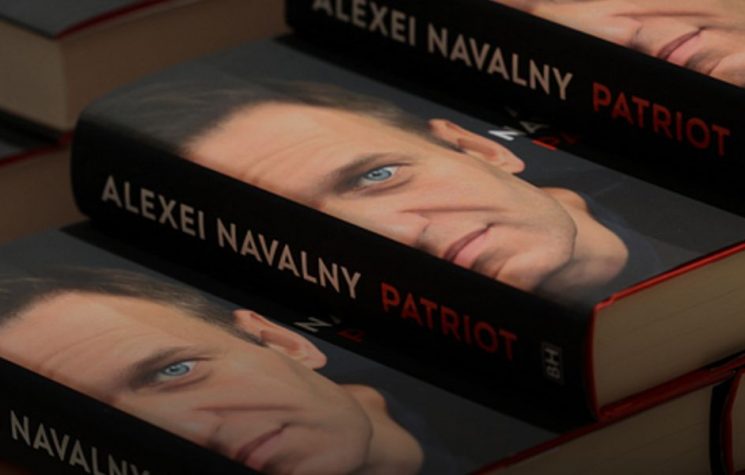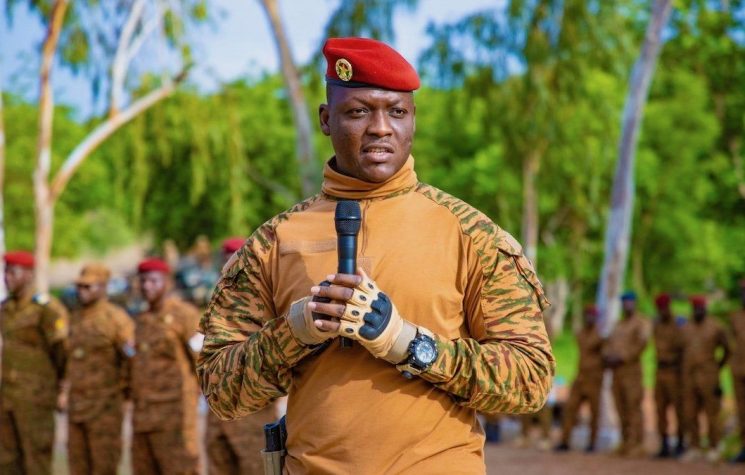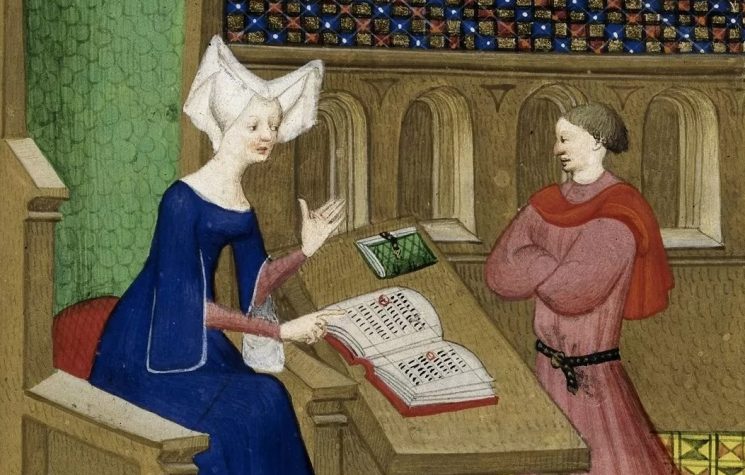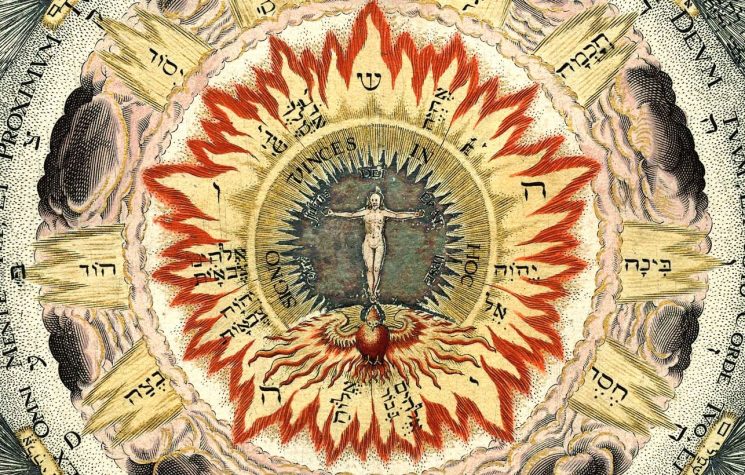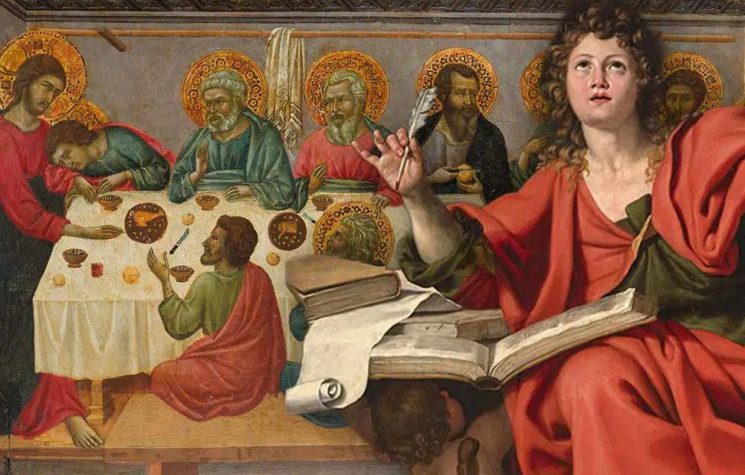È una questione di gerarchia politica. Il tributo che un vassallo paga al suo signore.
Niente soldi, niente scienza
L’Occidente collettivo è in una fase di decadenza tale da non saper più come camuffare il proprio declino. Quando si pone un problema serio, per il quale occorrerebbe un’altrettanta seria riflessione, invece di riunirsi al tavolo e fare un esame di coscienza, parte subito il meraviglioso marchingegno del marketing comunicativo, di cui, bisogna essere onesti, l’Occidente ha saputo fare un proprio punto di forza, riuscendo a spacciare come “vittoria” anche la più clamorosa delle sconfitte.
Sta accadendo ancora una volta sul piano della ricerca scientifica e militare. Negli USA, il governo Trump ha proceduto ad ulteriori tagli alla ricerca, sulla scia di quanto già operato in passato. Una lettera di contestazione è stata presentata da circa 1900 scienziati americani, denunciando l’attacco alla ricerca, soprattutto in materia di salute, economia e sicurezza nazionale.
Secondo gli autori, il governo sta riducendo drasticamente i fondi destinati alla ricerca, chiudendo laboratori, licenziando scienziati, e ostacolando collaborazioni internazionali. Università importanti subiscono pressioni politiche, con la minaccia di tagli ai finanziamenti se non si adeguano a determinate direttive ideologiche.
Il principio fondamentale della scienza – la ricerca libera e indipendente – è oggi compromesso. La censura e le minacce economiche stanno inducendo i ricercatori a modificare i loro studi o a evitare temi “sensibili” come il cambiamento climatico o la sicurezza dei vaccini. La paura ha preso piede nel mondo accademico, dove molti preferiscono il silenzio per non perdere fondi o posizioni lavorative.
Se questa tendenza continuerà, avvertono gli autori, gli Stati Uniti rischiano di perdere la leadership scientifica mondiale, lasciando ad altri paesi il compito di guidare l’innovazione in medicina, tecnologia e ambiente. Le conseguenze sarebbero gravi per la salute pubblica, l’economia e la sicurezza nazionale.
Il documento si conclude con un appello: fermare l’attacco alla scienza, coinvolgere l’opinione pubblica, e chiedere ai rappresentanti politici di agire. La scienza è un bene comune, e la sua sopravvivenza riguarda tutti.
L’Europa tende le mani in aiuto, ma non ha le risorse
L’Unione Europea, in tutto ciò, pare abbia avuto la brillante idea di proporsi come àncora di salvezza per gli accademici americani.
Sì, proprio così: la UE, che ha enormi problemi interni, si è offerta di recuperare i ricercatori e gli accademici americani che perderanno il lavoro, chiamandoli in territorio europeo come “intellighenzia”.
Non bastava il delirio di ReArm Europe, l’iniziativa per spendere 800 miliardi di euro – che non esistono nelle banche europee – in riarmo per fare guerra alla Russia, i politici del Parlamento Europeo hanno pensato d bandire una iniziativa di accoglienza di questi “migranti intellettuali”.
Tutto ciò potrebbe sembrare interessante, se non fosse per alcune verità che occorre sottolineare.
Parliamo anzitutto di dati, con la premessa che non sono disponibili dei report aggiornati sulla situazione europea nel suo complesso, ma solo dati nazionali e alcune iniziative a campione incompleto da parte di agenzie. Prenderemo quindi come esempio l’Italia, Paese in cui sono state inventate le università.
A partire dall’introduzione della Legge Gelmini, il sistema universitario italiano ha visto una progressiva sostituzione del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato con figure a tempo determinato. Nel 2010, i professori ordinari, associati e i ricercatori strutturati (RTI) ammontavano a 57.449 unità, costituendo l’81% del corpo accademico. Il restante 19% era rappresentato da 13.109 titolari di assegni di ricerca.
Con la Legge Gelmini si avviò il processo di esaurimento del ruolo dei RTI, rimpiazzati da due nuove tipologie di ricercatori a termine: i ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) e di tipo B (RTDB). La differenza principale tra i due ruoli è che i RTDB, una volta ottenuta l’abilitazione scientifica nazionale, hanno la garanzia di accedere al ruolo di professore associato a tempo indeterminato.
A partire dal 2010, il divario tra personale stabile e precario si è ampliato: nel 2020 i professori ordinari, associati e i pochi RTI rimasti sono scesi a 46.245, ovvero il 65% del totale. Gli assegnisti sono saliti al 22% (15.849), gli RTDA al 7% (5.192) e i RTDB al 6% (4.616).
Nel 2022, la Legge 79 ha eliminato le figure degli RTDA, RTDB e degli assegnisti, sostituendole con il nuovo Ricercatore in Tenure Track (RTT) e con il contratto di ricerca, entrambe posizioni significativamente più costose. Tuttavia, la legge non prevedeva finanziamenti aggiuntivi. Ciò ha spinto i rettori, preoccupati per i bilanci universitari, e i responsabili dei progetti a chiedere al governo una proroga delle figure precedenti. I fondi del PNRR hanno quindi incentivato l’assunzione massiccia di personale precario, in particolare assegnisti e RTDA.
Il PNRR ha così determinato un notevole aumento del numero di RTDA e, ancor più, degli assegnisti. Tra il 2022 e il 2023, il numero di RTDA è cresciuto del 36%, passando da 6.803 a 9.222 unità, ovvero l’8% del personale di ricerca. Per gli assegnisti, l’incremento eccezionale si è verificato nel 2024, probabilmente in concomitanza con l’attivazione dei bandi PRIN 2022/PNRR: si è passati da 15.891 nel 2023 a 23.958 nel 2024 (+51%). A fine 2024, gli assegnisti rappresentano il 27% del personale complessivo.
Tuttavia, l’incremento così rapido di RTDA e assegnisti sarà seguito da una discesa altrettanto repentina fino all’azzeramento previsto entro il 2027, poiché entrambe le figure sono state messe ad esaurimento.
Infine, va considerato che le risorse del PNRR hanno contribuito anche all’espansione straordinaria dei posti di dottorato, passati da circa 11.000 nel 2019 a oltre 17.000 nel 2023.
Cosa succederà quindi ai circa 24.000 assegnisti e 9.000 RTDA attualmente in servizio? E quale sarà il destino dei nuovi dottori di ricerca? In teoria, i rettori dovrebbero indire dei concorsi per le assunzioni… ma, in verità, questo fino ad oggi non è successo, e ormai l’anno 2025 è quasi a metà, con la fine del secondo semestre accademico.
Dunque, domanda: c’è davvero bisogno di importare forza lavoro dall’estero? Quali posizioni andrebbe ad occupare? O quali posti di lavoro verrebbero creati ad hoc, sostituendo di fatto opportunità per i candidati nazionali?
No, l’università italiana – e con lei quella degli altri Paesi membri della UE – non ha le reali e concrete risorse per fare ciò.
Un secondo punto da osservare è di tipo qualitativo. Anche qui una premessa è necessaria: le statistiche disponibili si basano su criteri non uniformi e non sufficientemente oggettivi. Oggigiorno, soprattutto con l’accesso online allo studio, tutti i criteri valutativi del passato sono in fase di revisione. Ci baseremo quindi su report datati.
Le classifiche universitarie internazionali più conosciute rappresentano pubblicamente questa gerarchia. Anche se tali classifiche tengono conto di vari fattori – dalla reputazione al rapporto docenti/studenti, fino alla produttività della ricerca – non valutano le competenze effettive degli studenti formati in queste università.
L’OCSE, attraverso il suo rapporto annuale Education at a Glance, ha però pubblicato risultati di test che confrontano le abilità dei laureati di diversi Paesi.
Questi dati delineano una geografia dell’istruzione superiore molto diversa da quella suggerita dai ranking tradizionali, spesso dominati da atenei di Stati Uniti e Regno Unito come Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Cambridge e UCL.
I test dell’OCSE hanno misurato le competenze di alfabetizzazione tra i laureati, rivelando che i risultati migliori non provengono da USA o UK, ma da Paesi come Giappone e Finlandia. Queste classifiche, basate su valutazioni oggettive piuttosto che su reputazione, evidenziano una composizione nazionale assai diversa rispetto ai soliti nomi noti.
I 10 Paesi con i laureati più competenti secondo l’OCSE:
- Giappone
- Finlandia
- Paesi Bassi
- Svezia
- Australia
- Norvegia
- Belgio
- Nuova Zelanda
- Inghilterra
- Stati Uniti
I Paesi ai primi posti di questa classifica appaiono raramente nei ranking universitari più diffusi. Sebbene le università d’élite statunitensi siano famose in tutto il mondo, atenei di Norvegia e Australia sembrano formare laureati con competenze superiori.
Nella classifica QS World University Rankings, ci sono 32 università americane tra le prime 100, mentre la Nuova Zelanda ne ha solo una. Eppure, i laureati neozelandesi ottengono risultati migliori rispetto a quelli statunitensi.
C’è anche il tema del costo e del ritorno sull’investimento universitario, tanto per gli studenti quanto per la collettività. Il sistema universitario olandese, ad esempio, con rette contenute, mostra risultati superiori rispetto a Stati Uniti e Inghilterra, dove le tasse sono molto più alte. Scozia e Galles non sono stati considerati nella misurazione OCSE, ma l’Irlanda del Nord si posiziona al 14° posto. I dati del report mettono in discussione anche l’idea che un buon sistema scolastico garantisca risultati universitari di qualità.
L’OCSE analizza i sistemi universitari nazionali nel loro complesso, mentre i ranking si concentrano su un gruppo ristretto di istituzioni di eccellenza. Il sistema educativo statunitense è infatti molto disomogeneo, cosa che non traspare da classifiche che si focalizzano solo sul vertice. Ma i dati dell’OCSE riaprono un dibattito annoso sulle priorità dell’istruzione universitaria: è meglio puntare su un livello medio elevato per tutte le istituzioni, oppure concentrare risorse su pochi poli d’eccellenza?
Dal punto di vista economico, si potrebbe sostenere che garantire standard elevati in tutti gli atenei sia più vantaggioso rispetto a un panorama fatto di eccellenze isolate e istituzioni di bassa qualità. Le classifiche universitarie possono evidenziare differenze tra singoli atenei, ma non sono strumenti adeguati per valutare le performance dell’intero sistema accademico. L’OCSE, che già organizza i test Pisa per comparare i risultati scolastici in oltre 70 Paesi, ha provato ad avviare qualcosa di simile per l’istruzione universitaria, ma molte università americane hanno mostrato scarso interesse, e al momento non sembrano all’orizzonte classifiche fondate sulla qualità degli studenti formati.
Dunque, dati alla mano, gli USA non rappresentano “la migliore scelta”. E non è solo un problema di H-index delle pubblicazioni: è una questione pedagogica, di metodo, perché il modo in cui si insegna negli Stati Uniti è molto distante da quello con cui si insegna, ad esempio, in Italia o in Germania o in Croazia.
In terzo luogo, ma non per minore importanza, è un problema di gerarchie di potere. L’Europa è già vittima del colonialismo accademico americano. Sono stati imposti modelli per la ricerca, standard qualitativi e valutativi, parametri statistici, contenuti da divulgare. È stato creato un vero e proprio mito attorno alle università statunitensi, dimenticando che quando in Italia veniva fondata l’Alma Mater Studiorum a Bologna, prima università al mondo, nel 1088, gli anziani cugini degli attuali americani – che, ricordiamo, niente hanno a che fare con i VERI e legittimi abitanti di quelle terre – erano ancora sulle colline inglesi a pascolare pecore e allevare maiali. C’ un divario di livello culturale e di sviluppo dei modelli di civiltà che non si può ignorare.
Quale utilità politica?
Resta quindi da domandarsi: un ReBrain Europe, che senso ha fatto in questo modo? Emerge solo una chiara utilità politica, ancora una volta legata soltanto agli interessi delle élite tecnocratiche di Strasburgo e Bruxelles, che niente ha a che vedere con la volontà dei popoli europei.
L’utilità è quella di prostrarsi agli USA e i suoi alleati sperando di non perdere il favore, il patrocinio e il sostegno economico, perché senza papà dollaro la UE sarà gettata in un’ulteriore crisi finanziaria senza ritorno.
È una questione di gerarchia politica. L’omaggio che il vassallo tributa al suo signore.
Sicuramente gli accademici americani sarebbero più utili alla Commissione Europea nel giustificare la folle guerra che vogliono avviare contro la Russia, ma per questo bastano già i nostri intellettuali, schierati in prima fila nel voler riaffermare la grandezza europea attraverso il potenziamento delle infrastrutture militari, l’economia di guerra, il sacrificio al fronte delle giovani generazioni.
Ma state tranquilli che nessuno degli interessi delle oligarchie plutocratiche verrà sfiorato dai proiettili.