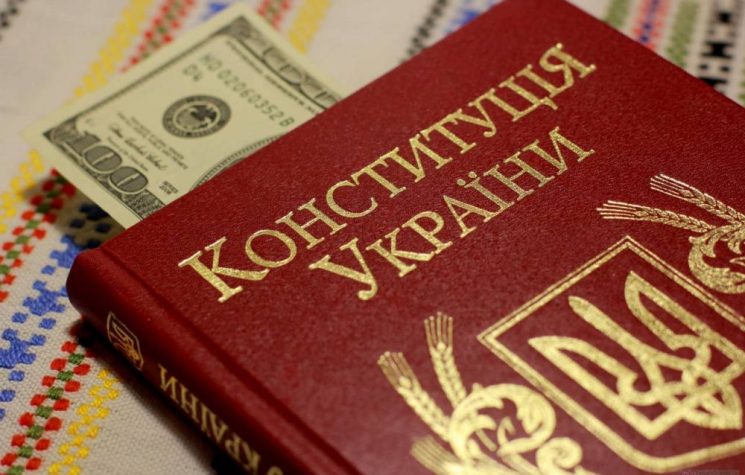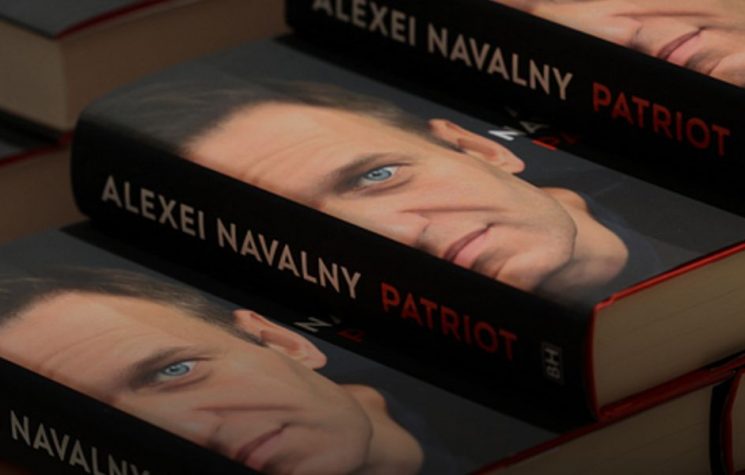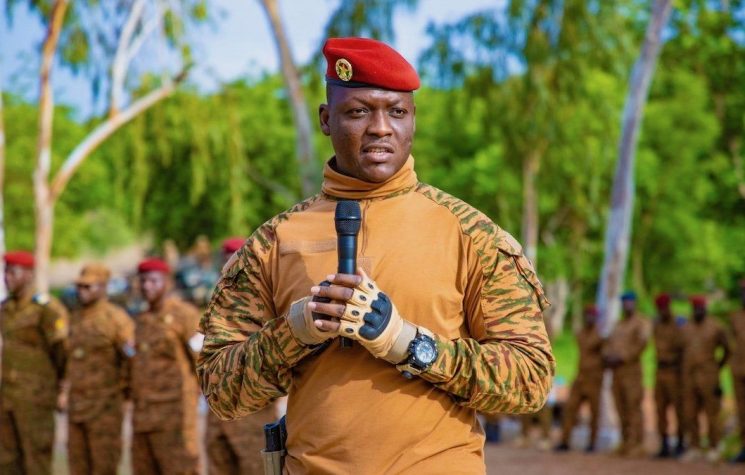Il cambio di rotta nello stile dei conflitti globali ci ha portati già ad una condizione di guerra permanente sotto una nuova veste percettiva.
Le coordinate dei conflitti a bassa intensità
Secondo la dottrina occidentale, un conflitto a bassa intensità è un conflitto armato la cui forma è caratterizzata dall’uso limitato e selettivo della forza militare, ibridata con altri settori e discipline strategiche. Questi tipi di conflitti si collocano fra la guerra e la pace, coinvolgendo una pluralità di attori statali e non statali in scontri prolungati nel tempo, che non raggiungono mai l’intensità di una guerra totale, ma che sono comunque devastanti e duraturi per tutte le parti coinvolte.
Si tratta di una definizione che affonda le sue origini già negli anni ’70, quando il Generale inglese Frank Kitson, esperto di controinsurrezione, studiava le modalità da adottare in risposta a minacce non convenzionali. Il concetto ha poi ha avuto successo negli USA, entrato dal 1986 nella dottrina comune dell’Alleanza dell’Atlantico.
Le caratteristiche principali di questa tipologia di conflitti sono:
- Un uso limitato della forza
- Una durata prolungata
- Il coinvolgimento di attori non statali
- L’ambiguità politica e giuridica
- Il coinvolgimento della popolazione civile
Ciò ha interessanti implicazioni strategiche. Le operazioni di controinsurrezione, ad esempio, prevedono un alto livello di infiltrazione nel tessuto sociale delle aree coinvolte; la guerra psicologica diventa centrale, di pari passo con quella informativa, per predisporre il terreno psicologico e rielaborare gli eventi; la cooperazione civile-militare assume un ruolo fondamentale di integrazione e assistenza.
Tradizionalmente, l’intensità di un conflitto viene misurata mettendo a sistema il livello di violenza e l’uso della forza, l’ampiezza geografica, il coinvolgimento di attori, la durata del conflitto e l’impatto sociale e politico. L’analisi di questi elementi consente di stilare una classificazione.
Il successo nell’adozione dei LIC (Law Intensity Conflict) è dato anche dalla profonda ambiguità che suscita davanti al Diritto Internazionale. C’è infatti un problema: la mancanza di una dichiarazione formale di guerra e la presenza di attori non statali, complicazione l’applicazione delle norme umanitarie. Le Convenzioni di Ginevra perdono terreno. Chiaramente, la protezione dei civili diviene molto complicata, così come il riconoscimento delle responsabilità degli eventi.
I LIC rientrano nella molteplicità delle tipologie di conflitto adottate nel grande calderone della zona grigia, dove questo tipo di problemi non sono nuovi: «in passato, per descrivere il fenomeno, sono stati usati nomi come guerra irregolare, conflitto a bassa intensità, guerra asimmetrica, operazioni militari diverse dalla guerra e piccole guerre. Il Presidente Kennedy parlò della zona grigia durante il suo discorso del 1962 alla classe di laurea di West Point, quando disse: è un tipo diverso di guerra, nuova nella sua intensità, antica nella sua origine, una guerra di guerriglieri, sabotatori, insorti, assassini, una guerra d’imboscata invece che di combattimento; d’infiltrazione invece che di aggressione, alla ricerca della vittoria, distruggendo il nemico esaurendolo invece di impegnarlo» [1].
È curioso che, per i “centri di ricerca” occidentali, la parola “ibrido” venga applicata a qualsiasi attività della Russia, e spesso anche di Cina e Iran. Ad esempio, per gli autori che lavorano per le strutture della NATO, le interazioni di Rosatom con i partner stranieri sono implicitamente tutte delle attività ibride [2].
Quel che si è reso evidente, è che i conflitti a bassa intensità sono diventati una sorta di giustificazione, o forse più una strategia mirata, per mantenere un costante stato di allarme e di conflitto
Lo vediamo, ad esempio, sin dal 1945, quando in Europa gli anglo-americani hanno posto sotto assedio ed occupazione militare, mai terminata, la stragrande maggioranza dei Paesi vinti. Se questa affermazione può sembrare eccessiva, si consideri come, per prima cosa, l’intero continente, con tutto il cosiddetto blocco occidentale, sia finito di lì a poco nella Guerra Fredda, il conflitto ibrido per eccellenza, che ha visto l’alternanza oscillante di varie modulazioni di bassa intensità, senza mai arrivare all’attacco convenzionale vero e proprio. Ancora, si consideri i conflitti in Vietnam o Medio Oriente, emblematici per la loro bassa intensità, che sono stati delle palestre per muovere i passi strategici successivi. Ma si pensi anche allo stato di guerra permanente che anche dal 1989 e 1991 gli USA hanno imposto al mondo intero, provocando l’espansione della zona grigia fino a coprire la maggioranza del pianeta. E, infine, si pensi ai numerosi conflitti di oggi, non da ultimo la Operazione Militare Speciale e ciò che ne consegue nelle relazioni con l’Occidente.
Il LIC è un investimento meno dispendioso e più redditizio, permette una maggiore variazione delle strategie in corso d’opera e può integrare più facilmente professionalità collaterali, persone dal mondo civile e, dunque, distorcere la corretta percezione del conflitto, l’attribuzione delle responsabilità e la risoluzione internazionale.
Il passaggio al problema della densità
Cambiamo parametri. Oggigiorno, conclamato che abbiamo conflitti a bassa intensità sparsi un po’ dovunque ed integrati attraverso numerosi sistemi di guerra ibrida, possiamo considerare la densità di questi conflitti.
Trattandosi di un concetto meno codificato rispetto all’intensità, possiamo provare a darne una definizione come indicatore della equazione dell’intensità e frequenza dei conflitti che si verificano in uno spazio geografico e in un tempo preciso. Possiamo parlare, dunque, di:
- densità spaziale, calcolata sul numero degli eventi violenti distribuiti sul territorio
- densità temporale, considerando il numero di eventi concentrati su un arco di tempo
- densità di fuoco, in ambito militare, nel senso della quantità di risorse impiegate
- densità sociale, come concentrazione della popolazione colpita o coinvolta
Un’ulteriore osservazione che possiamo avanzare, è quella per cui la densità che oggi registriamo è praticamente quella di una saturazione geografica e temporale di specifiche zone: Europa e Medioriente in primis, ma anche Africa, Sudamerica ed Asia orientale. Esattamente le zone in cui troviamo operazioni psicologiche, guerra informazionale, piccoli conflitti armati mantenuti in essere, gruppi terroristici o criminali che operano. Guarda caso – sarà forse una coincidenza? – tutte quelle zone che interessano molto all’asse anglo-americana.
Il risultato è quindi quello di una bassa intensità con una ampia densità. Laddove ci sono conflitti, sono fievoli, ma densissimi, non viene lasciato spazio ad altro e il coinvolgimento deve essere massimale, se non fisicamente almeno psicologicamente.
Dal coordinamento di più Low Intensity Conflict con High Density Conflict nasce una strategia della guerra permanente e della tensione che è ben nota, in realtà, da almeno 70 anni. Un mondo in guerra è un mondo che frutta più soldi di un mondo in pace.
Il problema di una guerra ad alta densità è che non lascia spazi di manovra per la fuoriscita dal conflitto, perché la chiave di smascheramento è per lo più percettiva: non essendoci una intensità sufficientemente alta, e dunque non facendo percepire che si è di fatto in guerra, anche la densità viene sottovalutata.
La soglia di attivazione cognitiva viene sempre tenuta a distanza, operando sotto il livello di rottura. La massa non deve percepire l’effettività del conflitto.
Avviene una gestione controllata della dissonanza, razionalizzando costantemente le incoerenze, presentandole come “errori dei nemici”, “frasi di transizione”, “sacrifici necessari”, adottando una narrativa flessibile che possa assorbire le critiche e ammorbidire le tensioni cognitive senza cedere sul nucleo ideologico.
Bisogna poi procedere ad una saturazione mediatica, controllando bene i frame comunicativi, riempiendo l’infosfera (quinto dominio di guerra) con messaggi costanti, anche contraddittori, purché impediscano una visione autonoma e chiara della realtà. Distrarre, confondere e moltiplicare versioni, questo è il procedimento usuale.
Tutto ciò deve avvenire sotto una costante sorveglianza del dissenso, operando un isolamento pubblico di chi mette in dubbio la narrativa e inibendo la presa di parola, così da mantenere l’illusione del consenso e, quindi, costruire e legare la narrativa dominante ad identità emotive, capri espiatori, eventi simbolici, in modo che in caso di dissenso il costo psicologico del dubbio diventi altissimo.
Sempre devono essere presenti delle valvole di sfogo, simulando un pluralismo apparente in modo da non far cambiare in verità nulla, intercettando precocemente le idee alternative e disinnescando o neutralizzando gli avversari e i nemici, così da prevenire la maturazione di anticorpo cognitivi.
I LIC-HDC stanno ridefinendo le mappe con cui leggiamo il territorio esistenziale delle nostre civiltà, aprendoci a rischiosissimi scenari di conflitti interminabile e malapena percettibili.
[1] US Special Operations Command, The Gray Zone, White Paper, 9 settembre 2015, p. 19.
[2] Hybrid Atoms: Rosatom in Europe and Nuclear Energy in Belarus, 11 marzo, 2021.