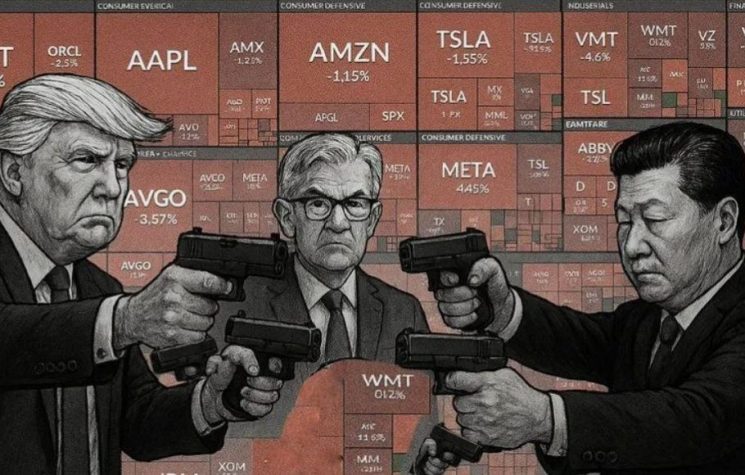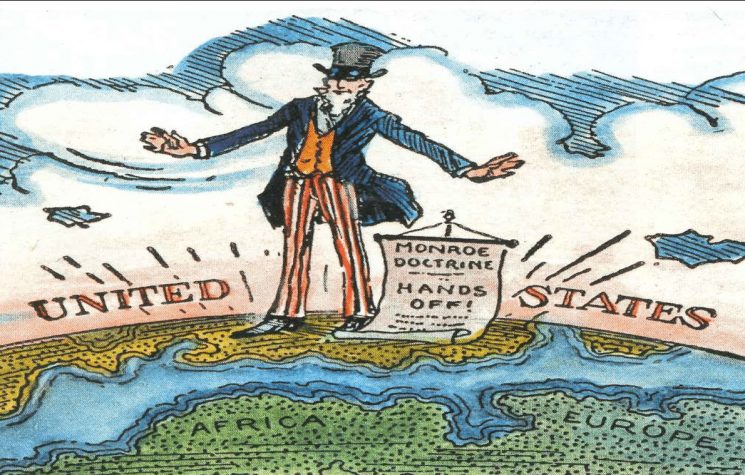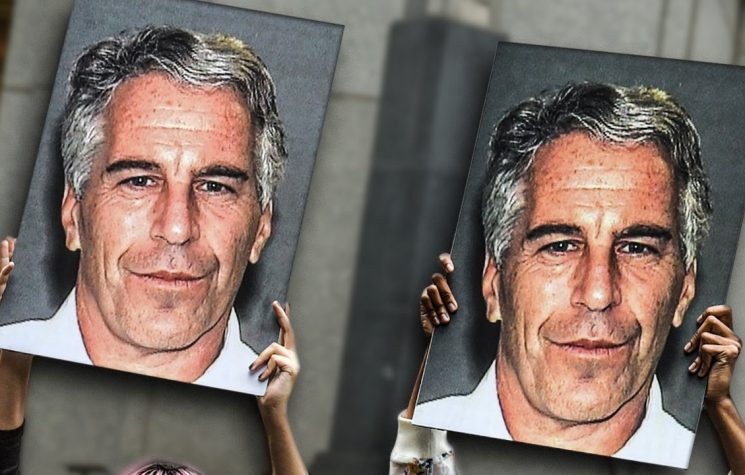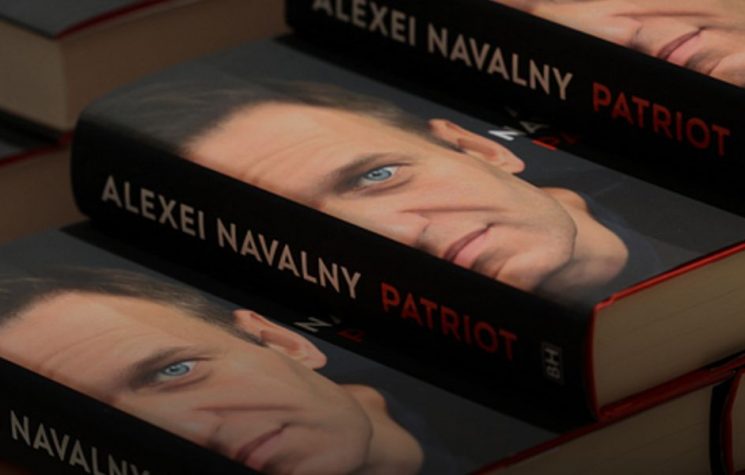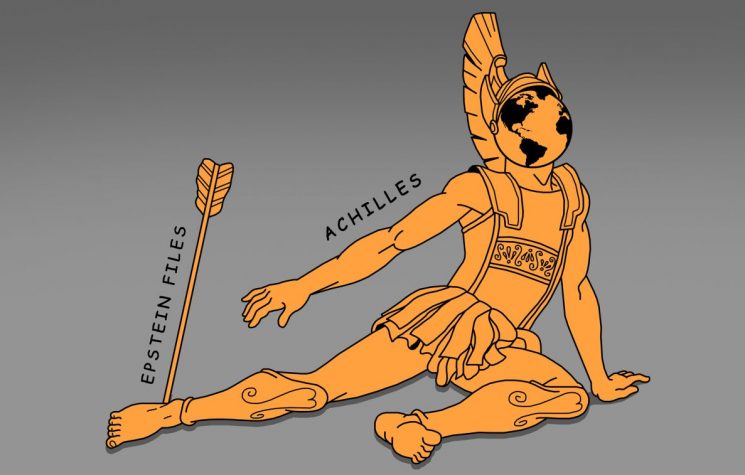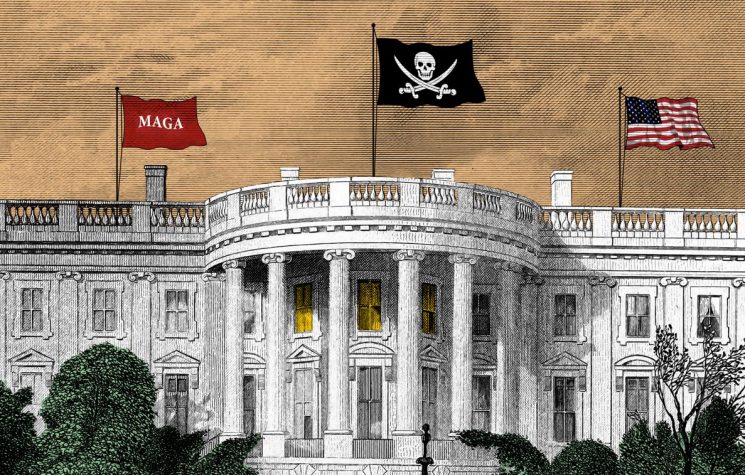In un momento in cui il mondo è in subbuglio, oscillante tra negoziati di pace e minacce di guerra, c’è una questione che deve essere affrontata con cura: il concetto di neutralità.
Una definizione preliminare
In un momento in cui il mondo si muove con forza, oscillando fra trattative di pace e minacce di guerra, c’è un argomento che richiede di essere trattato con attenzione: il concetto di neutralità.
La neutralità, nel contesto del diritto internazionale e delle relazioni internazionali, è un concetto giuridico e politico fondamentale che si riferisce alla condizione di uno Stato o di un soggetto internazionale che si astiene dal partecipare a un conflitto armato tra altri Stati belligeranti. Essa implica un atteggiamento di non schieramento e di imparzialità rispetto alle parti in conflitto, con l’obiettivo di mantenere una posizione di estraneità nei confronti della guerra o delle controversie armate in cui non si è direttamente coinvolti.
Dal punto di vista strettamente giuridico, la neutralità è definita come uno status riconosciuto agli Stati che vogliono rimanere estranei alle ostilità e che si traduce in una serie di diritti e obblighi reciproci sia nei loro confronti sia verso gli Stati belligeranti. Si basa su norme di diritto internazionale consuetudinario e pattizio, che regolano l’atteggiamento che uno Stato neutrale deve osservare per non compromettere la propria posizione e per assicurare che la sua neutralità sia rispettata dagli altri attori internazionali.
Storicamente, la neutralità era spesso considerata una condizione priva di rigorose norme legali, lasciata all’arbitrio degli Stati belligeranti, per poi evolversi fino a diventare un istituto giuridico codificato, con un chiaro quadro di regole sancito da trattati internazionali, in particolare dalle Convenzioni dell’Aia del 1907 che spesso vediamo citare. Questi strumenti stabiliscono che lo Stato neutrale deve astenersi da atti di ostilità, dal fornire truppe o aiuti militari a un belligerante, dal mettere a disposizione il proprio territorio per operazioni militari, e deve garantire l’inviolabilità del proprio territorio anche con l’uso della forza, se necessario.
La neutralità, chiaramente, non riguarda solo l’assenza di partecipazione diretta alle ostilità, ma anche una serie di obblighi più ampi. Tra questi vi è il dovere di non favorire una delle parti in conflitto, per esempio evitando di fornire supporti militari o logistici, ma anche evitando canali di comunicazione e altre forme di assistenza indiretta che possano influenzare l’esito del conflitto. La violazione di tali doveri può determinare la perdita dello status di neutralità e l’entrata dello Stato in conflitto come belligerante.
In ambito politico – e qui cominciamo ad entrare nella parte interessante – la neutralità può essere adottata come una scelta strategica e una linea di politica estera per preservare la sovranità, la pace interna e l’integrità territoriale di uno Stato. Alcuni Paesi, come ad esempio la Svizzera, hanno adottato la neutralità permanente come strumento di politica estera che contribuisce al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. In questi casi, la neutralità diventa uno status stabile e riconosciuto, che implica un impegno a non prendere parte a guerre e a mantenere una politica estera di non allineamento.
L’istituto della neutralità si è ulteriormente complicato con l’avvento della Carta delle Nazioni Unite, che ha sancito il divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, salvo casi specifici autorizzati dal Consiglio di Sicurezza. Siffatta evoluzione ha prodotto interpretazioni diverse circa la compatibilità tra neutralità e obblighi derivanti dalla cooperazione internazionale nel mantenimento della pace e della sicurezza globale. Per esempio, in situazioni in cui il Consiglio di Sicurezza impone sanzioni o interventi contro Stati aggressori, la neutralità può essere vista come un vincolo che limita la possibilità di adesione agli obblighi collettivi di difesa e di mantenimento della pace. Ciò ha portato a un dibattito sul ruolo e i limiti della neutralità nel diritto internazionale contemporaneo, che si estende, oggigiorno, nel contesto dei conflitti di nuova generazione.
Per questo motivo dobbiamo comprendere bene di cosa stiamo parlando e di come si sta evolvendo il concetto.
Non sempre le cose funzionano come previsto
Vediamola sul piano strategico militare. L’appartenenza a un’alleanza militare può impedire a uno Stato di dichiararsi neutrale principalmente perché la neutralità, nel diritto internazionale, presuppone un’astensione totale e imparziale da qualsiasi conflitto armato, inclusa l’assenza di obblighi di assistenza reciproca nei confronti di altre nazioni. Le alleanze militari, invece, implicano proprio il contrario: un impegno formale e vincolante di sostegno reciproco in caso di aggressione a uno o più membri. “Formale” e “vincolante” sono due parole chiave, giuridicamente valevoli.
Più specificamente, gli elementi che spiegano perché l’appartenenza a un’alleanza impedisce la neutralità sono:
- Obbligo di assistenza reciproca: molte alleanze militari, come la NATO, includono clausole che richiedono ai membri di difendersi a vicenda in caso di attacco armato (ad esempio, l’articolo 5 del Trattato NATO). Questo dovere di difesa collettiva implica automaticamente che uno Stato membro non può astenersi dal partecipare al conflitto a fianco degli altri membri, contraddicendo così il principio di neutralità che impone astensione da ogni ostilità e partecipazione.
- Impossibilità di mantenere l’imparzialità: la neutralità richiede una posizione imparziale, ossia di non favorire né sostenere una delle parti in conflitto. L’appartenenza a un’alleanza già definisce uno schieramento politico-militare e un chiaro orientamento verso uno o più Stati o blocchi, impedendo quindi qualsiasi forma di neutralità o non allineamento.
- Divieto di uso del proprio territorio ai fini bellici: uno Stato neutrale deve impedire che il proprio territorio sia utilizzato da belligeranti per scopi militari. Al contrario, in seno a un’alleanza ogni Stato può concedere il proprio territorio per basi militari o operazioni congiunte, contravvenendo alla neutralità.
- Impegno politico e militare: le alleanze implicano non solo rapporti militari concreti ma anche vincoli politici e ideologici. Tale impegno globale è incompatibile con la posizione di non intervento che caratterizza la neutralità.
- Riconoscimento internazionale dello status: per mantenere la neutralità, uno Stato deve dichiararla e ottenere il riconoscimento internazionale di tale status. Se è membro di un’alleanza militare con obblighi di difesa reciproca, tale status viene meno agli occhi degli altri Stati, che lo considereranno parte attiva di un blocco geopolitico.
Siffatti aspetti giuridici e politici spiegano perché Stati membri di alleanze come la NATO non possono essere considerati neutrali. Di fatto, l’adesione a un’alleanza militare e la neutralità sono due condizioni incompatibili e mutualmente esclusive nel diritto internazionale moderno.
È anche importante distinguere la neutralità dalla posizione di non allineamento, che è più una scelta politica di non aderire a blocchi militari ma che non garantisce il rispetto delle regole esplicite della neutralità in conflitto armato. Solo pochi Stati, come Svizzera e Austria, sono riconosciuti come neutrali permanenti e non fanno parte di alleanze militari vincolanti.
Prendiamo in esempio la NATO: gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Alleanza confliggono con lo status di neutralità permanente, soprattutto a causa della natura vincolante e attiva degli impegni di difesa collettiva previsti dall’Alleanza Atlantica. Tutti ci ricordiamo il famoso Articolo 5, secondo il quale un attacco armato contro uno o più membri dell’Alleanza è considerato un attacco contro tutti, imponendo un obbligo automatico di assistenza reciproca militare. Questo dovere esclude la possibilità per uno Stato membro di mantenere una posizione neutrale, poiché sarebbe tenuto a intervenire in conflitti animati da terzi anche se volesse restare neutrale. In linea di principio, quindi, nessun Paese membro della NATO può veramente essere neutrale, vi è una contraddizione evidente. La neutralità permanente, infatti, implica una totale astensione da qualsiasi partecipazione a conflitti armati e un atteggiamento di imparzialità verso tutte le parti in causa. L’appartenenza alla NATO, al contrario, implica l’assunzione di un ruolo schierato, obbligando lo Stato a sostenere politicamente e militarmente il blocco alleato.
L’Alleanza richiede non solo azioni militari, ma anche coordinamento politico che impone decisioni condivise e impegni reciproci, come ad esempio la messa a disposizione, da parte degli Stati membri, del proprio territorio per fare le esercitazioni e di un certo numero di forze armate da coinvolgere. Questa cooperazione vincolante è in antitesi con la neutralità permanente, che si fonda sull’assenza di vincoli militari e sull’autonomia decisionale totale rispetto agli eventi bellici.
L’adesione alla NATO e la neutralità permanente si escludono a vicenda poiché i principi fondamentali di ciascuna posizione sono incompatibili.
Il contesto ibrido
È dunque evidente che ci dobbiamo porre delle domande riguardo come oggi funzioni questa neutralità, allorché abbiamo nuove tipologia di conflitti, quelli ibridi, e nuove modalità operative.
Sul piano della teoria giuridica, c’è un vuoto normativo: i contesti ibridi vengono studiati giuridicamente da poco, perché, per la loro fluidità e atipicità, non rispettano i criteri definitori con cui siamo abituati a produrre norme per organizzare la vita sociale. Nella teoria militare, invece, lo sviluppo è ben più avanzato, perché le guerre ibride hanno già raggiunto una vasta elaborazione teorica e tecnica. Bisogna quindi trovare una liaison fra i due mondi, e questa può essere fornita se leggiamo la cornice sotto gli occhi della dimensione politica.
Facciamo un esempio per comprendere meglio: la Finlandia. Per anni, il Paese è stato annoverato nella lista dei “neutrali” (formalmente non è più neutrale dal 4 aprile 2023, quando è entrata nella NATO). Il Paese, quando era ancora neutrale, ha rispettato i criteri formali della neutralità… ma ha infranto, ipso facto, la neutralità, allorché ha partecipato alla esercitazioni sulla cyber security tenute dalla NATO e dalla UE. Helsinki, quindi, è passata da essere un alleato che condivide informazioni, capacità tecniche e strategia con i partner europei e della NATO, a divenire un vero e proprio attore, con una sua posizione, decidendo da quel parte stare. Dopo anni di “finlandizzazione”, cioè di strategia di allineamento prudente ma nominalmente neutrale, la Finlandia è ora un baluardo nella cyberdifesa occidentale contro la Russia.
Ora, sappiamo che le guerre ibride si caratterizzano per la combinazione di strumenti convenzionali e non convenzionali, includendo cyberattacchi, disinformazione, operazioni economiche, pressioni diplomatiche ed infiltrazione di agenti non statali, allo scopo di destabilizzare Paesi avversari senza un dichiarato stato di guerra. In questo scenario, le tradizionali regole della neutralità appaiono sempre meno applicabili e frequentemente contraddittorie.
La neutralità d’altronde presuppone il riconoscimento e il rispetto da parte degli Stati belligeranti dei confini giuridici e territoriali dei Paesi neutrali, nonché la non interferenza con la loro sovranità; ma le guerre ibride si sviluppano proprio nell’ambiguità e nella zona grigia tra pace e guerra aperta, sfruttando vettori d’offesa difficili da attribuire in modo certo e spesso senza violare formalmente la territorialità o la sovranità del Paese neutrale. Questo fenomeno genera una contraddizione strutturale: lo Stato neutrale, pur non coinvolto in maniera tradizionale, può diventare bersaglio di operazioni ibride o esso stesso partecipare ad operazioni ibride.
Ecco perché è opportuno parlare di neutralità relativa, un nuovo concetto da introdurre nelle scienze che studiano la neutralità.
La neutralità relativa consiste nel posizionamento che un Paese o entità compie in riferimento ad uno specifico dominio. Ciò implica che gli altri domini non necessariamente prevedano la neutralità reale. Ancora, la neutralità può essere adottata secondo le definizione formali e normative circostanziate, ma non come principio pure e assoluto, e dunque è possibile eluderla nella zona grigia senza incorrere in una contraddizione sanzionatoria.
Ecco, quindi, il nostro tempo: Paesi che sono, sulla carta, neutrali, ma che di fatto sono coinvolti in varie forme di conflitti e operazioni che però esulano dalle normative e dalla dottrina presente.