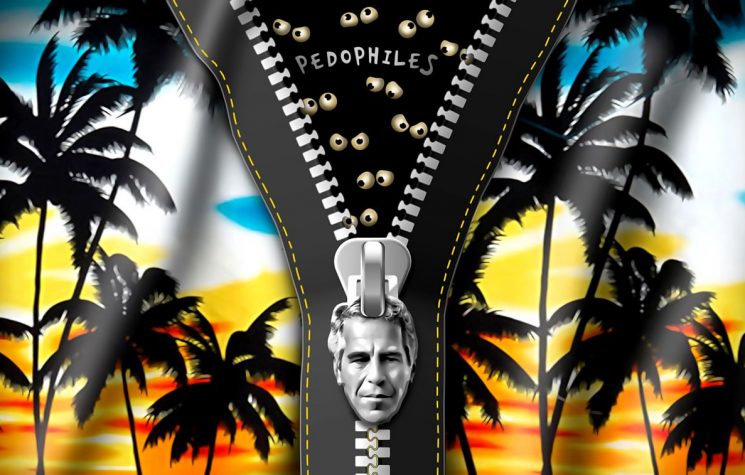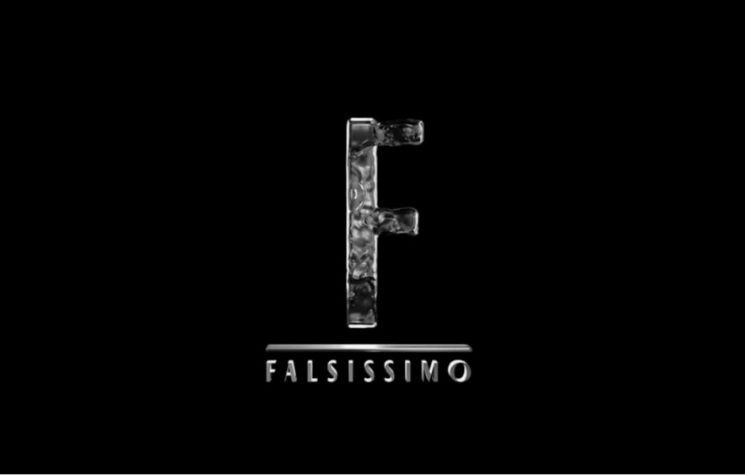C’è vento di guerra in Europa. Sembra di essere negli anni Venti dello scorso secolo. In Italia il problema è anche costituzionale.
La questione costituzionale
La questione della difesa europea, regolata dal metodo intergovernativo secondo il Trattato di Lisbona del 2007 e non da quello comunitario, rappresenta un confine critico: oltrepassarlo significherebbe sancire la fine degli Stati nazionali a favore di una struttura federale sempre più consolidata. Le pressioni del Presidente della Commissione europea vanno proprio in questa direzione, e il conflitto in Ucraina, unito al progressivo disimpegno degli Stati Uniti, si rivela un’opportunità per accelerare questo “processo di federalizzazione”.
La proposta di un piano da 800 miliardi di euro, prelevati dai fondi strategici, per potenziare le capacità militari dell’Unione Europea non è il fine ultimo, bensì il mezzo per integrare la difesa nel metodo comunitario, naturalmente previa modifica del Trattato. Dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989 e la riunificazione della Germania nel 1990, si pensava che il termine “riarmo” fosse ormai superato.
Il percorso di integrazione europea si è sviluppato anche grazie a un’interpretazione discutibile dell’articolo 11 della Costituzione italiana, sostenuta da una giurisprudenza costituzionale altrettanto poco convincente. In origine, questa norma non era pensata per legittimare in via permanente “limitazioni di sovranità”, ma per permettere restrizioni mirate da approvare caso per caso. In ogni caso, tali limitazioni non avrebbero dovuto portare nel tempo a uno smantellamento progressivo dell’ordinamento costituzionale stesso.
Venendo al merito della proposta, ci si deve domandare quale sia l’obiettivo reale di questo riarmo. Da un lato, l’Unione Europea si lamenta di essere esclusa dai negoziati tra USA e Russia per una pace stabile in Ucraina (ma cosa si aspettava dopo aver sostenuto la politica sanzionatoria e bellicista dell’amministrazione Biden?); dall’altro, adotta una strategia che contraddice qualsiasi intento pacificatore.
Contro chi si sta armando l’UE? Contro Vladimir Putin? Si crede davvero che l’obiettivo del Presidente russo sia la conquista dell’Europa? Storicamente, quando gli Stati destinano una quota crescente del loro bilancio alle spese militari, aumenta la probabilità di coinvolgimento in conflitti. Questo perché tendono a fare affidamento sulle armi e sulla forza per risolvere le questioni di sicurezza, trascurando soluzioni diplomatiche e pacifiche.
Cambia il mondo
Ciò che è accaduto durante la conferenza stampa di Trump e Zelensky a Washington evidenzia due aspetti: uno già noto e l’altro una novità significativa.
Che Zelensky fosse un comico prestato alla politica, con problemi di dipendenza e un comportamento discutibile, come affermato anche da Elon Musk, oltre a essere un governante responsabile di scelte devastanti per il suo stesso popolo, era cosa risaputa.
L’elemento nuovo riguarda invece la natura dell’imperialismo statunitense: non più fondato sul controllo politico-territoriale, ma orientato al dominio economico-commerciale. Questo tipo di influenza rientra nella normale dinamica geopolitica e può essere contrastato.
Ciò che però cambia radicalmente il quadro generale è il declino della NATO, ormai svuotata di significato. La Federazione Russa ha ottenuto un successo strategico nonostante il massiccio sostegno militare ed economico fornito all’Ucraina da oltre 40 Stati, un paese già noto per la sua corruzione.
Eppure l’aspetto ancora più rilevante è il tramonto dell’Unione Europea, se mai sia esistita come vera entità sovrana. Dopo le umiliazioni subite dal rappresentante americano Vance alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, è arrivato il colpo definitivo con la posizione assunta da Donald Trump.
Di conseguenza, le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, sempre più delegittimate, si trovano prive di reale capacità decisionale. I leader filo-bellicisti dell’UE cercano di riorganizzarsi in incontri ristretti, come quelli di Macron a Parigi o di Starmer a Londra, ma si tratta di tentativi disperati.
Il punto centrale della crisi europea è il crescente divario tra la volontà popolare e le politiche imposte dall’alto, anche con metodi repressivi, come dimostrato dall’attentato contro il premier slovacco Fico. Le tensioni crescono in Romania, Ungheria, Germania, Francia e Regno Unito, ma i media, asserviti ai poteri forti, evitano di parlarne.
Questo cambiamento avrà ripercussioni anche all’interno dei singoli Stati membri dell’UE. In Italia, figure come Mario Draghi, Guido Crosetto e Antonio Tajani si troveranno in ruoli ben diversi da quelli istituzionali, mentre la premier Giorgia Meloni, che aveva puntato sulla vittoria dell’Ucraina contro la Russia, dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue scelte.
Ci si chiede se chi ha guidato l’Italia in questa direzione proverà almeno un senso di colpa per aver impoverito economicamente e moralmente il Paese. Il caso di Gianfranco Fini, che riappare con dichiarazioni surreali sul patriottismo ucraino, è solo l’ultimo esempio di un quadro politico in piena confusione.
La transizione sarà complessa e richiederà sacrifici, ma potrà portare alla riconquista della sovranità nazionale, intesa come indipendenza politica ed economica, dignità individuale e collettiva, e tutela degli interessi del Paese.
Dopo una lunga storia segnata da tradimenti, è giunto il momento di dire basta.